LUCIANO CANFORA - ARISTOFANE CONTRO SOCRATE
27.8k views18425 WordsCopy TextShare

Circolo Metafisico
🔔 Iscriviti e visita il Canale per non perderti nessun video: https://www.youtube.com/channel/UCPti...
Video Transcript:
Abbiamo dato un tema, [Musica], che potrebbe apparire alquanto estraneo alla tematica complessiva dell'intellettuale e del potere. Ma mi giustifico subito: io ho voluto indicare nel titolo "Aristofane contro [Musica] Socrate" un elemento emblematico e direi addirittura unico, nei limiti di quello che c'è, visto dell'impegno intellettuale, piuttosto polemico, pungente e premeditato di un esponente di spicco della cultura teatrale della drammaturgia ateniese, in pieno, anzi tardo, V secolo, ma nel pieno della guerra con Sparta, nei confronti di una figura anomala come Socrate, peraltro bagliore della commedia, così come poi più tardi lo sarà Platone. Allora entriamo in
medias res con una questione preliminare che mi sta a cuore. Per molti di voi sarà materia molto nota; la dirò in breve, ma mi pare indispensabile replicarla: il teatro è l'altra assemblea. Questo credo sia giusto ribadirlo sempre. Teatro di Atene, naturalmente, noi pensiamo sempre alle due grandi scadenze: le Lennee e le Dionisie. Pensiamo al ruolo pubblico, alla funzione pubblica del rituale connesso, in particolare, alle Dionisie di aprile, mentre le Lennee sono a gennaio, fine gennaio, ogni anno. Cioè entriamo preliminarmente in questa macchina del teatro di Stato. La parola "Stato" è modernistica; però la usiamo ugualmente.
Basti pensare che nel momento in cui si avvia la messa in scena alle Dionisie, il pubblico è costituito anche, in parte non piccola, da alleati non ateniesi, cittadini che vengono dalle città alleate, più o meno entusiasti del predominio ateniese. Dico "più o meno entusiasti" perché su questo terreno c'è sempre un equivoco. No, siamo tutti influenzati dalle poche fonti che ce ne parlano. Quindi, per Tuili, dell'impero e tirannide, rapidamente gli alleati diventano schiavi. Per Aristofane, Babilonesi: gli alleati sono gli schiavi alla macina, tanto che una reazione politica ci fu contro di lui proprio per quella commedia
del 426. Dell'anno 426, però, ogni comunità alleata è divisa. È divisa tra una parte, magari minoritaria numericamente, che è in piena sintonia con la città dominante, no? Atene ha un impero ideologico, potremmo dire, fondato sulla presenza, spesso, di cleri atenesi nelle varie località. Però soprattutto l'omologazione dei regimi politici: quindi le democrazie assembleari vengono imposte più o meno brutalmente nelle varie città alleate. Se c'è uno scontro in cui quel regime viene messo in crisi o abbattuto, Atene interviene militarmente, lo ripristina e quindi c'è una minoranza che la pensa come gli Atenesi. Chi andava al teatro, alle
grandi Dionisie, degli alleati non lo sappiamo, naturalmente. Però c'è una parte consistente che ci va. Quindi le Dionisie sono un'occasione imperiale. Prima che incomincino le rappresentazioni, c'è tutta una cerimonia: sfilano gli orfani dei caduti in guerra e ogni anno c'è qualche occasione del genere, durante la guerra con Sparta, ancora di più. Però non necessariamente soltanto in quei terribili 27 anni. E la cerimonia prosegue col fatto che gli orfani hanno addosso un po' di un addobbo militare, siedono in prima fila accanto alle autorità, viene celebrata la città con un discorso epitafio affidato a un grande politico.
La partecipazione è enorme. All'assemblea ci va una minoranza politicizzata che decide per tutti, ma al teatro, no. Al teatro c'è una presenza di gran lunga superiore, quindi è l'altra assemblea. Questo è un punto fermo al quale guardare sempre quando si parla del teatro ateniese, che è un unicum. Quando, nei primi anni di [Musica], Bimar parte il teatro politico, no? Erin, Piscator, Brecht, eccetera, ha grandi meriti, agitatori. Però è un fatto pur sempre minoritario, intellettuale, con una presenza proletaria molto selezionata, molto minoritaria anch'essa. Cioè, tutta un'altra cosa si chiama e si vuol chiamare teatro politico. Piscator
ha scritto in proposito; anche i testi teorici ha spiegato che il teatro non deve semplicemente avere un significato politico, ma deve parlare di politica, no? Pato è estremista da questo punto di vista, ma questo è un modo molto indiretto. Lo dice Brecht in uno dei suoi scritti sul teatro: rifare al modello Aristofane, che è l'unico che conosciamo bene, pur sapendo la differenza sostanziale. C'è, nell'antica Atene prima della guerra civile del 404, un fenomeno della città, pervasivo, di tutta la città, ufficialmente messo in essere e anche diretto da un, diciamo, un filtro del quale bisogna sempre
tener conto. Aristofane si diverte, nelle Rane, a un certo punto a dire che ci sono migliaia di giovanotti ad Atene che non fanno che scrivere drammi e lui li disprezza. Ha torto? Ha ragione? Però pochissimi hanno poi il coro, cioè l'autorizzazione a imbastire, allestire, con un ricco signore che paga. Uno dei doveri dei ricchi è di pagare la coregia: il teatro, oltre che pagare per le feste, pagare per le navi. Insomma, i ricchi vengono spremuti, diceva Arthur Rosenberg, notevole studioso di epoca Vaim, Mariana. Come la mucca, no? Non viene espropriata la ricchezza, ma viene utilizzata
socialmente, con la macchina micidiale dei tribunali popolari, che sono affidati non a dei giuristi. Va bene, che poi anche il CSM ogni tanto ci dà dei pensieri, quindi non dobbiamo esaltare poi la specializzazione. Ma lì sono dei cittadini che si offrono di fare giudici. Perché? Perché c'è un pagamento di due oboli; anzi, Cleone l'ha alzato a tre oboli, che è una cifra minima, è meno del salario di un operaio specializzato. No, dei conti delle rette; sappiamo quanto veniva pagato un salariato per una giornata di lavoro. Aveva di più che non questi benedetti tre oboli del
servizio come giudice, e però è molto desiderato. Allora, immaginiamoci questi giudici popolari che non hanno una preparazione giuridica, sono sicuramente molto attenti se un ricco la vuole far franca, per esempio spiegare che non deve pagare per le navi, per la gerarchia. Insomma, è un regime pesante, no? Diceva Benjamin Const, praticamente Pu, sociale, cioè il potere sociale addosso al singolo individuo. Quindi una inesistente libertà. Allora, il filtro però c'è e consiste in questo: sono gli arconti, due arconti in particolare, che decidono a chi dare il coro, su che base? Sulla base... Di non lo sappiamo con
precisione. C'è tutta una teoria molto fragile secondo cui esibivano gli aspiranti le 'odai', cioè le parti liriche [Musica]. Forse è un passo di Platone dei 'Nomoi' che ha suggerito questo, ma in realtà lì non si dice questo esattamente. Però, insomma, una teoria, una teoria secondo me più convincente, credo che l'abbia sostenuta un nostro collega studioso molto bravo che si chiama Albio Cesare Cassio, ma anche altri prima di lui. Un canovaccio, una trama, un titolo? No, perché anche il titolo allude al contenuto. Non sempre, noi per esempio possiamo notare che Aristofane non ha mai... abbiamo i
titoli delle sue commedie, ma ne abbiamo solo undici. Non ha mai usato come titolo il nome di un politico, di un capo popolare. Ha fatto a pezzi Cleone in varie commedie, però non c'è nessuna commedia sua intitolata 'Cleone'. Invece, altri, come Eupoli, Platone, comico eccetera, hanno messo Cleofonte, Iperbolo, quindi hanno messo il nome del bersaglio, evidentemente perché questo piaceva. E i racconti, diciamo, oppure schematicamente, sono l'unica carica tra quelle sorteggiate non retribuita, mentre i giudici popolari sono sorteggiati, ma sono pagati, sia pure in quel modo così umile e modesto. Sono gente abbastanza benestante, gente ricca
in genere. Gli arconti, fra l'altro, sono sorteggiati, e cioè attraverso, sulla base di una lista di gente che si è offerta, magari... questo lo sappiamo per un'epoca un po' risalente, ma non abbiamo nessun motivo di ritenere che non accadesse più tardi. Quindi ragioniamo con lo schematismo dei sociologi, un pochino. Gli arconti non sono degli idolatri del potere popolare; in generale sanno poi di contare poco. Dal punto di vista politico, contano gli strateghi, che sono eletti, e lì c'è una lotta durissima per essere eletti. Allora gli arconti danno i cori sulla base di una trama eccetera,
selezionano un ricco signore che paga per l'allestimento. Ecco, questo è un quadro dentro il quale collochiamo la drammaturgia che ci è arrivata, che si schiera, si schiera in due modi. Ovviamente, la tragedia in un modo e la commedia in un modo molto più esplicito. Diretto, perché, dicevo, nella tragedia abbiamo tantissimi titoli di tragedie, ma pochissime tragedie, delle tante che sono state prodotte in almeno un secolo di attività. Però dai titoli qualcosa si capisce. Per esempio, il fatto che argomenti storico-politici non ci sono praticamente, tranne i 'Persiani' di Eschilo, che hanno come corego un signore che
si chiamava Pericle, che non era l'ultimo, diciamo, politicamente parlando; era ancora giovane in quel momento, ma già ben messo dal punto di vista dei suoi propositi politici, ed è una celebrazione della vittoria sui Persiani. Il dramma di Eschilo non è fine a se stesso. Se solo si pensa, mi riferisco alla politicità della tragedia, se solo si pensa al fatto che giustificare l'impero attraverso la vittoria sui Persiani è l'argomento principe. Quando Erodoto sta per raccontare l'invasione di Serse, la seconda invasione persiana, dice: "Qui mi fermo, faccio una riflessione; non piacerà ai Greci, ma lo dirò lo
stesso: senza il sacrificio di Atene, che ha bruciato la città, sarebbero arrivati fino nel Peloponneso". Quindi, dobbiamo agli ateniesi la nostra libertà. "Arrangiatevi, se sudditi alleati; l'impero è così pesante". È un ragionamento che ha una sua logica; è interessante che lo faccia Erodoto quasi alla vigilia della guerra o quando la guerra era appena cominciata. Non sappiamo le date precise di Erodoto, ma quanto questo argomento fosse malvisto lo si cava, per esempio, dall'inizio del dialogo che Tucidide ha inventato tra gli ateniesi e i Meli. I Meli, gli abitanti di Melo, vengono invasi da una flotta ateniese
che pretende assoggettamento, rientro nella lega. Lo si direbbe, però non li portano davanti all'assemblea; i generali ateniesi li portano, diciamo, a quattro occhi a conversare soltanto con i notabili. E allora Tucidide fa dire ai delegati degli strateghi ateniesi: "Visto che non siamo davanti al popolo, non diremo la solita storia che, avendo vinto i Persiani, abbiamo diritto all'impero"; m una forma estremamente dissacrante dell'argomento principe a difesa, a sostegno e a giustificazione dell'impero. Allora i Persiani hanno un chiaro significato. Potremmo aggiungere di più: un uomo come Eschilo, che ha combattuto a Maratona, era un giovanotto in età
militare nel 490. Maratona, Omero più vecchio dei tre che noi ben conosciamo, si esprime in un anno cruciale con l'Orestea, un dramma che parla delle vicende torbide della famiglia di Agamennone, questi Atridi. Ritorna la moglie, ma non proprio così. Sostanzialmente, questo è l'avvenimento terribile del primo dei tre drammi della trilogia: il figlio vendica il padre uccidendo la madre, perseguitato dalle Erinnee. La terza, il terzo dramma, sfocia davanti al Tribunale dell'Areopago ad Atene, che deve giudicare questo reato di sangue terribile per il quale, appunto, Oreste non ha pace. Atena risolve, con suo voto, il processo con
la soluzione di Oreste. E questo va bene, rientra nel mito; agli ateniesi è ben noto, insomma, ovviamente. Ma dice una cosa fondamentale: d'ora in avanti questo tribunale si occupa di reati di sangue. Questo dice sostanzialmente e lo dice nel momento in cui Efialte, capo popolare che viene poi ammazzato, non si sa bene da chi, subito dopo la sua riforma, toglie all'Areopago i poteri abusivi di cui si era impadronito dopo le guerre persiane e lo limita ai soli reati di sangue. Dice della Costituzione degli Ateniesi, opuscolo aristotelico, talmente bene si era comportato all'Areopago durante le guerre,
la seconda persiana soprattutto. Ne faceva parte anche Temistocle, che poi è l'ideatore della strategia vincente, da assumere dei poteri che non erano propri: gli epiteta, dei poteri aggiuntivi. E Fialte, approfittando del momento in cui migliaia di opliti ateniesi, che si sarebbero magari opposti a questa riforma ultrademocratica, sono impegnati nel Peloponneso a sostenere Sparta contro la rivolta degli schiavi, la terza guerra messianica cosiddetta, e quei poteri li passa ai Tribunali. Popolari e alla boulet trènica e all'assemblea popolare, naturalmente, quindi è la più forte delle riforme in senso democratico della città di Atene nel corso del secolo
che va dalla cacciata dei tiranni al colpo di stato del 411. No, un secolo di democrazia. Al centro c'è questo episodio: Eschilo lo esalta, con l'orchestra. Sono un po' schematico nel dire questo, ma credo di non dire una sciocchezza. Colpisce il fatto che Fial venga ucciso e poi varie teorie su chi l'ha ucciso; Eschilo se ne va, se ne va in Sicilia e muore in Sicilia dove ha grande successo, la grande potenza occidentale, Siracusa. No, quindi è successo qualcosa di molto pesante per cui quest'uomo, legato a Eleusi, quindi a un culto popolarissimo, sentitissimo, molto più
della religione etnica, decide di rompere con Atene e di andarsene. Talmente traumatica come decisione che non può non avere un rapporto con quella sua presa di posizione. Tragedia può dunque parlare di politica senza parlare di politica. Un esempio che si può fare, lo faccio. Talvolta è Euripide; Euripide, un'altra generazione, è nato alquanto dopo Eschilo, è legato a un ambiente, diciamo, di critica della democrazia. No, nelle Rane lo fa trattar malissimo dal dio del teatro, quando per esempio dice il dio del teatro che deve giudicare la contesa infernale, che non ha senso sprecare il tempo chiacchierando
con Socrate. Quindi Euripide è colui che spreca il suo tempo chiacchierando con Socrate. Ma poi sappiamo questo in maniera... Aristofane può scherzare come gli pare. Euripide e Socrate sono i suoi bersagli, ma abbiamo notizie molto più serie, diciamo così, di un meccanismo molto interessante, e cioè Crizia, nipote remoto del grande Crizia, famiglia di Solone, che era a Codro, zio di Platone, figlio di Cesc. Cesc era uno dei 400, 411, quindi un golpista egli stesso implicato già allora, poi leader della seconda e ben più efficace oligarchia, quella del 404. Crizia e Euripide si scambiano i drammi.
No, perché ci sono fonti; Sesto Empirico, per esempio, cita un brano del Sisifo, dramma satiresco, e dice Euripide o Crizia. Che vuol dire "si scambiano i drammi"? Vuol dire due cose: intanto che molti di questi filo-oligarchi o direttamente oligarchi fanno anche il mestiere di drammaturghi, tragediografi. No, Antifonte, capo dei 400, è anche tragediografo. Teognide, molto meno noto, omonimo del poeta, anch'esso profondamente antidemocratico. Teognide, un altro Teognide, è uno dei 30. No, lo sappiamo perché Seno fonte ci dà l'elenco dei 30 ed è autore di tragedie, come dire, la scena tragica può servire a dire delle
cose che non si possono dire in assemblea. In assemblea uno non si può presentare e dire "ma la democrazia è un regime discutibile, scadente, fondato sul numero, sull'incompiuta radice", il meccanismo assembleare democratico. Sono impensabili, impronunciabili davanti all'assemblea per ovvie ragioni; se addirittura si trasformano in proposte, sono immediatamente colpite da un'accusa per illegalità. Invece le critiche a vende, come dice un famoso articolo di Max Troy, a vende le obiezioni contro la democrazia, così come contro la fede negli dei, così come contro l'umiliante condizione degli schiavi o delle donne, cioè tutto questo mettere in discussione i fondamenti
della città si può fare dalla scena tragica. E che non ha fatto che questo. Perciò è giusto ricordare questo troppo lungo preambolo che nelle Supplici, quasi certamente messe in scena nel 424, poco dopo una tremenda sconfitta, battaglia di Delione, cui Atene ha perso almeno 1000 opliti, battaglia rovinosa dal punto di vista militare, mette in scena una tragedia, le Supplici, in cui lo scontro dialettico tra Teseo, re fondatore della democrazia, un po' uno ateniese, e l'araldo tebano, che viene lì a contestare la possibile decisione che Atene, e Teseo in particolare, può prendere di consentire la sepoltura
dei sette che hanno aggredito Tebe, difesa da Creonte. Nello scontro dialettico tra questi due personaggi Teseo fa una lezione di educazione civica usando alcuni degli argomenti principali dell'epitaffio pericleo, parafrasato da Tucidide, che noi possiamo immaginare essere dei topoi nella autoesaltazione tipica degli epitafi. E però l'araldo obietta con durezza sui due caposaldi, il predominio dei demagoghi che ingannano, che hanno un eloquio seduttivo ma non veridico, e decisioni prese da masse non competenti, prive di gnome perché costituite da persone non selezionate con nessun criterio. No, questi due argomenti, tipici del pensiero antidemocratico di tutti i tempi, non
soltanto di Atene, molto presenti nella tradizione socratica e poi platonica, eccetera, vengono sciorinati davanti al pubblico da un personaggio che certamente non fa una bella figura nell'economia del dramma, per cui alla fine Teseo ottiene, sconfigge questi tebani che vogliono impedire... però il pubblico ascolta delle parole, delle critiche che rimangono senza risposta. Teseo non confuta le obiezioni dell'araldo e quindi, come dire, restano nelle orecchie degli ascoltatori degli argomenti che in altra sede non sarebbero mai proferiti, neanche lontanamente immaginabili. E per giunta dinanzi a masse molto più ampie che non gli scarsi 5000 - e mai veramente
5000 - su 30.000 cittadini che vanno all'assemblea. Questo per quel che riguarda la tragedia. Non si può dire in maniera complessiva che il caso di Eschilo sia abbastanza anomalo. Eh, è Sofocle, del quale si parla sempre come bonom, no, per colpa di Aristofane, tutto sommato, perché dice "Ecòlos, no, un bravo ragazzo di 80 anni". Però Sofocle è stato nominato prytano dopo la sconfitta in Sicilia, tremenda del 413; è uno dei 10 prytani, che sono una magistratura straordinaria che di fatto espropria molti poteri della boulet. La boulet, l'assemblea, scelta a sorte, 500 persone, 50 per ogni
tribù. È come diceva Gaetano De Sanctis, il Palladio della democrazia, no? E infatti è la prima struttura che i 400 abrogano e la sostituiscono con una boulet di tipo soloniano, di 400 persone scelte per cooptazione, non più a sorteggio. Quindi il prytano non è l'unico; magari sarebbe stato anche messo lì dentro per il suo... Prestigio, però, ha accettato di rientrare. I dieci "probu" svolgono quel compito di preparazione della materia da portare in assemblea che spetterebbe alla Boule; perciò si chiamano "Pro buoi", cioè fanno prima il lavoro che sarebbe competenza di D-bulet. Noi lo sappiamo, per
caso, questo fatto di Sofocle. Sofocle è sempre stato protetto dalla buona sorte. No, fino nelle Muse c'è un frammento famoso: viene citato "felice da vivo, felice da morto." No, c'è questa esaltazione; non so se fosse scherzosa. Un frammento, il contesto com'era? Perché forse era anche un atto di omaggio, però per caso invece sappiamo di questo suo impegno nell'affossare il regime democratico. Un po' forte come espressione, ma vedrete che non è totalmente sbagliata, perché Aristotele, nella "Retorica", nel terzo libro della "Retorica", porta un esempio di argomentazione che lo interessa dal punto di vista retorico, in cui
si viene via via costretti ad ammettere di aver fatto qualcosa e lo si giustifica con lo stato di necessità, diciamo così. Allora dice: quando Sofocle fu portato da Pisandro, che era uno dei capi dei Quattro, a giustificare la sua adesione al colpo di stato, al governo dei Quattrocento, fu oggetto di un interrogatorio da parte di Pisandro. No, Pisandro era chiaramente sotto processo, chiamato di correo, si dice, no, coinvolto. Un così grande personaggio, quindi, gli ha detto: "Ma tu hai accettato di fare questo?" "Sì." "Sapevi che questo era la premessa per il regime dei Quattrocento?" "Sì."
"Allora hai accettato il regime dei Quattrocento?" Risposta: "Ma non c'era di meglio in quel momento." Aristotele interessa questo tipo di argomentazione, ma nel frattempo ci dà una notizia non da poco. Ovviamente, molti moderni hanno detto: "Ma no, è un altro Sofocle, non vi permettete," eccetera. È inutile. A parte che Sofocle poi ha ricoperto la carica di stratego insieme a Pericle al tempo della guerra contro Samo, quindi è complice anche di una specie di genocidio dei poveri Sami della guerra del 441-440. Poi è stato uno degli Elenotami, cioè ministro delle finanze. Quindi, insomma, è uno che
ha fatto volentieri politica, quindi non stupisce affatto che, avendo questo piedistallo alle spalle, a un certo punto, in quel momento terribile, dopo che si è appreso che Atene ha perso tutta la flotta e migliaia di combattenti in Sicilia, si sia ricorso a tipi come lui che mettano un po' di ordine in questa città. Tu ci di del tutto contento del fatto che si nominano dei "pruli"? La città funziona, eccetera. E quindi, quando lo dico così, perché di solito poco abbiamo sentito tragedie, soltanto... ma insomma, l’Antigone, Creonte, Antigone, le leggi non scritte, sembra quasi un teorico
del diritto naturale. No, buona attraverso la persona di Antigone, il diritto naturale: una parola, un termine modernistico. Però, indubbiamente, ha un antenato in questa teorizzazione che ci siano leggi superiori alle leggi scritte. No, lo dice anche Pericle nell'epitafio. No, noi ateniesi non solo rispettiamo le leggi, ma anche quelle leggi che non sono scritte, ma la cui violazione porta vergogna universalmente riconosciuta a "tunen omum menen." Però questa esaltazione della legge non scritta è ambigua. È ambigua perché, sembra banale dirlo, la legge scritta è la principale conquista democratica; quando finalmente la legge viene scritta, non è più
compito di caste sacerdotali che, in modo insondabile, dicono: "La legge dice questo." C'è una norma. Quindi, questa vicenda dello scontro Antigone e Creonte ha due facce: nel pieno della vitalità di un'Atene sempre sotto l'incubo di un colpo di mano oligarchico, squalificare la legge scritta e il nome di quello che invece gli dei suggeriscono non è una manovra particolarmente in sintonia col regime politico. La commedia è, come è stato scritto da un bravo interprete, un po' dimenticato, che si chiama "Cua", scritto "Kat qua", che non era un professore, era uno studioso libero. La commedia è all'opposizione.
Lui ha fatto anche un tentativo sociologico di tentare di sistemare, diciamo, sul piano della scala sociale i commediografi di cui abbiamo notizia. No, mentre per i tragediografi qualcosa sappiamo. No, abbiamo nominato personaggi tipo Antifonte, Teide, Sofocle, Eschilo; sappiamo molto di persone nella scala sociale, molto in alto. I comici fanno questo lavoro: intanto per il premio, lottare per il premio significa anche lottare per un salario, no, per un compenso. Aristofane nell' "Eclessiazusae" lo dice chiaramente, no, quando dice: "I giudici si ricordano sempre della commedia che hanno ascoltato per ultimo; cercate di ricordarvi anche di quelle messe
in scena prima, se no, siamo penalizzati dal punto di vista del premio." Non è giusto fare delle generalizzazioni, però quei personaggi di cui sappiamo si collocano bene nella posizione, come dice apertamente "qua", ma anche altri, lo stesso Cratete, che pure c'era molto con "qua", un sorboniano contro un libero pensatore, quindi giustamente lo maltratta. Vabbè, sono clienti, hanno la configurazione del cliente della realtà romana: clienti di qualcuno. C'è una pagina famosissima dell'opuscolo che noi leggiamo tra le opere di Senofonte, ma che non è sua, per testa "Ten Pol teias", sono le prime parole del testo che
vengono assunte come titolo nel secondo capitolo, paragrafo 18. C'è tutta una tirata curiosa sulla commedia e da parare. Per brevità, il soggetto di tutto l'opuscolo è il demo e il demo non è il popolo, questo non per fare dei paradossi, nel senso che la parola, nel suo uso concreto politico, si riferisce a varie realtà. Un demo è un comune dell'Attica. No, la Carne è un demo, Tireo è un demo. Vabbè, è anche la comunità nel suo insieme, "edox te bou cit demo", decisione della boulè e del popolo. Quelli che vanno all'assemblea sono il popolo di
Atene; non importa se sono una minoranza numerica: erano lì, gli altri non c'erano, hanno deciso quello che ha deciso e vale per tutti. E il demo è anche la parola con cui si... Definisce la democrazia politica Catalin con "Demon": abbattere il demo, cioè la democrazia politica. Ma è anche la base sociale di essa, cioè il demo. Sono quelli che sono pronti a battersi per difendere quel sistema politico; sono pochi, però ci sono. Quando sono perseguitati, cacciati, come è successo nel '404, riescono a recuperare un minimo di coesione e tentano la riscossa. Quindi, non è un
partito nel senso moderno, però è un gruppo che si riconosce socialmente. Riesce a individuare dei leader sui quali... Poi c'è tutta un'ostilità preconcetta della cultura che giunge fino a noi: filosofica, storiografica, drammaturgica. E quello è il demo. Il popolo è tutto. Una pagina che ho voluto valorizzare da ultimo, e che non voglio ora leggere per intero, ma semplicemente riassumere, è delle famose lezioni di letteratura greca di Nietzsche, 1875. L'ultimo, penultimo corso che lui ha fatto prima di dimettersi dalla cattedra aveva come tema il pubblico dei generi letterari: Das publicum, che è una prospettiva molto moderna,
prospettiva alla Auerbach notevole. Quando affronta il tema, il pubblico della commedia, parla ovviamente per lo più della commedia di Aristofane. Dice: "Aristofane da giovane", le prime commedie, "è l'organo del partito oligarchico". È giovanissimo, no? Le prime cose le ha fatte a 20 anni praticamente, ma parla come se fosse vecchissimo. Il suo demo, cioè la parte democratica, diciamo, non è il suo pubblico, è il suo bersaglio, perché ha davanti tutti gli altri, non soltanto quella… Anza politicizzata. Infatti, la tattica argomentativa che Aristofane mette in essere, di commedia in commedia, con grande abilità, è di [musica] adulare
gli altri. Saggissimo! Questa apostrofe, saggissimo! Sofi, i contadini, perché i contadini o piccoli proprietari - o anche non tanto piccoli - sono la vittima della politica imperialistica guerrafondaia della democrazia ateniese e della sua base sociale; e di coloro che sono direttamente interessati, no? A cominciare dai marinai del Pireo e da tutti quelli che lavorano intorno agli arsenali, quelli che fanno muovere le navi. E quell'autore che ho ricordato prima, no? Che parla della commedia e di cui riprenderemo presto il contenuto della sua diagnosi, dice: "Il regime che vige ad Atene non mi piace. Non lo elogio,
perché è in mano a quelli che fanno muovere le navi", cioè a tutto quel mondo che gravita intorno alla flotta, che è però lo strumento dell'impero e che è, diciamo, intrinsecamente imperialista, perché ha bisogno di avere sudditi che pagano un foros, di avere schiavi che si prendono come prigionieri di guerra, di avere oro, se si può, nelle operazioni di conquista di altre comunità che vengono spogliate, anche punitivi. No, la guerra costringe contadini di varia statura e ricchezza a vedere devastare le proprie terre dalle invasioni stagionali spartane e a vivere dentro la città, dentro le mura,
a far niente, guardando impotenti la rovina delle proprie terre. Quindi odiano la guerra, odiano la democrazia politica. E Aristofane li mette in scena: già dice "opoli degli Acarnesi", nei "Cavalieri". Addirittura il coro sono i Cavalieri, cioè il ceto sociale più ostile alla democrazia: quelli che sono protagonisti di tutti i colpi di Stato che via via si sono verificati ad Atene. E una tesi non sbagliata è che i 24 coreuti fossero dei Cavalieri veri e propri. No, i Cavalieri sono un corpo di élite: 1200, 1000, ma poi diventano 200. Armano le proprie spese, il cavallo lo
allevano, eh, si atteggiano a spartani, hanno le chiome lunghissime come gli Spartani; però sono anche un ceto sociale. No, hanno un certo reddito e quindi stanno sotto i pentacosiomedimni, che sono i più ricchi di tutto. Quindi i Cavalieri sono proprio la quinta essenza dell'anti-democrazia. Senofonte dice una volta nelle "Elleniche" che quando Sparta, ormai vincitrice, chiese un aiuto per la guerra contro la Persia sotto la guida di Agesilao, gli ateniesi mandarono 300 Cavalieri, sperando che crepasse proprio, togliersi di piedi, combattere in Persia e speriamo che non tornino. Questo è l'atteggiamento di una città in quel momento
controllata da Sparta. Eh, quindi lui è chiarissimo nella presa di posizione e bersaglia una serie di personaggi con un'estrema abilità. Cleone fa le spese più di tutti. Quel testo che ho ricordato, del che viene chiamato stupidamente "l'anonimo", ma ha un titolo e un nome un po' strano, insignificante: "Comodino de auos lein ton demon". "Hē osin" non consentono, non permettono ai Gesi di mettere sulla scena comica e quindi prendere in giro, no, burlare, comodi, bersagliare attraverso la commedia, ovvero parlar male, "cacos legin" "tol demon", del popolo. "Hē osin" non lo permettono. Questo è l'incipit di quella
parte del testo che vi sto evocando. Cicerone, che conosce questo testo, direi Certamente nel "De Repubblica", dice che era "lege concessa", cioè quel "non consentono" lui l'ha tradotto in una norma di legge. Quindi è stabilito per legge che non si può attaccare il demo, ma dei personaggi in vista. Poi aggiunge Cicerone: "A Roma, questo è impensabile. Vi immaginate Plauto che attacca il Scipione? Inconcepi...bile!" Invece lì qualunque comico può attaccare, perciò tranquillamente il massimo cittadino, eccetera eccetera. Cicerone è molto seccato di questo. Non ci stupisce, anche perché Roma non fu mai una democrazia, ma una repubblica
aristocratica molto ben costruita. Però ci dà una testimonianza interessante di aver letto questo testo e di averlo interpretato a suo modo. Modi sono meno bravi di Cicerone, quindi cambiano 'Hē osin'. Mi dà fastidio tutte correzioni inutili; in realtà il testo è chiarissimo. Ma è molto interessante quello che viene dopo, e cioè che il demo come tale non deve essere bersagliato. Apro una piccola parentesi: fiumi di inchiostro sono stati versati per dire. Dunque, questo opuscolo è scritto prima del '424, perché il '424 è la data in cui vengono messi in scena "I Cavalieri". Nel "Cavalieri", il
vecchio rimbambito è demo; sembra un ragionamento inoppugnabile. No, in realtà non regge, ma soprattutto prescinde dal fatto che... Alla fine della commedia, Demo ringiovanisce, si libera dei suoi amici che sono i demagoghi e quindi, lungi dall'essere un cacos legin, e addirittura un'esaltazione, no, del… quindi, insomma, questa datazione alta non sa di niente. Invece seguo il testo dicendo: «Invia privatamente». Vanno dai comici a chiedere di attaccare determinate persone, no? Onomasti comode, si diceva. No! Attaccare con nome e cognome, onomasti ID de CH leusin. Anzi, addirittura lo impongono privatamente. Vuol dire due cose: vuol dire un rapporto
privato col commediografo, che non ci stupisce in realtà, eh. Il commediografo non stava sotto una campana di vetro, era in costante rapporto col pubblico, prima, durante e dopo la concezione, stesura, messa in scena della sua opera. Quindi la scena che viene fuori è di un contatto al personam molto interessante. Però vuol dire anche un'altra cosa: l'attacco complessivo. No, ma privatamente i singoli personaggi, mh. E poi aggiunge anche sempre questo prezioso testo che tra i commodum, tra quelli che vengono bersagliati, c'è anche gente del popolo, se emerge troppo, se stanno un po' troppo in posizione eminente.
Poi prosegue l'autore dicendo: «Ma io la democrazia al Demo non gliela rimprovero perché fa il suo mestiere, ama i suoi simili, detesta le persone per bene. Io detesto invece i cresto che non sono di nascita popolare e che invece accettano di fare politica en democrat po in una città retta da un regime democratico. Salto invece coloro che non sono di nascita elevata, sono tu Demi, ma si comportano come cresoli». Si è discusso a lungo a chi si riferisca; è inutile adesso fare il catalogo delle ipotesi. Quello che ci interessa è il quadro descritto in questa
pagina, molto interessante, che mette in rilievo un fenomeno che, se vogliamo, poi è diventato anche oggetto di erudizione. No, i manuali di commume o di epoca ellenistica erano degli strumenti in cui si veniva a catalogare, a cercare di identificare, quando non erano indicati per nome, tantissimi bersagli personali delle tantissime commedie giunte ad Alessandria, alla biblioteca di Alessandria, e messe in ordine dai vari Cimaco compagni. Quella pagina descrive un fenomeno che ci riguarda da vicino: l'attacco a Socrate, l'attacco a Euripide, l'attacco a Cleone. Sono fenomeni fra loro diversi; li ritroviamo tutti nella commedia di Aristofane. Eh,
sarebbe ingenuo immaginarsi, da parte di un commediografo di un livello notevole come lui, un comportamento schematico a senso unico. No, una sorta di, per usare l'espressione un po' estremistica di Nietzsche, organo del partito. Mh, organ del partai. È interessante, però non è del tutto soddisfacente, perché, semmai, lui è stato capace di non farsi mai o quasi mai identificare come organo di partito. Che abbia preso ventenne l'iniziativa con i babilonesi, la commedia del 426 babilonio, di mettere sott'accusa il rapporto oppressivo della città tiranna verso gli alleati non ci sorprende; non si può neanche dire che sia
un atto di coraggio, perché non la presenta lui col suo nome. No, c'è un altro che fa il regista nelle nuvole, che la commedia tutta contro Socrate. C'è la solita parabasi, no, in cui il corifeo fa un discorso in tetrametro, quindi è quasi prosa, e parla da solo, no? Gli attori si allontanano e il coro appare. Si toglie il mantello, il corifeo fa una tirata, spesso di argomento politico o politico personale. Nel le nuvole, per esempio, si parte dal caso suo personale: «Mi avete bocciato la commedia quando la presentava la prima volta, siete dei caltroni».
No, torneremo su questa strana parabasi però. Lì dentro c'è una dichiarazione autobiografica: «Quando cominciai il lavoro di comediografo ero una ragazza partenos, metafora e non potevo partorire». Cioè non aveva, diciamo, la veste giuridica e quindi altri presero il mio frutto. Cioè vuol dire che lui scrive una commedia e però poi c'è un regista che figura anche come autore. In realtà, no, noi su questo punto abbiamo le idee confuse, perché disponiamo di qualcosa che somiglia alle didascalie aristoteliche. Aristotele fece accogliere i vincitori delle commedie e delle tragedie, no? Le didascalie, il titolo a rigore non era
didascalia, forse era appunto quello dei vincitori; ha attinto a documenti ufficiali. Sì, no, non entriamo in questa discussione. Sta di fatto che quando leggiamo in queste brevi notizie molto interessanti che si trovano spesso al termine di quelle prose grammaticali che chiamiamo Yup Tesis, no, argomenti dei drammi, quando leggiamo: vinse Tizio, non so, vinse per esempio Aristofane di Callistrato, attraverso Callistrato, per opera di Callistrato. Callistrato, in realtà, era un comico anche lui, che si è prestato a fare da regista nella lista dei vincitori. Sicuramente c'era il nome Callistrato; non diceva il nome Aristofane, però l'erudizione era
in grado di stabilire chi fosse il vero autore. Ma, come diceva Carlo Ferdinando Russo, che ha studiato moltissimo la commedia ad Atene, tutti sapevano chi era il vero autore. Le didascalie aristoteliche noi non ce l'abbiamo in forma autentica diretta, abbiamo il consom mean, hanno fatti grammatici. Quindi stiamo attenti a dire che noi leggiamo le didascalie; la formula «vinse Tizio attraverso Caio» è probabilmente la resa in termini, diciamo, parafrastici del documento ufficiale e della realtà effettuale. Mh, quindi babilonesi, Aristofane, sì, tutti sapevano che era lui, ma non è stato portato in tribunale; c'è stata una denuncia
depositata davanti alla boulè da parte di Cleone con l'argomento: «Hai offeso la città in presenza degli stranieri», perché erano le Dionisie, quindi c'erano gli stranieri, no? Gli alleati, e questo è un reato. Cioè non è che dice: «Hai offeso l'impero», «Hai offeso la città in presenza di…». Dian che la deposizione dell'accusa sia stata contro Aristofane è sicuro, perché Aristofane poi protesta in tutti i modi, esulta perché questa cosa è fallita negli Acarnesi, cioè l'anno dopo. Però probabilmente anche Callistrato ha passato i suoi guai all'inizio, perché era quello che figurava come autore. Ora, nel caso dei
babilonesi, sì, ci si aspetta da uno che lavora per… I Cavalieri, no, nei Cavalieri il coro dei Cavalieri dice: "Solo per lui noi avremmo calcato la scena, solo per lui". Quindi c'è un rapporto diretto, solidale, tra i Cavalieri e questo giovanotto, che era un Povero Diavolo, nel senso che era figlio di un clero. Quindi, questo almeno su Eupoli possiamo discutere: se sia vero che al cped l'ha buttato dalla nave, può essere una leggenda nel caso di Aristofane. Però, abbastanza sicuro che, che se ne dica, che suo padre era un clero e aveva la terra a
Egina. No, perciò lui dice: "Attenzione! Non cedete a Egina, se no perdete il vostro commediografo!" Vuol dire questo. Vuol dire che lui ha formalmente, è nato lì e che lui è al servizio dei Cavalieri o comunque di un gruppo identificabile con quell'etichetta. Spari a zero sulla ferocia e iniquità dell'impero, si capisce eh, che spari a zero su Cleone, vendicandosi di fatto che lui lo ha denunciato davanti alla buia, pure fallendo. Che esulti perché Cleone, per ragioni che non sappiamo, ha dovuto pagare una multa molto forte; lui dice cinque talenti, che è una somma gigantesca. Non
so se sia iperbolica, si capisce perché Cleone scomparso. Pericle, verso il quale si era comunque atteggiato in maniera ostile nell'ultimo tempo di Pericle. No, perché Pericle è un personaggio non facilmente identificabile con la democrazia radicale. Tukur eh, che lui attacchi Cleone, benissimo, perché Cleone è la bestia nera dei Cavalieri. È quello che, appena può, fa fallire il tentativo di rinnovare la tregua annuale del 423-422. Quindi guerra fonda, per le ragioni che sappiamo, abbiamo già detto. No, la guerra è parte integrante del meccanismo democrazia imperiale. Questo è il punto base, meno riusciamo a orientarci e lì
si vede la bravura di quest'uomo: quando il bersaglio è Socrate. [Musica] Euripide, intanto, il comico ha una forza straordinaria, quella di poter sempre dire: "Ma questa è commedia, quindi non devo essere preso sul serio necessariamente." No, la tragedia non può fare questo. La tragedia è molto più vincolata, per cui deve sempre ricorrere, se vuol dire qualche cosa, all'uso del mito, che è fruibile in cento varianti nel mondo ateniese, anche nel mondo greco. Non solo, poi la commedia ha questa valvola di sicurezza: è commedia, quindi fa ridere. È l'obiettivo principale, ma anche se Aristofane dice e
ridice che la comicità banale gli fa schifo, questa parabasi delle Nuvole fa un elenco di scenette comiche tipiche, banali oltremodo banali, e dice: "Io questa roba non la faccio, e solo per questo voi magari mi avete voltato le spalle. La mia commedia, cioè le Nuvole, quella contro Socrate che avete bocciato, è la migliore in assoluto che io abbia fatto, è profonda". Naturalmente lo dice in un contesto in cui deve anche avere un effetto comico, quindi è quasi una forma autoironica. Però dice una cosa profondamente sentita da parte sua, tant'è vero che ha tentato di riproporla
nelle Nuvole. Il bersaglio è Socrate. Ma già negli Acarnesi, l'idea ne esce male, viene ampass, sfiorato, ma in maniera molto distruttiva, molto sarcastica. Lui sa che la comicità banale non è la sua cifra; lo dice nel 423. No, con la parabasi delle Nuvole lo ridice all'inizio delle Rane, 18 anni dopo. No, all'inizio delle Rane, un duetto fra Dioniso, come alcuni giustamente dicono, o Dioniso, se mi piace, ma non sarete puniti né un calo né dell'altro, e il suo servo. [Musica] Santia, in cui il servo dice: "Devo dire una delle solite banalità per cui il pubblico
ride". L'altro dice: "No, mi stomaca soltanto il pensiero che tu ad Ombri di fare una cosa del genere". Quindi c'è proprio una presa di distanze aristocratica rispetto alla comicità banale, e che può rendere, dal punto di vista del successo, questo per complicare la figura di Aristofane, che non ha vinto tante volte. Eh, di Euripide si dice che ha vinto pochissimo e l'ultima vittoria, la quinta, l'ha avuta da morto. No, qui il figlio nipote ha portato sulla scena di Atene la trilogia che lui aveva elaborato ormai in Macedonia, dove si era ritirato dopo il 409-398. Allora
i due che vengono bersagliati, Euripide e Socrate. Euripide, abbiamo detto il suo rapporto sicuro con un personaggio come Crizia, lo colloca in una posizione, diciamo, di critica del regime vigente. Poi, ovvio che ci sono tanti compromessi. Però, se uno passa in rassegna i temi per Euripide, siamo fortunati perché per caso abbiamo una ventina di non soltanto sette, e come per gli altri due. Se uno passa in rassegna, diciamo, i motivi fondanti. Lui mette in discussione tutto, anche l'istituto della schiavitù, anche la condizione femminile, che per un buon democratico ateniese è un problema. La condizione femminile
è un non-mondo, è estraneo alla cittadinanza. Sono non persone. [Musica] Per non parlare dell'aspetto, diciamo, religioso o irreligioso. Ricordiamoci sempre che le aristocrazie a mente. Ma insomma, molto spesso, sono portatrici esattamente di questa critica radicale o strumentalmente o per profondo convincimento attaccano la grettezza della mentalità democratica e i comportamenti concreti della democrazia ateniese rispetto, per esempio, a figure inquietanti di filosofi, Anassagora in primis e poi Socrate, tardi. E se vogliamo, le scuole filosofiche nel quarto secolo, quando addirittura c'è una proposta di legge di chiuderle, e parte dall'entourage post-demostenes di costante minaccia su quelli là che
mettono in discussione tutto. Chissà cosa fanno nelle loro cerchie. Poi l'ateniese medio sa che esistono le eterie. Le eterie sono associazioni più o meno segrete di signori coesi che fanno insieme letteratura, simposio, politica, si aizzano a vicenda. E il clan filosofico e l'etera si rassomigliano abbastanza, visti dall'esterno, dall'es medio democratico. In quell'ambiente tutto si può discutere. [Musica] No, nel Sisifo di Crizia o Euripide per dirla con sesta empirico, c'è tutta la teoria della genesi umana degli dèi, no? Invenzioni degli uomini, no? Con funzioni di polizia, di ordine pubblico, di disciplina, no? Pensieri agli antipodi della
religione olimpica, o se vogliamo anche... Delle forme diffusissime di religione popolare, come i misteri, pleusini, che sono fortissimi come presenza radicata, e quindi in quegli ambienti coesistono, lo ha scritto molto bene un notevole studioso che poi nella vita ha fatto tutt'altro. Si chiamava Wattenbach, era un amico di Monsen; tutto sommato, poi è stato coinvolto nei monumenti della Germania storica. Ha fatto il medievalista. Wattenbach, da non confondere con Wittenbach, che invece è un signore molto precedente, editore di Plutarco. Wattenbach è un'altra persona: la sua dissertazione è "De Quadring Gorum Faione", cioè una prima prosopografia, potremmo dire,
ragionata dei 400. Lui non aveva il Corpus delle iscrizioni che abbiamo noi, non aveva la prosopografia attica di Kirchner, men che meno le "Athenian Persons", che hanno fatto un ottimo lavoro negli Stati Uniti. Canà, da ultimo, lavorava sulle fonti che sapeva a memoria. Comunque è un ottimo strumento, questa dissertazione in latino; lui mette subito in chiaro una cosa: nella faziosità dei 400 assunti come simbolo di un gruppo oligarchico molto potente convivono tante cose diverse. Convivono i gretti reazionari all'antica, per cui anche Socrate e anche Euripide sono gentaglia pericolosa e che quindi magari sono in piena
sintonia col contadino attico puro, saggissimo, come dice Aristofane quando lo va adulando. I valori all'antica, le mode nuove, fanno ribrezzo. E poi ci sono invece i giovani che si atteggiano a filo spartani, no? Anche fisicamente. Poi ci sono la gens dor, quelli che mutilano le Erme e non si capisce perché tutti in una notte, che magari nella preparazione del colpo di stato, fanno anche i sicari, ammazzano di nascosto capi democratici e nessuno imbastisce un processo. E poi ci sono i grandi critici della democrazia, i vari Antifonte. No, Antifonte è un cervello, tuid de lo ammira
to corde. Ci sono tutte queste anime dentro la faziosità. Quindi è una bella tastiera, dov'è la bravura di Aristofane. Punto fermo: il popolo, non il demo, e quindi dice "opol", che è lui stesso, e per avere l'applauso di quella parte che è numericamente maggioritaria. E l'applauso non è soltanto una soddisfazione così estetica, influenza anche le decisioni, poi, degli arconti che dicono "ha vinto Tizio, ha vinto Caio". Perché qualcuno alla fine deve fare la graduatoria di chi ha vinto e lo fa su vari elementi, comprese le, anzi, dando peso alle reazioni del pubblico. Quindi la stella
polare è quella: il popolo, non il demo, e giustamente Nietzsche dice "il demo non è il pubblico, ma il bersaglio di Aristofane". E alla luce di tutto questo discorsetto, questa frase diventa più chiara: per avere questo facile consenso è ovvio che deridere un estroso personaggio come Euripide, che mette, come dice Estilo, nelle "Rane", in scena donnacce, quindi moralismo bieco, va benissimo. Euripide può essere tartassato e fa piacere questo a quella parte lì. Socrate, meglio ancora, no? Nel "Commèdia", la commedia, perciò lui è molto seccato che gli è andata male. No, nel 423 aveva ottenuto un
successo strepitoso; l'anno prima, nel 424, coi "Cavalieri", primo posto, prima volta che lui fa il regista e volta unica, forse di una presenza addirittura di cavalieri veri come coreuti. Poi non devono fare moltissimo, coreuti; poi il corifeo fa le cose più impegnative. Però magari si sono anche addestrati e li hanno addestrati, hanno imparato la parte. Recitare, l'attore professionale, nasce un po' dopo, eh? Eschine era un attore professionale e Deos lo prende in giro per quello, e gli faceva invidia perché aveva una voce potente mentre era anche balbuziente, quindi molto difficile. L'anno prima è un trionfo
ed è un trionfo in salita, eh? Perché? Perché tra il momento in cui ha redatto la commedia e la deve presentare, almeno in parte, agli arconti, e poi la deve offrire agli attori che devono imparare la parte, quindi non è che finita il giorno prima va in scena. Ci sono settimane e settimane di preparazione [Musica]. Mnemonica. Tra la redazione, diciamo così, e la messa in scena c'è il trionfo di Cleone, inaspettato, nell'assedio di Sfacteria. No, prigionieri, un centinaio e passeri spartani, puro sangue, proprio animali d'allevamento. In caso di dire più, qualche centinaio di combattenti presi
prigionieri nella stessa circostanza, che diventano un po' un elemento di forza di ricatto, no? Nella clausola della pace di Nia, in primis c'è la restituzione di questi qua; e Cleone ha chiesto la pace subito dopo lo scacco di Sfacteria. E Cleone si è opposto. Cleone sulla cresta dell'onda, perché si è trovato lui a vincere per caso, no, subentrando a Nieta e quindi non essendo stratego a tutti gli effetti, ma surrogato di uno stratego divisionario. E quindi attaccarlo dinanzi al pubblico dopo questo successo è curioso; c'è riuscito magnificamente. Tra l'altro, i "Cavalieri" in quella commedia esaltano
come ben più importante della vittoria di Sfacteria un loro piccolo successo: che hanno fatto uno sbarco a Corinto, hanno fatto, hanno ottenuto una piccola soddisfazione, orno fatto una scorreria, non più di questo. Poi sono tornati su e sono tornati ad Atene e nella assurdità di questa contrapposizione, la vittoria di Sfacteria viene presentata come un inzia. E invece questo trionfo dei "Cavalieri": noi andammo coraggiosamente sulla terra di Corinto, mi sembra, hanno fatto chissà che cosa. Il premio, però poi si vota, ci sono le elezioni per gli strateghi poco dopo. Noi non abbiamo notizie precisissime sul mese
in cui si vota, però dalla successione "Cavalieri", "Nuvole" possiamo ragionevolmente pensare che si sia votato dopo la messa in scena di "Cavalieri", che vincono alle le nere, quindi si sarà votato a marzo. Le "Leene" sono a fine gennaio, inizio febbraio, e Cleone viene rieletto. Anzi, viene eletto per la prima volta perché quella non era una strategia vera e propria: quella quando ha comandato le truppe a Bacterio e ha avuto quel grande successo l'anno dopo, tastiera abile. No, prima in sequenza, tre cose: Politic babilonesi, Acarnesi, Cavalieri. Babilonesi, abbiamo detto ad nauseam. Pace è separata; noi siamo
nel 425, prima di Delion e prima di Sfia Dicheopoli. Fa una pace personale. No, questo è uno dei punti alti di questa commedia, che è un po' sconclusionata. Non è vero; poi la commedia è fatta così: dopo la parabasi c'è una serie di episodi, ma non per questo è sconclusionata. E "fa separata" è una richiesta pesante, perché era la richiesta degli oppositori, prima di Pericle e poi di Cleone. E lui la mette sul comico. No, c'è questo qui che è un contadino che si è stufato della guerra, dice il peggio possibile dei politici e fa
la pace separatamente. Lui, Cavalieri, abbiamo appena detto, attacco frontale a Cleone. Cleone viene fatto a pezzi; Demo è un vecchio rimbambito, schiavizzato da Leone. Alla fine della commedia viene bollito, rinasce e caccia questo impostore. No, qui direi che più chiaro di così. Quindi tre testi, tre pezzi di cui il terzo presentato in prima persona, di una indiscutibile politicità schierata, schierata in modo netto con un bersaglio chiaro: il Demo guerrafondaio e il suo capo, Nuvole. No, non vuole. So ed è la trama; vi è certamente nota, no? Interessante per tante ragioni. Fra l'altro, Platone se n'è
ricordato nell'Apologia. No, nell'Apologia, più o meno vicina a quello che Socrate realmente disse. Inutile sofisticare; possiamo dire con certezza un bel niente, ma nel 399 si celebra questo processo e Socrate sfida la giuria. Alla fine viene condannato a morte, eccetera. Ma il primo dei discorsi che pronuncia, la vera e propria Apologia, si apre dicendo: "Il primo accusatore fu la commedia che mi ha raffigurato mentre aerobato, no, cammino per aria", che è la scena famosissima di Socrate nel cestello del macchina del volo, che appare mentre gli scolari si intrattengono con il vecchio Strepsiade, che è andato
lì per imparare le male arti della retorica e uscire dai debiti in cui è sprofondato per colpa del figlio e della moglie. Strepsiade è un contadino, quindi una persona aristocratica, apprezza. È secco; Tiso, perché a causa della guerra non può picchiare gli schiavi. No, si deduce di lì che forse il regime, diciamo, inter-familiare verso gli schiavi può essere stato attenuato a causa della guerra. Eh, maledetta guerra! Non posso, neanche questi ronfano, dormono; lui è sveglio perché è ossessionato dai debiti. Il figlio non fa che sprecare i quattrini; corse di cavalli, compra cavalli. La moglie? No,
ne parliamo perché è aristocratica. Il figlio si chiama Filippide, lui si chiama Strepsiade. E colpo di Genio: vado da Socrate, imparo come imbrogliare le carte, rendere forte il discorso debole e mi tirerò fuori dai debiti. Il milieu familiare viene rappresentato piuttosto interessante, perché il giovanotto, il Filippide, che poi diventa un protagonista, che il padre fallisce, dialoga a lungo con Socrate. Socrate gli dice: "Sei un disastro! Non capisci niente!" Lo manda via, fraintende tutto. Quindi grande comicità banale, no? Equivoci sulle parole, parole in doppi sensi, eccetera. Filippide subentra; prima non voleva andare lui a scuola di
Socrate, invece poi impara talmente bene che minaccia di picchiare il padre perché il padre ha parlato male di Euripide. Quindi vedete bene l'ambiente: c'è un contadino presumibilmente ricco che ha sposato una donna in alto nella società, che quindi spreca, è scialacquatore, dalla madre. E quindi ha una sua, diciamo, formazione, stile di vita, soprattutto che è quello della gioventù di questa genesi che poi bicherà le avventure oligarchiche in realtà. Infatti, si impara, discende dal mondo socratico; il mondo socratico al quale la democrazia ateniese rimprovera di essere la matrice dell'oligarchia omicida di Trizia. No, questa sarà la
vera ragione del processo, al di là di altre motivazioni che certamente hanno avuto il loro peso. Quindi quello è l'ambiente; il guru, diciamo così, di quell'ambiente è proprio Socrate. Socrate viene presentato in una forma più negativa possibile. Alla fine, però, insomma, Strepsiade non ne può più del fatto che anche il figlio ormai si è schierato in quella gente e la conclusione è l'incendio, tentativo di incendio, incendio nella casa del filosofo. No, come scrisse Dods in Gre: "irrazionale". Non si fa sufficiente attenzione al fatto che quella commedia è un incitamento a Socrate vivo, perché Socrate è
vivo e vegeto nel 423, a passare alle vie di fatto contro questo disturbatore, il quale nell'Apologia si autodefinisce il tafano, no? Quello che a voi ateniesi dà un fastidio, ponendovi le solite domande non facili, ruotanti sulla questione competenza, non competenza, qual è la specifica competenza politico, eccetera, eccetera; tutte domande che mettono in discussione, come fa l'araldo tebano Cont Teseo, i fondamenti della democrazia. Ecco, questa commedia però è un disastro. Nel testo che io vi ho dato, e non per ostentazione, ho dato effettivamente perché mi auguravo di utilizzarlo, ci sono dati due, uno è, spero di
trattarlo tra qualche minuto, il più famoso comizio di Aristofane e la parabasi delle nuvole. Dunque, se andiamo, sì, in basso della pagina 161, quella r numerata come sesta, non c'è? Non ce l'avete? Beh, quindi una beffa veramente trea; dopo i nostri sforzi, Diani sono falliti in pieno; sono insufficienti. No, sono insufficienti le pagine, cioè qualcuno ce l'amo. Una volta mi è capitato, quando facevo lezione, c'erano alcuni studenti i quali avevano di leggere un testo per non dare il dispiacere che non ce l'avevano davanti, la fotopedia di leggere qualcosa che non c'era. Spero che non succeda
in questo caso; se abbiamo comunque almeno un testo in vista tra due o tre utenti, già qualcosa. Ma comunque, al massimo cerco io di soffrire questa breve premessa. Una cosa che non si dice spesso: "Leese". Grazie! Infatti, ogni tanto serve un po' d'acqua. Grazie! La migliore edizione, con apparati più che soddisfacenti di queste ipotesi, che sono proprio un consommé dell'erudizione Alessandrina passata attraverso una serie di filtri e riduzioni. E alla fine sono approdate nei manoscritti, quindi rimpiangiamo l'intero CH. Dove è finito questo di C? Questo francese Cava, al Saziano, doveva farlo per Teer; poi, dopo
il 1918, l'Alsazia passò alla Francia. Quindi lui lo fece con le bellezze e si beccò una recensione a sprinia di Vilam Movit che quasi lo trattò come un traditore della patria. Poveraccio, era un professore di liceo del Liceo Cleber di Strasburgo, no, capitale del Managgio, un'ottima persona. Ha fatto un grande lavoro e poi Niger Wilson, in realtà, ha fatto bene nell'ultima edizione, insomma, ultima ormai da qualche anno, di Aristofane per la Clire and Oppress e ha messo a frutto qua le congetture moderne che Culon ha trascurato o non conosceva. Quindi i due apparati si completano.
Prima di loro, però, l'abitudine era di pubblicare queste tesi in modo selvaggio, senza neanche una nota critica, niente. Se prendete l'edizione standard, tante volte usata da Dine, è addirittura in corpo invisibile, cioè talmente depressa che solo i miopi sono esclusi dalla frizione di quella ipotesi, talmente piccolo il corpo di stampa. Ed è proprio per una critica che come edizione si desidererebbe un'edizione critica vera di tutte le ipotesi che ci sono arrivate, non solo quelle di Aristotele, che sono le più abbondanti, ma anche del Corpus dei tragici. Eh, e si imparerebbero parecchie cose da un lavoro
organico su questo. Tra l'altro, molto arbitraria è la suddivisione prima, seconda, terza; questa viene presentata come sesta, ma a beneficio inventario è un pezzo di un discorso che comincia prima. Le prime Nuvole, dice, furono rappresentate nell'asei e che è la formula per dire alle Dionisie Nesei. Epi arcontis Sarcu, quando nell'occasione in cui Cratino vinse con la bottiglia, Pitine. No, era stato attaccato; Cratino era molto più vecchio, era l'altra generazione rispetto ad Aristofane. Eupoli erano dei ragazzi rispetto a lui, era più vecchio e l'avevano preso in giro; ormai Cratino è rimbambito, beve troppo il vino, non
è un alleato. E quindi Cratino fa questa commedia, La Bottiglia, in cui lui tradisce la moglie protagonista perché si è invaghito della bottiglia e poi, alla fine, lieto fine di questa che è una replica, diciamo, alle accuse di essere troppo debole, ha successo al primo premio. Non so se per premiare anche un vecchio che è tornato in lizza con questa commedia. Comunque Enica, Putine Amias, de Conno. Quindi, Amipsia arriva secondo con una commedia intitolata Conos, un nome proprio. Primo e secondo, attenzione, talvolta nelle otes si legge “Enica imperfetto,” il verbo “Nican”: no, vinse, vinceva. Deuteros,
quindi anche il secondo è vincitore. Ma sia il primo, che ha il premio maggiore, ma anche il secondo vince; il terzo è una posizione. Ma invece Aristofane, Apor RF Teis Paralòs, essendo stato respinto, contro ogni previsione, non dice che è arrivato terzo: è stato respinto. No, Aporis, e io credo, anche se di solito non lo si pensa, ma io tengo a pensare che questo significhi che lui non è riuscito neanche terzo, perché nel 423 ci sono ancora cinque concorrenti, che vuol dire parecchio, cinque concorrenti tra i tanti che hanno chiesto il coro, e i più
sono stati respinti. Vuol dire cinque corei, cioè cinque investimenti economici per altrettanti pezzi da portare sulla scena. Quindi, cinque, quando la guerra va sempre peggio, si riduce il numero dei concorrenti; c'è tutta una discussione in proposito per cui “respinto” secondo me vuol dire che è andata veramente molto male. Par logos, un po', se vogliamo, sarà il Grammatico della O. È una congettura sua o attinge alla parabasi in cui Aristofane si lamenta di questa inaudita sconfitta. Comunque Paralo ritenne di doverle rappresentare da capo le Nuvole. [Musica] Seconde, in un'altra delle Iesis, viene descritto in che cosa
stette la modifica apportata al testo che era andato male onde poterlo presentare. Una tradizione molto accreditata e recepita da questo signore Aon Poliu Mallon, essendogli andato ancora peggio. Centoys Epita, anche in seguito, non mise più in scena Uki. E i Seagen Ten di Asken non mise più in scena il rifacimento. È confusa come notizia perché non si capisce se Ste Nuvole Seconde sono andate in scena o no. Perché, a uno pensa che la ripresentata è andata male da capo, ma Ukti Eagen Tasken vorrebbe dire invece che non ha portato in scena. I moderni ritengono che
la seconda redazione di Asque, cioè il rifacimento, non l'abbia portato in scena il bravo Aristofane. Noi leggiamo il rifacimento perché lo sappiamo, perché nella parabasi lui si lamenta della sconfitta. Vi do lettura. [Applauso] Velocissima, cari spettatori, vi dirò la verità senza peli sulla lingua: per Dioniso, che mi ha fatto grande, il primo premio è una reputazione di sapienza per avere scelto di far riassaggiare a voi per primi, pensando che voi foste un pubblico competente, questa commedia che a mio parere è la più profonda che io abbia scritto, quella che mi è costata più fatica. Allora,
senza meritarmelo, ho dovuto cedere il passo ai volgari, che hanno purtroppo vinto, e di questo do colpa a voi, i cosiddetti esperti, quelli per i quali io mi sono dato tanto da fare. Tuttavia, anche così, non tradirò mai di mia iniziativa. Chi di voi ha mostrato di intendersene già una volta, su questa stessa scena presentai il Casto, Fato, ebbe un grande successo e quelle parole che ho prima ricordato erano una ragazza: non poteva partorire, un altro ha preso il frutto, eccetera. Quindi, da questo inizio, questo è l'Epiro, il primo intervento in Corifer. Si capisce che
stiamo leggendo una nuova parabasi in cui si parla della sconfitta subita. Quando è stata presentata la prima volta, la cosa che colpisce è che nel Seg di questa lunghissima parabasi lui dica: io, io Aristofane, quando Cleone era sulla cresta dell'onda l'ho colpito al petto, ho avuto il coraggio. Di affrontarlo direttamente, ma dopo che è caduto per terra non ho avuto cuore di dargli addosso un'altra volta. Queste parole vengono intese, credo giustamente, la frase "Quando è caduto per terra" vuol dire "quando è morto sotto Anfipoli nel tentativo di riconquistare Anfipoli". Perché Cleone ha avuto il grande
successo che abbiamo detto, 424 è stato rieletto, è ridiventato stratego. Però, attenzione: noi sappiamo abbastanza bene la composizione del collegio degli strateghi quasi per tutti gli anni della guerra ed è molto interessante notare che Cleone e forse Demostene (non Demostene oratore, no, colui che aveva fatto quasi tutto il lavoro) a Smia, tra l'altro, sono in buona sintonia con il demo Guerra Fondaro. Però molti altri componenti del collegio di strateghi non sono affatto così. Quindi Nietzsche, per esempio, è rieletto tutti gli anni e Nietzsche è quello che poi riuscirà a imporre la pace nel 421, avendo
evidentemente la maggioranza del collegio di strateghi dalla sua parte, il che spiega che, nonostante lui sia un autorevole stratego, negli ultimi mesi del 424 si vara la tregua annuale del 423-422. Tra l'altro, per il 400-424 è stratego Cid che certamente appartiene alla famiglia di Simone. Rispetto a Cleone, agli antipodi, disciplinatamente va a fare la guerra dove gli hanno detto di farla: in Tracia, eccetera. Però certamente uno degli strateghi favorevoli a chiudere questa guerra, almeno per posizione, diciamo, politica, personale, familiare. Dopodiché Cleone riesce a non far rinnovare la tregua e da capo stratego del 422-21 parte
con un corpo di spedizione che deve riconquistare Anfipoli che ha defezioni nell'inverno del 424-23 e muore in battaglia. Muore anche Brasida, un grande generale spartano, sotto le mura di Anfipoli e quindi ci sono le condizioni per cui Nietzsche e i suoi amici possono cogliere un momento in cui anche a Sparta non se ne può più dei vari Brasida che hanno sorretto sempre la scelta bellica. Quindi, quando dice "Quando è caduto per terra", io non ho avuto cuore di attaccarlo ancora e presuppone la sua morte nel 422 ed è un indizio interno della datazione della commedia
nella forma in cui noi la leggiamo. La Dias faci meglio colpisce il fatto ed è la prova che siamo davanti a un lavoro incompiuto che, sempre nell'an Pirrea, a questo punto, l'altro pezzo della parabasi, lui parla di Cleone come vivo, voi, nonostante il successo dei Cavalieri, l'avete rieletto. Quindi sta parlando di uno che è ridiventato stratego nelle elezioni fatte poco dopo il successo del 424. Pare che questo paese sia tutta una decisione sbagliata, ma che poi gli dèi volgano al meglio i vostri stessi errori è facile spiegarvi come anche questo potrà essere utile: basterà bloccare
quel porco di Cleone mentre ruba in tasca una tangente. Quindi stiamo parlando di un Cleone vivo ma nell'area è morto. Allora questo è un testo che è rimasto così, un tentativo di rifacimento. Si può anche capire, no? La cosa però che ci deve interessare è evidentemente tutta questa satira pesante antisocratico non ha propiziato la vittoria, non è riuscito nel disegno di avere, mentre magari quelle stoccate di Euripide sono state sempre corriere di risata del pubblico di successo. Per dire, le Rane hanno avuto un buon piazzamento, senza dubbio, e Euripide ne esce malmenato proprio intus e
tricut, sia pure molti anni dopo. Contro Euripide poi c'è tutte le Toforie anti, no? 411. Non sappiamo in quale. Alcuni pensano che noi leggiamo le Tesmoforie antiforse non le prime, quindi dovremmo passare al 410. Però è curiosa la strategia di attacco, diciamo, politico di quest'uomo, no?, a considerarla in un'ottica di rigore partitico, perché Socrate, bene o male, è il punto di riferimento di un'élite che guarda con ostilità al regime democratico, che guarda con simpatia alle cerchie Rosti, no? E sappiamo come è andata a finire, no? Però Socrate è anche un elemento non classificabile. I suoi
allievi hanno insistito sulla rottura che si è determinata fra lui e Crizia. Va bene, però sta di fatto che potremmo dire, come si diceva all'epoca, è rimasto in città. No, quelli che non accettavano il regime dei Trent se ne andavano e venivano anche incoraggiati ad andarsene, no? È rimasto incitante, Aristofane è certamente rimasto incitato. Io credo che si possa tentare una sintesi di questo complicato rapporto di Aristofane con i suoi referenti politici. No, è chiaramente un intellettuale al servizio, potremmo dire, però con tutta la volontà di indipendenza di grande artista, no?, che non si fa
mai poi ingabbiare nel ruolo di propagandista e basta. E uno dei segreti è anche quello di toccare tastiere diverse, sollecitare reazioni positive di pubblici fra loro diversi. Socrate è un bersaglio comodo per avere un successo tra i tradizionalisti, i contadini, come lui stesso li chiama, però la figura che mi è capitato di evocare è quella modernissima del XX secolo, del cosiddetto compagno di strada, cioè un intellettuale che non si lascia utilizzare, però svolge un ruolo, sa di svolgerlo, ci tiene alla sua indipendenza, però lavora in una certa direzione. Il fatto che Platone abbia messo Aristofane
dentro il Simposio che discute con Socrate sull'arte tragica, l'arte comica, certo, nessuno pretende di utilizzare questi testi in maniera schematica, però allude a una frequentazione di quell'ambiente da parte di Aristofane che un pochino smaschera l'antisismica ista, no?, che nelle Nuvole traspare in modo così prepotente. Per questo io ho voluto darvi, ma ora magari ne leggiamo qualche lio e basta. Un esempio unico, direi, nel poco che ci è arrivato, del modo in cui invece, almeno in un'occasione molto pericolosa e unica a suo modo, del modo in cui Aristofane ha fatto politica direttamente, cioè non più in
modo mediato, come per esempio accade in questa parabasi delle Nuvole dove parla di sé, quindi sembra interessato nella parabasi soprattutto a una polemica artistica contro quelli ignoranti che hanno vinto e che... Poi sono niente meno che il tratino e amipsia. Alcuni capivano il suo gioco, no? Tutti ci ricordiamo che proprio Cratino è potenza dei frammenti. No, frammenti decide la provvidenza. Sicuramente c'è una Provvidenza dei frammenti che li gestisce in maniera che noi ci affanniamo a interpretarli. No, frammento di Cratino che ha inventato un neologismo: “ipid aristan”, no, che non esiste naturalmente. Euripide e Aristofane Giare,
che vuol dire semplicemente: caro Aristofane, tu sei fatto della stessa pasta di quegli intellettuali che fingi di attaccare. Punto e basta. Questo Cratino era quello che insultava Spasia in maniera indegna, perché era tagliato sul popolo di Atene, che applaude a una determinata comicità e che vede in Pericle il folle che ci ha portato alla guerra infinita con l'argomento assurdo che gli alberi ricrescono e quindi se spartaci devastano campagne, nulla. Questo Euripide Aristofanis, secondo me, è proprio la chiave del compagno di strada che ha saputo dissimulare benissimo le sue scelte, facendo volta a volta la sua
parte nel parabasi D. Ran, nella parte esplicita. No, io penso, spero che questo testo vi sia arrivato tra quelli che abbiamo distribuito. Bene, l'argomento è notissimo, l'abbiamo detto, credo. No, lo scontro tra i due morti, tutti e due, Urid ed Estio. Euripide è morto da poco, Estilo da un sacco di tempo. Estilo ha il trono dell'arte tragica nell'Ade. Euripide arriva, lo vuole lui, quindi, come dice lo schiavo di Plutone che governa nell'Ade, tutti i delinquenti si sono schierati subito con i R immediatamente, e quindi siccome sono la maggioranza, qui, come ad Atene, il putiferio è
serio. Ah, è orribile, rischia di vincere. Arriva il dio del teatro che voleva portarsi ribile sulla terra, gli viene dato il compito di dirimere questa rissa micidiale e comincia la gara artistica, che finisce alla pari. Poi il consiglio politico, il consiglio politico vince Eschilo. Il dio del teatro riporta Eschilo sulla terra, e tanti saluti, auguri e tutta una festa finale. In mezzo a tutto ciò che sembra un trattato di storia letteraria, diciamo, no? Perché in fondo il nostro giudizio sui tre grandi tragici sta tutto nelle rane, per cui Nietzsche diceva giustamente che le rane sono
la conclusione della drammaturgia; Tenies finisce lì, esagera un po', però dice una cosa vera. Aristofane sente di fare un bilancio di una cosa che sta finendo. Né è nato più un altro Estilo o un altro Euripide dopo la scomparsa di quelli là. Eh, un fatto, con tutto il rispetto, dei vari Timoteo Picino, dentro questo un comizio, il comizio che ha un obiettivo preciso, quindi non c'è più da giocare. Vari tasti: contadini, demo, siete ignoranti. No, siete bravi, si parla chiaro e si parla chiaro, perché c'è un problema. Coloro che sono compromessi nel colpo di stato
regime oligarchico del 411, a seguito di un decreto popolare varato dopo la battaglia di Cizico, quindi nel marzo circa del 410, sono stati processati con l'accusa di complicità con i nemici. Democrazia, cat demon, è un crimine. Allora l'accusa è: complicità è un reato politico. Noi conosciamo il decreto che ha sancito questo parato da un tale, si chiamava Demanto. Non sapremmo nulla se non ci fosse questo testo trascritto da Andocide in una sua famosa orazione. Hanno perso i diritti politici, quindi sono stati resi atimi. È una massa di gente, sì, non ci sarebbe il problema di
restituire i diritti politici a queste persone se non fossero un numero consistente. Non sono pochi casi individuali, è una massa di persone che a torto, a ragione, addirittura. Sempre facciamo capo a quei testi documentari per avere svolto attività di servizio militare sotto il governo dei 400, sono stati impallati e privati di diritti politici. E la cosa va avanti per alcuni anni. Rientra CBI, trionfo, poteri speciali, seconda caduta di Alcibiade. Margin Terame, che è uno degli artefici del 411 ed è uno degli artefici del processo contro gli strategi e poi sarà partecipe del governo dei 30.
Poi sarà ammazzato. Del 30 personaggio dice: politeia, il vero politico, ma lo dice con entusiasmo, non perché voglia ironizzare. A un certo momento però gli equilibri cambiano, per cui comincia a porsi il problema che gli atimi vanno reintegrati nella cittadinanza. Chiaramente i rapporti di forze sono mutati e chi stava, come dire, acquattato, perché il decreto Diopanto ha falcidiato alla grande dopo che è stato decapitato il collegio degli strategi. G. Amici Cbasso, figlio di Pericle, viene mandato a morte, era uno dei strateghi processati. Dopo che è avvenuto questo, per opera di Teramene si comincia a capire
che la guerra bisogna chiuderla. Ma c'è un politico che si oppone: Cleofonte, mai e poi mai, il nuovo Cleone in un certo senso. E quindi serpeggia il problema: bisogna restituire i diritti politici agli ai. Che non è un problema teorico. Quel scrittarello che io vi ho citato prima, dove si legge "comodin de leg Demon", ecco, Pol termina. Si conclude con un dialogo in cui si dice: abbiamo numero sufficiente di atimi per abbattere la democrazia in Atene. Sono molti? Sono pochi. Risposta: sono pochi, non sono sufficienti per abbattere la democrazia di Maten. Quindi gli Aimori, cioè
quelli che hanno subito questa privazione, sono, diciamo, la massa di manovra sicura per ritentare di cambiare regime. Risposta che si danno gli interlocutori di quel dialogo è: non sono sufficientemente numerosi per agire. Però intanto il problema di rimetterli nella cittadinanza evidentemente c'è. E Aristofane impegna tutta questa parabasi e perlomeno l'pirrea in modo esplicito, esattamente per questa causa, e fa un intervento che meriterebbe di essere man mano tradotto e commentato. Ma io metterò a qualche rigo per portarvi in sostanza un esempio di come quest'uomo, che ha saputo fare l'anti Socrate, l'antipasto, bene il suo carte, qui
ritiene di dover parlare chiaro e scende in Lizza per una causa assolutamente impopolare, ai sensi del decreto di... e quindi di senza che ci sia alcun. Nesso con l'argomento della Cont, è giusto che il Sacro coro, perché il coro nell'Ade è degli iniziati ai misteri eleusini. Perciò, diciamo che l'ambiente leosino è l'unico del quale Aristofane parli con un rispetto assoluto. Dioniso viene trattato come un buffone; gli dèi sono ridicolizzati. Eleusi è una cosa seria; è giusto che il Sacro coro dia consigli utili alla città e che i maestri parlino. Innanzitutto, per prima cosa, noi, coro
degli iniziati, ascoltiamo: è il corifeo che parla. Innanzitutto, sembra giusto, exis sosus politas, mettere in vigore il principio di uguaglianza tra i cittadini. Magnifico! Quale pubblico democraticamente tale sarebbe contro? Quindi, si parte nella maniera più abile possibile, invocando un principio tipico. No, quando Otane parla lì nel dialogo di Erodoto, la parola è la più bella. Indubbiamente, è la parola d'ordine della democrazia. Certamente, anche se si può utilizzare in altri modi, c'è un passo di Tucidide che Mazzarino ha valorizzato giustamente tra Oriente e Occidente, in cui Tucidide dice che, in un certo momento della storia della
Beozia, vigeva un'isonomia: un'oligarchia che aveva adottato il principio della isonomia e lo aveva inglobato nel proprio funzionamento. Quindi, anche questo si può sottilizzare, ma qui exus politas è chiaro, non si può sofisticare. Kai afel deata; e far scomparire le paure, i traduttori spesso soffrono per questa frase, più che altro perché non hanno presente il decreto di Demofante. Il decreto di Demofante vieta di ridare la pienezza della cittadinanza a chi è stato condannato all’atimia per complicità antidemocratica golpista. Qual è la paura che bisogna togliere? La paura che si avrebbe in assemblea se uno si alzasse all'assemblea
popolare e dicesse: "Propongo di cancellare le condanne per atimia e gli effetti del decreto di Demofante"? Sarebbe immediatamente colpito da una grafè paranomon, denuncia per illegalità. Però, al teatro si può fare, sia pure con cautela. Quindi, io, corifeo, dico che secondo me è giusto il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini e che bisogna rimuovere le paure. Cioè, parlare di un argomento del quale non si parla per paura. E infatti, quando poi questa cosa passerà, dopo la battaglia disastrosa di Egospotami, il decreto di Patroclo viene preceduto da un altro decreto che rende legittima la proposta;
altrimenti, quel decreto non passava, e se uno ha compiuto qualche sbaglio... No, Emar am Martano vuol dire compiere un peccato. Messo a terra, fis dalle mosse abili, palmata; sono proprio le mosse della lotta libera. No, ti prende alle gambe, ti fa cadere. No, come diceva Plauto, no, il vino luat dolus, no, che ti prende le gambe, che è una mossa eh? Che ti fa cadere. Se uno è stato buttato giù dai palmata, dalle mosse abili, es, leali di Frico. Frico, tutti sanno chi è, non è con Eliografo, è l'unico esponente del '400 che è stato
ammazzato prima che finisse quell'esperienza, rispetto al quale hanno preso le distanze. Quindi, è un capo espiatorio ottimo; non è lui quello che ha organizzato l'antifonte, Terame, Pisandro. I nomi sono tanti. Fra' finito prima in quel modo misterioso, un attentato in pieno giorno nella Gor, quindi gli inganni di Fro. E quindi, se qualche cittadino ha commesso un peccato, buttato per terra slealmente dagli inganni di Frinico, io dico che deve essere lecito a quelli che sono caduti. Quindi, continua l'immagine della caduta e una immaginaria lotta. Allora, in quell'epoca, dopo aver espresso le proprie ragioni, cancellare i precedenti
peccati. Quindi, ha tirato fuori, finalmente si usa dire con immagine antipatica il rospo, cioè una cosa che è molto faticoso dire, è molto rischioso. Quindi, preliminarmente, cancellare le paure. Lasciatemi parlare senza che io debba temere per me, per ciò che sto per dire. Ael è l'allusione a quel gruppo di persone abbastanza consistenti, altrimenti non si muoverebbe lui rischiosamente per evocare quella gente lì. Dice: "Quelli che sono caduti perché Finico li ha ingannati", però insomma devono poter cancellare quella colpa, il diritto di parlare. Li usa San Mattias, no, proprio un linguaggio quasi religioso, mistico, no? Cancellare
i peccati, dimettere peccato. Secondo punto: evita; io dico che nessuno deve essere atimos in città. Aimon Femi medena. Ein prima, l'ho detto con una forma tortuosa: "I peccati lavare". I peccati, qui lo dice chiaramente. Perciò, Proton Elita. Secondo punto: non ci debbono essere ad; cioè, la cancellazione degli effetti del decreto di Demofante, che è tuttora in vigore. E infatti sarebbe vergognoso, a scon, che quelli che una sola volta hanno partecipato a una battaglia navale siano subito diventati plateesi e da schiavi padroni. Una frase pazzesca! Diventare plateesi vuol dire essere, si parla degli schiavi che hanno
operato le navi durante la battaglia delle Arginuse: una battaglia tremenda, stavano per perdere. Poi si capovolge la situazione, mandano, rompono l'assedio, arrivano altre navi. Insomma, è una battaglia che dura giorni e giorni, vince Atene, perde un sacco di navi. Gli spartani, molto peggio. E poi c'è quella coda terribile dei nafi, non vengono salvati, processo eccetera. Hanno avuto bisogno degli schiavi. Schiavi sulle navi con funzioni ovviamente de-matori, quello che è. Come si fa in ogni società schiavistica che si rispetti, si promette la libertà allo schiavo dal quale chiedi l'aiuto. No, ad Atene c'è l'invenzione; non c'è
il diritto latino e il diritto pleno juro, c'è la cittadinanza dei plateesi. Perché i plateesi, avendo mandato 1000 plateesi a Maratona, unici o degli atenesi a combattere nel 490, hanno avuto sto privilegio di avere una forma di cittadinanza sui generis, minoris juris, diciamo. Allora, gli schiavi si sono beccati questa cittadinanza, tutto sommato morfica, e dicono: "Vabbè, una battaglia navale", e sono diventati plateesi. Anzi, e qui proprio spudorato, da schiavi padroni! Pazzesco, perché hanno avuto questa cittadinanza emblematica, ma non troppo operativa sul concreto; ma dire che sono diventati padroni da essere schiavi, è uno dei topoi.
Degli oligarchi. No, sempre in quell'opuscolo che vi ho ricordato c'è un'intera pagina dedicata a come vengono trattati gli schiavi ad Atene: uno scandalo per il fatto stesso che si vestono come se fossero uomini liberi. E dice: "Uno non li può neanche picchiare, perché rischierebbe di picchiare un libero scambiandolo per lo schiavo". E dice: "Questo succede in una città dove si diventa schiavi degli schiavi ateni". Quindi, è proprio un luogo comune del linguaggio oligarchico più spinto dire che ad Atene gli schiavi comandano. E quindi questi signori, che erano schiavi, sono diventati plateesi, cioè da schiavi padroni.
Mh, lui conosce benissimo il lessico degli amici suoi delle eteriche. [Musica] Sarebbe vergognoso, quindi, che quelli che una volta solo hanno fatto parte di… hanno partecipato a una battaglia navale, ma sono diventati immediatamente chiusi plateesi, anzi la schiava di… [Musica] padroni. Anacoluto qui si ferma; dovrebbe completare dicendo: "e invece gli amici miei, quelli li avete messi, resi per questo peccatuccio". Gli inganni di Fr, il ragionamento sarebbe quello, e non è che lui non sa scrivere; ovviamente è un anacoluto intenzionale. Cioè, l'ascoltatore già completa mentalmente il ragionamento. No, perché sarebbe vergognoso che quelli li avete premiati,
e sta per dire: "invece questi no". Pausa: "ma io non dico che è stato male". Non sto dicendo che è stato uno sbaglio; ha appena detto che è vergognoso. E nell'aria è rimasto: è vergognoso. Il pensiero completo sarebbe comparativo, cioè è vergognoso premiare questi e punire quelli. No, questo pezzo è a metà; ho detto che è vergognoso premiare quello, però poi correggo dicendo: "Non sto dicendo che è sbagliato", perché deve anche, come dire, tenere vivo un consenso di un pubblico che è variegato e che comunque, buttati fuori gli atimo, è anche abbastanza selezionato. Siamo alle
Lenee, quindi ci sono ateniesi e basta. Eh, anzi, lo lodo; anzi, vi va bene. E poi, no, anzi, è l'unica cosa buona che avete fatto: paradosso, perché prima era turpe, vergognoso, poi non dico che è sbagliato. Anzi, mi va bene; anzi, è ottimo. Finisce con l'essere comico nel momento in cui finge di schierarsi con quella decisione che però ha definito vergognosa, per poi finalmente abrogare alla seconda parte. Alla orges anent otato chiuse: "Ma voi, saggissimo, saggissimo, sono tutti, non soltanto i contadini, tutti. Tralasciate l'ira anent tores fantas antropus e contes Sis tesoma cimus, CAI politas.
Bisogna prendere tutti quanti epitimpano de dei diritti siung Genis sienis". Che cosa vuol dire sungenis? Vuol dire che sono della nostra stessa razza, della nostra stessa stirpe. Lo schiavo magari è un prigioniero di guerra. Insomma, comunque non è un ateniese, ma l'idea che sollecita è molto demagogica; il pubblico è che gli atenesi sono tutta una razza speciale, sono autoctoni. No, pretendono di essere tali, sono puri. No, una forma di razzismo soft, diceva Claude Calam, che viene patrimonio comune anche del popolo. Non solo; anzi, magari gli oligarchi non la pensano così. Antifonte ha scritto: "briale teias",
il barbaro e il greco sono indistinguibili, hanno il naso, la bocca, tutti e due. Quindi, dov'è la differenza? C'è un oligarca convinto? È quasi un cosmopolita perché detesta l'egoismo del demo. Il demo è razzista, oltre che antifemminista, antifilosofia, messo lì per sollecitare un tasto particolarmente delicato e sensibile. E, insomma, questo mi fermo qui perché mi sto annoiando in maniera esagerata. È una prosa formidabile di un grande oratore politico, di uno che conosce alla perfezione come si passa da una difensiva a un'offensiva vincente, toccando i tasti necessari e sviluppando lo stesso concetto per una gradazione che
va da zero a infinito. Praticamente, come è il caso di Icrom, che diventa la cosa più bella che avete fatto. Bene, viva gli intellettuali! Casì, dire che sono capaci di tutto. Grazie, bene. Abbiamo due ore di discussione davanti e possiamo serenamente addentrarci. No, l'ho fatta lunga, ma ho la sensazione che se si semplifica… è un [Applauso]. Danno, prego. E quindi i chusi orom mastico modeno nel… nello Senofonte ci sono degli elementi che ci possono aiutare a capire se il successo delle nuvole sia determinato da un… dire, un errore di valutazione di Aristofano. È stato mal
consigliato? Questo poi… scusi. L'osservazione, nella ipotesis, si cita il catino, si cita il conno di Amipsia. Ora, c'è la possibilità che il conos si riferisca a questo personaggio Nesso, come maestro di musica di Soc. E dai pochissimi frammenti di cui, insomma, disponiamo, pare che argomento del conos fosse anche qui una satira contro gli intellettuali, cioè un frammento in Timo dove appunto da qui si ricava che il Corus era composto da fronti stai. Sono sapien. E c'è anche la possibilità, ma questo dipende se un frammento sia riconducibile a questa commedia o no, che ci fosse anche
Sopio, personaggio. Ecco, questo discorso può aiutare in qualche modo a caratterizzare questa situazione dove… Sì, sì. E intanto… S, la domanda purtroppo non può avere una risposta: è stato mal consigliato? Oppure un suo moto proprio sbagliato? Non credo che dipenda dal bersaglio scelto, perché il caso di Amipsia dimostra che un buon piazzamento si ottiene avendo sostanzialmente lo stesso bago. Tra l'altro, non ci dimentichiamo che il pubblico, in assenza di strumenti amplificatori, eccetera, via via che si va sulle gradinate più remote percepisce una parte; capisce, dentro per dentro, vede, intuisce, si diverte. Quindi l'apprezzamento, fino in
fondo, della satira antisocratica è pur sempre riservato a un'elite pensante, colta, preparata, consapevole, per quanto S fosse una figura pubblica. No, per il fatto stesso che affliggeva i passanti con i suoi quesiti tipo "cos'è la virtù?". Potevo non uscire di casa, mi andava meglio. E quindi non è tanto il tipo di bersaglio, che è lo stesso, quanto il modo in cui, evidentemente, ha reso l'operazione felicemente. Non felicemente, imbloccando il gusto del pubblico. Un caso simile, in certo senso, è proprio per nel caso delle rane: la simiglianza di argomento e il diverso… Risultato, in questo caso,
c'è una ipotesi abbastanza [Applauso] ricca. Non abbiamo detto, ma non era possibile infilare anche quello che, nel nelle rame, specialmente nella Ode. Ma poi, anche nel finale, bersaglio è Cleofonte, no? Cleofonte, colui che si ostina a impedire la pace, quindi agli amici di Aristofane è in viso, perlomeno quanto Cleone a suo tempo. Ora, nella gara del in cui le rane sono state presentate, messe in scena, dice questa didascalia, anche al solito rielaborata. No, il dramma, questa commedia è di quelle molto ben elaborate, filologos. Quindi anche sul piano letterario dell'argomento letterario filologos fu messa in scena
sotto Callia, sotto l'arconte Callia, quello succeduto ad Antigene di Filon. Cioè, Filonide ha fatto da regista, non è Aristofane il regista. Filon conato uno, Allene primo fu Frinico, secondo... Scusate, primo Frinico con le muse, musis; terzo Platone, Platone comico col Cleofonte. Quindi, un caso in cui Cleofonte era il titolo, quindi l'oggetto della commedia di questo signore, peraltro molto quotato, che era Platone comico, e il bersaglio sicuramente, perché lo leggiamo nelle rane. Le rane sono andate, meglio Platone comico col suo Cleofonte; gli è andata bene. È diventato terzo. Ecco, nel caso del Conos e nelle nuvole
c'è qualcosa di simile, cioè Socrate in un caso, nell'altro Conos prevale. Nuvole? No, certo, vorremmo capire di più su quella scena. Diciamo che io non amo dire pseudos, mi pare offensivo. Uno viene chiamato per ciò che non è, come dice Boccaccio, no? Propo di Calandrino filosofale. È utilissima, perché uno non è visto dove non è, e Calandrino ci crede perché è stupido. Il non Senofonte. Vabbè, non tutti gli altri esseri umani possono definirsi come non Senofonti, perché non lo sono. Comunque, a parte gli scherzi, in quel testo noi intravediamo qualcosa che vorremmo capire meglio, cioè
che vuol dire che Idia Kusin, come dicevo prima, intuisce una familiarità, una vicinanza molto forte. Autore pubblico, ci immaginiamo. Questo sta nel Boh, una specie di bottea con qualche gia il figlio; non so se era pronto, no? Ara Ararot. Aros, alle prime armi, poi più in là impara il mestiere del padre. Ma anche il figlio di Estilo, figlio di Sofo, hanno il figlio e nipote Urif. Quindi, in famiglia c'è questa specie di bottega, ma anche gente non necessariamente legata familiarmente, e poi ci sono i curiosi. Poi ci sono le spie, cioè quelli che vanno lì
per vedere che stai facendo, andarlo a rischiare a un altro comico, perché si attrezzi, come sappiamo, per i logografi. No, per i logografi lo sappiamo bene; quel bel libro di Lavany di tanti anni fa sulla logografia artica mette insieme varie testimonianze dalle quali si ricava che nei grandi processi, certo non cause da quattro soldi, nei grandi processi i clan dei rispettivi grandi avvocati fanno la spola per cercare di far sapere all'uno che argomenti svilupperà l'altro, così quello si prepara. E spesso troviamo nella corona Beia "Prevedo che il mio nemico dirà", e quindi... già argomentazioni. C'è
tutto un lavorio sotterraneo; Atene proiettato sulla strada. Le case erano talmente orribili e scomode, de' signori, era meglio stare in giro che non dentro. E per l'attività dei comici, che non erano dei Santoni tipo Estilo, erano persone del popolo, comunque modesta condizione. Questa intrinsechezze col pubblico è molto probabile, e quindi la scena di dire "attacca quello" non è affatto inverosimile ed è molto concreta; lui sottintende che tutti sanno naturalmente che scrive per gente che è ben informata. Benic, però, ecco: "lege cum" è un po' forte rispetto al "non". Non lo vietano. Che os? Va bene,
direi che sì, sono due osservazioni più che meritevoli che dimostrano una buona conoscenza dei frammenti di Amipsia. Bene, io non vi voglio tenere a soffrire indefinitamente, perché non è il mio compito; però sono felice di qualunque dubbio, contestazione, protesta, eccetera, possa affiorare, compatibilmente col clima caldo, l'ora tarda e tutti questi fattori umani dei quali bisogna tenere conto. Eh, quindi mi affido a voi. Prego, io avrei una curiosità sul titolo, sulla scelta del titolo. Se lei si avvicina un po', io sono più felice. Sì? No, dicevo, una curiosità sul titolo delle rane di Aristofane. Perché, in
genere, nella commedia il titolo viene desunto dal coro; è così per i cavalieri, per gli uccelli, e così via. Però nelle rane c'è questa particolarità di un doppio coro. All'inizio ci sono le ramee e poi, negli inferi, ci sono G, inizia dai misteri. Però perché Aristofane dà risalto alle ramee, che invece è una parte minoritaria, se vogliamo, del coro rispetto al finale? Sì, sì, è una domanda sacrosanta e, purtroppo, senza risposta sicura. Ci sono tante ipotesi, o anche molte rinunce a dare una risposta. Io ho un'ideuzza; ogni tanto mi viene in mente che se è
vero che davano all'arconte un titolo, per forza, che è l'unica maniera di identificare il dramma, e un canovaccio e qualche parte lirica, quello era un modo perfetto per non far capire il vero contenuto della commedia. Va bene, questo è una mia spiegazione, forse un po' dietro logica, un complottistica. Ma altri invece dicono: "Ma no!", il legame fortissimo che lui ha verso i misteri, le Usini, e quindi è un atto di omaggio. Non? Poi c'è quel bel librettino di Pierre Lck di tanti anni fa, Le grenu fto, un libro sulle rane, pescando le rane in tutte
le mitologie giapponesi, orientali, greche, bizantine tarde, e quindi un animale molto simbolico. Simbolico di che cosa? Questo è l'altro problema. Può essere, può essere; Levkeche era un uomo di grande finezza intellettuale. Non azzardava risposte perentorie, però ha fatto un lavoro meritorio, cioè tirare fuori le rane dall'isolamento. No, noi pensiamo sempre a Batra coi Atene. Invece lui ne ha dato una visione molto più larga. Secondo me è comunque suggestiva. Più di questo non saprei. Un'altra? La spiegazione che viene data è che è talmente forte l'intento di deridere il dio del teatro, perché effettivamente viene trattato fino
all'ultimo in una maniera indecente, che ha voluto affidare a questo coretto limitatissimo come prestazione. Non finisce subito il compito di sbeffeggiare durante la traversata piuttosto pericolosa che lui fa da solo, remando, eccetera, mentre il povero Xan deve fare tutto il giro per arrivare sotto il peso di quei bagagli pesantissimi, non molto entusiasta, diciamo di ciò. E allora le rane, che provocano e ridicolizzano il dio del teatro, servono a rendere ancora più comica e degradata la sua presenza, la sua funzione. Anche questa è una spiegazione: sono tentativi. Insomma, è il più strampalato dei titoli che lui
ha usato, eh? Certamente è più strampalato. L'unico titolo onomastico è "Lisistrata": Lisistrata è un capo politico e quindi come Teofipò, no? Ed è trionfatrice, no? Lisistrata vince non tanto per lo sciopero famoso, ma perché alla fine impone a Spartani e Ateniesi la pace, facendo un discorso storico-politico adatto ad entrambi. Quindi Agli Ateniesi spiega: "I tiranni li hanno cacciati". Gli Spartani, gratitudine eterna visto che la tirannide è il contrario della democrazia, i vecchi del Lor hanno detto: "Qua c'è odore di Ippia". Io mi vado a mettere vicino alla statua di Armodio, eccetera. E agli Spartani dice:
"Itome! Siamo noi che siamo venuti a salvarvi!", cosa non vera, perché poi gli Spartani li hanno cacciati. Quindi fa due comizi brevi e trionfa: è un uomo politico che conosce la storia ateniese, che la sa utilizzare politicamente. Qui, il personaggio trionfa ed è l'unico il cui nome fa da titolo a una commedia, perché è una delle tante forme, diciamo, dell'ambiente ostile o critico verso la democrazia. Kiese di accentuare uno dei suoi principali difetti, cioè l'esclusione femminile. E questo vale anche dopo la guerra civile, quando le donne all'assemblea popolare vista aurano un nuovo regime. No, la
commedia contro Platone, diciamo, va bene. Prego, io avrei un'osservazione che è più una curiosità, diciamo, parlo da un po' ignorante nella materia, perché mi siamo tutti, eh? Quindi siamo tranquilli. Mi occupo di tutt'altre tematiche. Però, all'inizio citato il teatro di lotta del periodo di Bimar, che, diciamo, poi accompagna la prima metà del Novecento con figure quali Prct, per arrivare banalmente anche a un contemporaneo di Popò. E lei trova delle analogie? Sì, premio Noell, una... diciamo, questo concetto di politicizzazione che abbiamo visto appunto in autori come Aristofane e se vi sono appunto delle analogie con il
teatro politico del Novecento. Va bene. Sì, infatti è giusto. S lineare questo. Io sono stato sommario perché puntavo ma Brecht, in quello scritto in cui dice sostanzialmente partiamo da Aristofane, lo dice abbastanza chiaramente. E poi il teorico della cosiddetta rottura della quarta parete, no, si dice teatro epico, grandissima trovata, eh? Difficile che dimenticato. Secondo me, razionale al massimo. Proprio uno degli autori che hanno segnato la nostra intelligenza, per fortuna, usa l'aggettivo gastronomico per dire proprio la cosa più gastronomica, l'esatto contrario del teatro epico. Ma il teatro epico è una moderna riproposizione della parabasi. La parabasi
è il teatro e... ecco, interrompiamo la finzione e parliamo direttamente. Quo. E per lo più parliamo direttamente di politica. Quindi è evidente che loro, lui certamente, ma credo anche Pis, Scatoli, abbiano riflettuto su quell'esperienza che è unica, perché poi dopo non c'è più il quasi inutile Menandro, no? Con tutto il rispetto per Menandro. Ma insomma, se ne poteva fare a meno. Io continuo a scoprire commedie una più triste dell'altra, ma speriamo che abbia avuto successo al tempo suo. E poi il teatro romano ha lavorato sulla commedia media nuova, eccetera. Cambia tutto, cioè quell'esperienza dell'arcaica è
rimasta unica. E quindi è stato notevole come il teatro politico del Novecento, a ridosso di un'orgia di tradizionalismo retorico, teatro inim mistico, eccetera, abbia ripreso quel modello per sfasciare, diciamo, l'arte borghese. No, no, poi ovviamente non è mai diventata un'arte di massa. Nel mondo sovietico è stato molto presente questa volontà del teatro che parla direttamente di politica. Bakowski incrementare la frequentazione dei teatri da parte del proletariato. Non si può dire che sia la stessa cosa di Atene, ma anche per ragioni di dimensione, no, di strutture materiali. Però ci sono stati alti e bassi, no? Negli
anni '20, il teatro russo rivoluzionario parla a tutti. No, ha una forza dirompente, poi diventa poliografico commemorativo, come sempre succede; poi, poi c'è il disgelo, no? C'è il disgelo perché c'è il gelo prima, no, se non ci sarebbe dis... Negli anni '30, poi la celebrazione della guerra. Mi riferisco alla realtà sia letteraria che teatrale russa nella Germania democratica, come si definiva, poi chiamata dell'est. Ma nel tempo della guerra fredda vien chiamata "la zona di massimo disprezzo", perché era la zona di occupazione sovietica delle quattro zone, no, del '45. Nella Repubblica Democratica Tedesca che fu un'esperienza
importante, che se ne dica, PR ha investito tutte le sue energie per far rinascere un teatro politico, no? Berlin Transam che riprendeva il filo di Maïmard, no? E ma anche i nostri Streler è andato lì a imparare tantissime cose. Dall'esperienza di PR è diventato un teatro di massa in certi momenti. Forse sì, poi lui è morto giusto in tempo per non cominciare a soffrire. No, è morto poco prima del '56, no? Ha visto il '53, che a Berlino fu drammatico, ma è morto prima del disastro finale del '56. È stato un punto fermo, c'è poco
da fare. Quando io ero un giovanotto andavo all'università. Paolo Chiarini, che insegnava il tedesco da noi, che era uno dei migliori conoscitori di Brecht in Italia, non dico chi, ma abbiamo fatto anni di tedesco soltanto su pres. E va bene. Abbiamo imparato un sacco di cose. Perché? Perché ancora in quegli anni, parlo del 1959-60... Pres era nella cultura di sinistra, non soltanto diciamo partitica, molto presente, considerato un esperimento aperto da riprendere. Eh, i nostri studiosi Aristofane dovrebbero ricordarselo, più che altro per ingallsirsi e convincersi che hanno un grande autore davanti, non soltanto un insieme di
problemi testuali che poi vanno affrontati. Lei volev dire una cosa? Sì, in realtà la mia domanda è solo da quello che abbiamo detto finora e però stavo riflettendo, parlando di Aristofane, su quanto di utopico e quanta utopia circoli in tutte le sue opere. Io ho iniziato a leggere il suo volume in Aristofane. Sì, esatto. E ma perché dice utopico? Perché è un bel aggettivo, leggere il suo volume. Mi incuriosiva questo, quella che lei chiama utopia urbana, utopia di origine urbana, rappresentata dalla commedia di Aristofane. Parte. Se capito, da appunto preciso. Cioè che il potere di
Atene negli anni di Aristofane era bellicista, e quindi di qui l'utopia della pace che circola, per esempio, nel "Carnesi" e nella "Pace". Appunto, ed è utopia anche la prima parte dei "Due ci"; poi la seconda. Ecco, da una lettura utopica si passa a una lettura politica, che è via della fuga della città verso una città ideale e utopica, anche la e le TR ause, eccetera. Ecco, la mia curiosità era questa: mi chiedevo quando si arresta in Grecia questo filone e semmai si arresta. E si arresta con l'ironia e con la comicità di Aristofane oppure continua?
Dico in Grecia, lasciando da parte gli stoici e pure i latini. E mi chiedevo se ci fosse qualche notizia. Ecco, se è genere un filone che ha goduto ancora di una qualche fortuna. Non dico l'utopia evasiva, quella del paese del Bengol, paese della cagna, che è nella commedia atenese di V secolo, dei frammenti. Quindi ha goduto di una qual... per esempio, Fer Cate, non viene in mente. E niente, la mia curiosità, ecco, era un po' questo. Cioè l'... Sì, vè, noi usiamo la parola utopia, va bene, Platone non avrebbe mai accettato che si definisse utopia
la sua proposta politica; per lui è una cosa che si deve tentare di realizzare. Ci ha tentato, eh, più volte, però certo dice anche: «È un'idea forza, la Callipolis». Movimenti intelletuali o pratici, aspiranti ad un riordino radicale della società, noi li intravediamo per quest'epoca risalente, tutto sommato, dal secondo libro della Politica di Aristotele, no?, che ne parla molto ostilmente, proprio in maniera sempre molto critica. Da Platone medesimo, al quale destina critiche aspre, non sempre con realtà di particolare livello; alcuni sono molto banali. Colpisce il fatto che per Aristotele, nella Poetica, la commedia perfetta è Menandro;
cioè la commedia che ha la yambi idea, cioè la violenza giambica dell'attacco alla persona, eccetera. Considera un fenomeno deteriore, ed è interessante il fatto che detesti l'utopia e detesti l'aria come genere comico. Parte non ha camuffato menomamente i suoi punti di vista, i suoi atteggiamenti. Non tutte però queste, diciamo, esperienze che Aristotele ha messo in esse conosciamo in minima parte, per le ragioni che sappiamo; vanno necessariamente ricondotti sotto quella categoria. È evidente che gli "Uccelli", che molti adorano come la commedia perfetta, no? Gennaro Perotta, per esempio, un notevole critico italiano, sempre considerato "Uccelli". Massimo Giro
leg, è chiaro che fanno capo ad un'immagine di extramondo, dove finalmente tutto quello che accade sulla terra non accade; c'è una spinta concreta. No, la data ci aiuta e capiamo che la Atene invivibile dei processi del 415 è l'antefatto no di quella scelta; però la città degli "Uccelli", delle "Nuvole" è palesemente una trovata utopica, per il fatto stesso che quel luogo non esiste. Se vogliamo usare il termine di Tommaso Moro, nel caso delle commedie contro la guerra. No, lì già è un po' diverso, perché è vero che sono controcorrente in maniera... non dico inefficace, perché
nulla è inefficace, ma i cui risultati si vedono molto dopo e magari per cause che non sono riconducibili alla propaganda attuata dalla scena. È vero, però c'è da considerare un elemento che spesso sfugge, e cioè che quella guerra è un unicum, cioè nessuna guerra. Tucidide ha teorizzato che è un'unica guerra durata 27 anni; va bene, han buone ragioni per sostenerlo. Ma a rigore, altri non pensavano questo, pensavano che la guerra decennale fosse finita con la pace di Nícias, che poi forze politiche, sia spartane che ateniesi, hanno lavorato per delegittimarla e poi violarla. E dopo alcuni
anni, essenzialmente per l'iniziativa ateniese di creare un altro fronte, Siracusa, quindi con un nemico lontano all'occidente, si è riaperto il conflitto ed è durato altri 10 anni. Nel 413 formalmente viene denunciata la pace di Nícias, che di fatto non esiste più già da qualche mese prima, no? Da quando Sparta manda Gilippo a Siracusa, praticamente si accende la guerra tra Atene e Siracusa e quindi in guerra. Dura fino alla capitolazione nel 404, quindi sono almeno due blocchi di 10 anni sicuri e in mezzo c'è tutta quella vicenda. Ah, è un unicum, nessun altro conflitto ha avuto
quella durata. Quindi, l'elemento che rende esaspera una parte non piccola della popolazione, quella più direttamente danneggiata, è una guerra che non finisce più; non si capisce perché. Non so se mi spiego. Né dopo sono avvenute guerre simili. Tucidide un pochino marmaglia quando dice le guerre persiane: due battaglie navali, due terrestri; finita. Questa è la guerra lunghissima, eccetera, eccetera. È vero, ma mentre è vero sul piano storiografico poi ha un risvolto, diciamo, pratico-politico, che è lottare per fermarla, per interromperla in qualche modo; era il compito principale che si davano tutti quelli i cui interessi venivano colpiti.
E non sono soltanto i piccoli contadini; sempre lo stesso Tucidide dice in un capitolo del secondo libro, prima di parlare della sconfitta di Pericle, che non viene... Rieletto viene subito portato sotto processo, poi morirà, che anche i signori avevano sì grandi proprietà fuori; quindi il danno era minore per loro. Però anche per loro il danno della guerra era notevole. Tant'è vero che poi sono i protagonisti di quella tattica che si è poi fonte per chiamarlo con quel nome: esalta. Siccome non siamo un'isola, possiamo aprire porte al nemico; e così finisce la guerra e finisce la
democrazia, che vanno insieme. E questo è un disegno che hanno quelli che poi faranno il tentativo del 411, per esempio, no? Quindi c'è una massa notevole che non la vuole, questa guerra; quindi parlare contro la guerra dalla scena non è così. Il sogno di uno che parla dell'impossibile è l'oggetto del contendere in una posizione difficile, perché chi va poi a votare, a eleggere gli strateghi, elegge tipi come Cleone, i quali evidentemente si fanno valere in un collegio di strateghi anche quando hanno accanto altri che la pensano diversamente. Quindi tutta quella parte, diciamo così, antibcista, come
si può chiamare, io la collocherei non tanto sul versante utopico, anche se poi la pace finisce con le scene della pace bellissima, no?, che ha fatto tanto esaltare gli studiosi. Trigeo, no?, che fa festa. E vabbè, quello è il lato spettacolare, se vogliamo anche da paesi di cucagna. Però la lotta per fermare questa guerra è una cosa seria che ognuno fa con le armi che ha, con gli strumenti che ha. E poi c'è il versante critica [Musica] dell'angus mentale della democrazia, no?, i cui limiti sono quelli che il teatro, nelle sue due funzioni, tragica e
comica, si sforza di fare emergere, mentre gli oratori che vanno alla tribuna a fare l'epitafio hanno il compito di dire: "Siamo i migliori! Che bello! Abbiamo vinto tutte le guerre! Il nostro regime!" Il teatro non fa che mettere in discussione tutto questo. E quindi sì, Toille diceva, scriveva: "La democrazia ateniese è un'aristocrazia piuttosto larga", no?, in cui il suffragio è riservato ai cittadini pleno jure, che non sono un'elite ristretta, però sono un'aristocrazia rispetto a una massa di esclusi. Lui parla di schiavi e meteci; si dimentica le donne. Va bene, questo direi che molto tardi ci
si è accorti di questo fatto. Ma nel mondo dei filosofi, anturage platonico, anurag di Epicuro, nel mondo ruotante intorno a comici come Aristofane, che poi erano intrinseci a questi ambienti intellettuali, il problema veniva messo in luce con forza. Le eroine di Aristofane sono tutti personaggi positivi; anche Pasàg, che è la delle Clese Azzurre, è un personaggio positivo. Il fatto che poi il comunismo che lei vuole instaurare fallisca perché c'è l'egoismo individuale, quello che non vuole mettere i mobili all'ammasso perché se li vuole tenere, corre a mangiare il pasto comune, poi, la comunanza dell'eros crea degli
ingordi pazzeschi. Quello fa parte anche del comico, naturalmente. Però Prago ha delle grandi idee e mette in riga quelli che non sono d'accordo. Va bene, quindi insomma c'è questa apertura a un mondo che la democrazia atenese ha ignorato del tutto. Si dice sempre Sparta; certo, le donne non diventano né efori né re, però hanno un prestigio sociale enorme, che ad Atene non hanno assolutamente. Vabbè, un po' importante all'interno della commedia di Nuvole è occupato dai filosofi. Ecco, e io ho sempre interpretato, magari semplicisticamente, la posizione di Aristofane come assolutamente volto allo screditare i filosofi. Sì,
anche quando parla del discorso buono e del discorso cattivo. E appunto questo di cos logos e adicos logos, sino a quando mi sono scontrato con la lettura di Mario Steiner, il quale dice che è possibile leggere di cos logos e adicos logos alla luce del passo della retorica di Aristotele in cui si parla di ektòn logos e kāyon logos, che traduce come minore capacità di conoscenza e maggiore capacità di conoscenza. Dicendo questo, afferma che vi è una sofistica che ammette la possibilità, dopo un primo livello, diciamo, di conoscenza relativista, di unire più teste e di
arrivare a una conoscenza superiore. E bene, in questo, la possibilità di una sorte di riabilitazione della sofistica all'interno delle Nuvole che io non riesco a vedere. Lei riesce a vedere? No, studioso, molti meriti; poi si è occupato sia di filosofia antica sia anche di teatro, perché le due cose poi sono spesso molto vicine. Questa teoria mi pare molto tirata per i capelli; lui ha fatto, o in parte, son visti per la nuova Italia, no? Sì, li conosceva bene, per carità, perché è debole questa ipotesi. Perché la trama e la ragione per cui Filippide si avvale
di questa nuova competenza, no?, di una dialettica che capovolge ciò che parrebbe giusto sconfiggendolo, ha un obiettivo strumentale, cioè quello di esercitare una sopraffazione. No, quindi non c'è l'ombra di positività in questa invenzione che ovviamente ha di mira non tanto Socrate, perché il Socrate alle Nuvole poi è Anassagora, sostanzialmente, no? Le cose che gli vengono addebitate sono ascrivibili ad Anassagora. Va bene, che è un Socrate all'anno 423; però, essendo egli nato alquanto prima, 469, è già un uomo fatto. Nell'apologia Socratica, quella platonica, dice di sé che ha incominciato con Anassagora; lo dice anche nel Fedone.
Però nel 423 è un'altra persona; non è più l'Anassagora. Invece, siccome Anassagora è stato a suo tempo il bersaglio dell'ateniese medio bigotto che vede in lui l'ateo, il non ateniese, l'amico di Aspasia, donna peccaminosa, eccetera, eccetera, allora farne una specie di epigono di Anassagora va bene per metterlo in cattiva luce. No, questo è però c'è anche sottinteso il passaggio di Gorgia da Atene, no?, che fece scalpore col virtuosismo suo di poter dimostrare una tesi, anche l'opposto, con uguale dovizia di argomenti. È vero. Quindi ciò che viene bersagliato con adicos logos, ecc., è quella roba lì;
disprezzo per questa gente che si faceva pagare. No, non mi convince per... Va bene, rispetto alla, diciamo... Al ritratto di Aristofane come compagno di strada, quindi come intellettuale, anche consapevole di svolgere una certa funzione politica, geloso della propria indipendenza, dunque non legato fino oltre un certo limite, mi veniva da porre questa figura in relazione all'intellettuale invece organico, categoria più certa di altri tempi, diciamo. Ma mi chiedevo se questa distinzione, parlando da non conosciuto, ovviamente, possa essere in qualche modo valida per i modi di attenuare; cioè c'è, si può riscontrare, questa... Io sono prudente, almen credo
di esserlo, magari mi sbaglio. Quindi le categorie le uso in punta di piedi. Compagno di strada? È espressione di Trotsky, no? In riferimento a una precisa realtà di quegli anni, del rapporto con gli intellettuali attratti, ma non del tutto, dalla rivoluzione, eccetera. Avevano in mente, forse, Barbi, no? Barbi, discorso... uali un pfl, praticamente parus, è stato molto vicino al pcf, eccetera. Organico, visto che mi fa questa domanda, che è una domanda pesante, nel senso che ha molto peso dentro. Io sarei portato a fare una superficiale osservazione: se proprio vogliamo adoperare una categoria di questo tipo,
la persona che sembra potersi collocare è Erodoto, che, ve di caso, non è un ateniese, però è talmente dentro la politica periclea che va addirittura a Turi a fondare la colonia panellenica che Pericle ha voluto piazzare in Occidente. E Pericle aveva in mente Turi non per far piacere a noi e quindi dire che Erodoto è turios, la lezione giusta, non Ricardus, ma perché aveva in testa quel drang verso Occidente che non ha potuto attuare, ma che ha trasmesso come eredità politica ad Alcibiade, no? L'idea di colpire Siracusa per finalmente cacciare i cartaginesi dalla Sicilia e
estendere l'impero ateniese anche nella parte occidentale del Mediterraneo. Che poi questo è il succo della questione, no? Per cui sembra un pazzo Alcibiade, come viene presentato, nella sua ostinazione a voler colpire Siracusa, ma quello è un'antica idea periclea, che l'impero deferisce se non si amplia. Perciò interviene in Egitto quando c'è la ribellione di Inaro contro i Persiani ed è un disastro, e punta alla Sicilia, però non fa in tempo, perché intanto precipita la guerra con Sparta. Ora, Erodoto è quell'uomo, l'ho detto poco fa, credo all'inizio della nostra chiacchierata, che pur non essendo ateniese interrompe la
narrazione della vicenda di Serse invasore per dire: "State attenti all'Impero, siete tenuti a mantenere lealtà, perché la vostra libertà è figlia dell'Impero", la vostra di voi Greci, che non ce la fate a sopportare il tributo, le navi e tutto il resto. C'è una scelta abbastanza pesante, eh? E se noi, come ho detto all'inizio, leggiamo la dissacrazione di quell'argomento che Tucidide si compiace di mettere dentro il dialogo melio-ateniese, effettivamente Erodoto è uno che difende gli Alcmeonidi dalla taccia di aver collaborato coi Persiani, ma lo deve ammettere, però cerca di ridimensionarlo, fa un monumento a Clistene, che
è l'antenato, diciamo, il capo della stirpe, oltre che politicamente, anche dal punto di vista familiare. Difende l'impero quando è ormai malvisto, si imbatte nell'impresa di Turi. Quindi perfetto, ma non è ateniese. Ma succede spesso, eh, succede spesso! I rivoluzionari più coerenti sono quelli venuti da fuori. No, no, è successo anche nel mondo sovietico: grande insofferenza per... però i militanti che scappavano dal fascismo, scappavano da altre parti, erano quelli che ci credevano di più, fino in fondo. Succede. Allora, stiamo facendo dei paragoni un po' spropositati e metaforici, però visto che lei mi fa una domanda così
pungente, io penso di non dire una stupidaggine colossale. Ho spesso pensato di Erodoto in questi termini, però non mi è mai venuto il coraggio di dire un intellettuale organico, eh, né lo dirò da domani in avanti. Però, usando queste categorie un po' schematiche, effettivamente la sua è una scelta di straordinaria coerenza, sempre soltanto in quella direzione. Non abbiamo parlato molto di Sfente, ma forse non... diciamo... no, no, vabbè, è un grande problema chi lui fosse veramente, ma lasciamo perdere. Credo di dovervi ringraziare, soprattutto per la pazienza assoluta che avete dimostrato: tenacia, spirito di sacrificio, un...
come si può dire, il Lòcos pîtan ates, no? Che... una delle truppe speciali di Sparta, voi siete un Lòcos pîtan ates. [Musica] [Applauso] Complimenti.
Related Videos

1:26:31
LUCIANO CANFORA - CHI HA UCCISO LA DEMOCRA...
Circolo Metafisico
143,709 views

1:41:25
Moro - Presentazione del libro di Massimo ...
TreccaniChannel
30,063 views

27:12
Giuseppe Conte - Intervista a “Che tempo c...
MoVimento 5 Stelle
1,242 views

1:35:41
Luciano Canfora e la crisi politica ateniese
Università del Piemonte Orientale
103,339 views
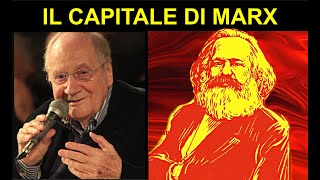
1:07:31
✨ CARLO SINI: IL CAPITALE DI KARL MARX 📖 ...
DANTE CHANNEL 📺
19,436 views
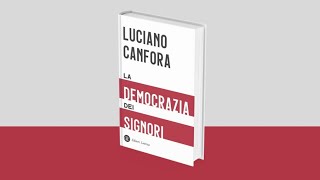
1:34:41
LUCIANO CANFORA - La DEMOCRAZIA dei SIGNORI
Circolo Metafisico
37,636 views

45:25
Luciano Canfora - Democrazia e oligarchia ...
Pandora Rivista
98,349 views
![OTTAVIANO AUGUSTO - raccontato da Luciano Canfora [2015]](https://img.youtube.com/vi/2uY6XurVusY/mqdefault.jpg)
51:33
OTTAVIANO AUGUSTO - raccontato da Luciano ...
Circolo Metafisico
21,628 views

1:36:09
Il FASCISMO e il COMUNISMO - raccontati da...
Circolo Metafisico
82,404 views
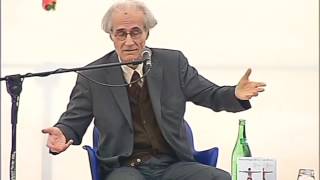
1:14:37
Luciano Canfora: "L' eterna lotta tra vero...
Dialoghi di Pistoia
128,662 views
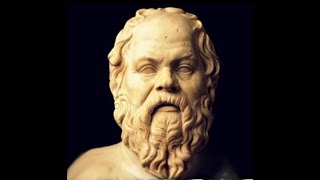
4:57:05
🔴 ✦SOCRATE✦ Raccontato da Luciano Canfora...
Ayka
75,139 views

1:00:51
LUCIANO CANFORA RACCONTA CICERONE e SALLUSTIO
Circolo Metafisico
11,449 views

1:20:48
Odifreddi: i mondi perduti (Unione Sovieti...
Piergiorgio Odifreddi
184,046 views

49:12
STATI Uniti d'EUROPA? IMPOSSIBILE - Alessa...
Vassalli di Barbero (ORIGINALS)
199,886 views
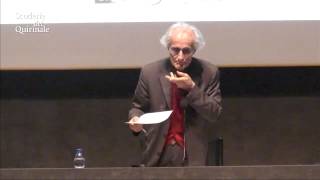
1:19:46
Incontro con Luciano Canfora - La presa de...
Scuderie del Quirinale
143,977 views
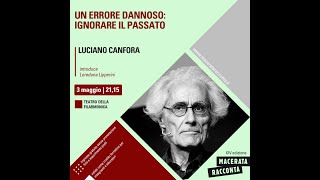
1:13:50
Luciano Canfora - UN ERRORE DANNOSO: IGNOR...
Macerata Racconta
36,940 views

1:22:36
SALLUSTIO, CATILINA E CONCETTO MARCHESI - ...
Università dell'Età Libera - Pesaro
16,648 views
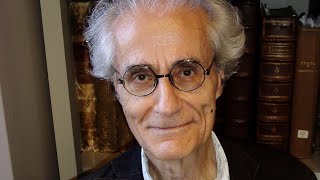
1:13:41
La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cr...
Club di Cultura Classica "Ezio Mancino" APS
32,879 views

1:09:03
Luciano Canfora e Dario Fabbri | Sotto la ...
Fondazione Circolo dei lettori
110,266 views

40:55
Servi e schiavi - Barbero risponde (La7, 5...
B.S.
3,545 views