L'ascesa del Nazionalsocialismo: cosa andò storto?
1.48M views3989 WordsCopy TextShare

Nova Lectio
Il mio Podcast "Storie di Geopolitica" (sulle principali piattaforme di podcasting): https://open.sp...
Video Transcript:
Com’è potuto accadere? Ce lo siamo chiesti molte volte negli ultimi novant’anni, ma mai siamo riusciti ad avere una spiegazione sufficiente. Per descriverlo si è fatto ricorso a frasi emblematiche: enigma del consenso, morte della democrazia, l’irresistibile ascesa.
Ci siamo messi a studiare l’essenza del male, quasi fosse un organismo, e lo abbiamo trovato inconsapevole e banale, un imprevisto quotidiano. Abbiamo ascoltato le masse, osservato la loro psicologia tramutarsi in follia. Abbiamo più volte vivisezionato i totalitarismi quasi fossero scherzi della natura, eppure sembra tutto inutile e limitato quando si arriva alla voce nazismo.
Nel nostro immaginario Hitler ha assunto sempre più le dimensioni di un Sauron, di un Voldemort. Tutto è finito eppure anche solo il ricordo mette a disagio persino noi che apparteniamo a tutt’altra generazione perché quei due signori, Sauron e Voldemort, ci insegnano che i mostri possono sempre tornare. Per carità, non sarà questo video a fornire le risposte, né tantomeno a sconfiggere il male, ma proveremo lo stesso a capire cosa è andato storto in Germania quel 30 gennaio 1933.
Tra le argomentazioni più inflazionate e periodicamente rispolverate per giustificare l’ascesa al potere del nazionalsocialismo, troviamo sempre quella voce persistente che ci racconta di un partito forte, vittorioso alle elezioni e quindi legalmente riconosciuto dai tedeschi come guida del paese. Questo è vero, ma solo in parte: dopotutto non c’è bisogno di sottolineare che una vittoria elettorale non giustifica l’instaurazione della dittatura e la repressione violenta di ogni forma di dissenso. Sì, Adolf Hitler fu a tutti gli effetti nominato cancelliere della Germania (vale a dire capo del governo) il 30 gennaio 1933, ma per comprendere come si sia arrivati a tanto occorre fare un salto indietro di oltre dieci anni.
La fine della Grande guerra aveva segnato per l’impero tedesco una cocente disfatta. Come spesso capita, chi non si capacita di una sconfitta o semplicemente chi non sa perdere, pur di non ammettere la sua debolezza inizia ad individuare alibi e giustificazioni o, meglio ancora, precisi colpevoli. La propaganda nazionalista e militarista avrebbe così presentato la sconfitta come il frutto di un tradimento interno (la cosiddetta pugnalata alla schiena), una congiura ordita non solo dai soliti elementi ebraici (e non è certo una novità) ma anche dai bolscevichi nuovi di zecca, dal momento che era appena nata la Russia dei soviet.
Proprio sul più bello questa congiura quindi avrebbe determinato l’ingiusta e rovinosa sconfitta. Si trattava però di una farneticazione, buona soltanto a coprire la dura realtà: la crisi interna e militare dello stato tedesco, delle sue diseguaglianze sociali e del suo sistema di governo vetusto e inadeguato che imponeva durissimi sacrifici ai lavoratori, aggravata dai tanti errori strategici nella conduzione della guerra, era latente da tempo. Le pesanti responsabilità non potevano che gravare sulle spalle della dirigenza politica e militare, la quale pensò bene di “scaricarle” su qualcun altro, ricorrendo alla sempreverde teoria del complotto, per non assumersi il peso di mancanze ed errori.
Lo scaricabarile ad ogni modo ebbe molta fortuna- poi dicono di noi italiani…- perché forse conveniva un po’ a tutti sgravarsi la coscienza, tanto che grazie alla martellante propaganda si radicò nel sentire comune e in larghe fette della popolazione. Ogni fazione poteva contare sulla sua, ma fu soprattutto quella di matrice nazionalista che si sarebbe scagliata con più veemenza contro le durissime e indubbiamente ingiuste condizioni di pace imposte alla Germania dai trattati di pace di Versailles del 1919, che in sostanza indicavano la nazione come l’unica responsabile del conflitto. Se vogliamo anche la stessa Versailles fu un’operazione di scaricabarile.
Si trattava comunque di questioni sulle quali i nazionalsocialisti faranno a loro volta leva per alimentare crisi e malumori, promettendo di restituire alla Germania dignità di grande potenza, ingiustamente umiliata dalla comunità internazionale. Le clausole di Versailles erano effettivamente molto pesanti e contemplavano la perdita di tutte le colonie, l’occupazione di parti del territorio europeo, una sostanziale smilitarizzazione con il divieto della coscrizione obbligatoria e la limitazione delle forze armate a non oltre le 100. 000 unità; ma soprattutto le clausole del trattato imponevano il pagamento di pesantissime riparazioni di guerra, che di fatto condannavano il paese a una durissima crisi economica e forti restrizioni, sfociate in fame e disoccupazione.
Più che un trattato di pace sembrò una vendetta degli antichi rivali, che avevano finalmente trovato un modo per tagliare fuori l’avversario. Ad ogni modo la fine della guerra coincise con il crollo della monarchia, circostanza che non risolse poi di tanto la situazione. Il sovrano abdicò e abbandonò un paese attraversato da un clima di autentica guerra civile: un vero e proprio scontro armato fu scatenato dal vano tentativo di instaurare nel paese una repubblica sul modello russo promosso dai comunisti della lega spartachista, contrapposti alle destre conservatrici e al partito socialdemocratico moderato.
Proprio L’SPD, il partito Social Democratico, aveva assunto il governo, colmando il vuoto di potere creato dalla fuga del Kaiser e dando vita a un governo provvisorio con il sostegno delle forze conservatrici, uniti dalla comune volontà di “scaricare” sulla sinistra la responsabilità della gestione della sconfitta. L’obiettivo ufficiale era dare vita ad un nuovo stato democratico e repubblicano, poi chiamato repubblica di Weimar dal nome dell’omonima cittadina dove fu approvata la nuova costituzione. Alla fine, dopo varie tensioni, gli spartachisti furono sconfitti dall’alleanza tra destre e socialdemocratici.
Non fu però un processo molto pacifico perché i capi della rivolta vennero uccisi e il tentativo rivoluzionario represso nel sangue anche perché il governo non aveva esitato a ricorrere bellamente agli “aiuti” di gruppi paramilitari formati da reduci di guerra, chiamati Freikorps, di chiara ispirazione nazionalista, che più tardi sarebbero confluiti nelle formazioni paramilitari nazionalsocialiste (soprattutto nelle SA). La fine del tentativo insurrezionale risolse un problema, ma ne lasciava aperti molti altri, a cominciare dall’endemica debolezza del nuovo assetto repubblicano, che più tardi avrebbe spalancato le porte ai simpatizzanti nazionalsocialisti. Infatti, il nuovo regime democratico non era partito col piede giusto ed era già malvisto da tanti: le forze nazionaliste e militariste, che continuavano ad alimentare la retorica di una sconfitta tedesca dovuta ad un complotto interno, consideravano pur sempre la repubblica come una sorta di ostaggio delle forze sovversive; per ragioni opposte, quelle rivoluzionarie di sinistra volevano abbatterla per creare un regime bolscevico.
Da un punto di vista squisitamente politico, la neo repubblica era molto fragile, tant’è vero che prima ancora dei malumori e delle opposizioni, il governo doveva fare i conti con la sua stessa struttura. Il regime costituzionale era una sorta di via di mezzo tra presidenzialismo (con un capo di stato eletto dal popolo) e parlamentarismo (con un governo doveva avere la fiducia dei parlamentari), che alla lunga dimostrerà tutta la sua inadeguatezza; il mio vecchio professore di storia l’avrebbe definito con un aggettivo: farraginoso. Come se non bastasse, la Repubblica di Weimar doveva vedersela con una preoccupante frammentazione politica, dal momento che la legge elettorale di tipo proporzionale non permetteva la formazione di maggioranze stabili.
A complicare le cose, l’assenza di governi forti e autorevoli acutizzò il problema delle onerose riparazioni di guerra cui non si sapeva fare fronte, che bloccarono a lungo ogni tentativo di ripresa. Insomma, la ricetta perfetta per un disastro. Non dobbiamo dimenticare che in tutte queste difficoltà la Germania era comunque osservata con occhio particolarmente attento dalle potenze vincitrici che, lungi dall’aiutarla o dal mostrarsi disposte ad una revisione di Versailles, non si facevano scappare nulla.
Con dispiacere dei tedeschi, le nazioni più intransigenti con il nemico sconfitto furono Francia e Belgio, che pretendevano il pagamento puntuale dei debiti. Il governo di Berlino, non volendo tagliare le spese per timore di accrescere i disagi della popolazione, pensò di risolvere il problema della liquidità stampando carta moneta, aumentando così la massa circolante. Dalla padella alla brace, perché questa scelta improvvida scatenò però una terribile spirale inflazionistica, che non fece che impoverire ulteriormente le grandi masse.
Il marco perse praticamente ogni valore reale e la Germania di conseguenza non fu più in grado di onorare le riparazioni di guerra. Ma per capire meglio il meccanismo economico dell’iperinflazione vi lascio un minutino in compagnia di Edoardo di Starting Finance che gestisce un canale interamente dedicato all’economia e alla finanza e sicuramente saprà illuminarci meglio. Nonostante la Repubblica di Weimar fosse dilaniata dall’iperinflazione, Francia e Belgio non si mostrarono molto comprensivi e reagirono occupando la Ruhr (1923), regione di confine franco tedesca, all’epoca ricca di industrie e miniere strategiche, con l’obiettivo di incamerare le risorse per la riscossione delle riparazioni di guerra.
L’occupazione di una parte del proprio territorio esasperò l’opinione pubblica tedesca, scatenando l’ostilità delle forze nazionaliste contro l’atto di forza straniero e dando vita a forme di resistenza passiva da parte della popolazione. Tra le forze nazionaliste ed estremiste che contrastavano la fallimentare azione di governo figurava un piccolo partito nato in Baviera, il cui leader indiscusso era un ex caporale di origine austriaca, Adolf Hitler. Il partito a cui si riferiva era stato fondato nel 1919 col nome di partito dei lavoratori tedeschi, DAP, ed era capeggiato da Anton Drxler, all’epoca un fabbro nel settore ferroviario.
Hitler vi era entrato quasi per caso con la tessera numero 555, facendosi subito notare come oratore nei comizi organizzati nelle birrerie bavaresi, divenendone in breve tempo il leader assoluto. Convinto nazionalista e antisemita, nel 1920 Hitler lo ribattezzò partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (che per comodità da ora in avanti pronunceremo NSDAP), e delineò un programma politico di chiara ispirazione nazionalista, antidemocratica, pangermanista, antisemita, antibolscevica e vagamente socialisteggiante (in realtà questi ultimi aspetti del programma saranno progressivamente accantonati negli anni). L’NSDAP si trattava, per la verità, di uno dei tanti micropartiti presenti nel panorama politico tedesco, privo di qualunque peso significativo sino alla fine degli anni Venti.
L’unico intervento politico di rilievo sarebbe stato il fallimentare colpo di stato in Baviera (il celeberrimo putsch della birreria di Monaco), organizzato nel 1923, che si risolse in una disfatta totale: Hitler fu incarcerato e il partito venne sciolto e dichiarato fuori legge. Poteva essere la fine della per ora fulminea parentesi politica di Hitler e del partito, ma l’iniziativa, benché fallimentare, avrebbe regalato una certa visibilità al futuro Fuhrer, che si vedrà depennata dai giudici gran parte della pena e che nel frattempo avrebbe approfittato della prigionia per scrivere il suo libro Mein Kampf (la mia battaglia), una sorta di manifesto politico del nazismo. Forse se avessero controllato cosa andava scrivendo in cella non lo avrebbero lasciato andare così presto… Nel frattempo però, grazie alla mediazione americana, inglese e italiana, furono stipulati a Locarno dei nuovi accordi internazionali che da un lato contemplavano appositi piani di ripresa (il cosiddetto Piano Dawes), con generosi finanziamenti statunitensi e la concessione di dilazioni per le riparazioni di guerra, e dall’altro ponevano fine all’occupazione della Ruhr, restituendo alla Germania ruolo e dignità internazionali (garantendone tra l’altro il suo ingresso nella Società delle Nazioni).
Grazie al complesso di queste misure, la Germania avviava così finalmente una nuova fase di ripresa, e il paese poté lentamente risollevarsi. Questa fase di rinnovato sviluppo sarebbe stata guidata dal politico conservatore Gustav Stresemann, figlio di un commerciante di birra e afferente al Partito Popolare. Sotto Stresemann, in congiunzione con le minori pressioni estere, l’economia della Repubblica di Weimar crebbe nuovamente, la disoccupazione e l’inflazione degli anni precedenti furono in buona parte riassorbite, mentre una riforma del marco (garantendo il valore della moneta con le industrie e proprietà terriere) restituì alla valuta il peso perduto.
Sembrava tutto andare per il meglio, ma la crisi del 1929 rimescolò nuovamente le carte. Il crollo di Wall Street mise fine di botto all’indispensabile flusso di aiuti americani, il che precipitò il paese in una nuova e più grave crisi economica, che i governi di Weimar non seppero fronteggiare. Ricordate?
Farraginoso. Una forte disoccupazione e una nuova devastante ondata inflazionistica investirono il paese, annullando i progressi degli anni precedenti. Questa circostanza ovviamente favorì i partiti rivoluzionari di destra e di sinistra che si rianimarono, guadagnando nuovi consensi nella popolazione che era ormai esasperata.
Certo la crisi ci mise del suo, però tutti questi partiti estremisti fondavano il loro consenso su malumori ben più radicati. Non dimentichiamo che la repubblica di Weimar non era mai stata accettata dalle componenti estremiste (nazionaliste e comuniste), che non chiedevano di meglio che vederla crollare e che appoggiavano pertanto le forze politiche antisistema. La storia non si fa con “i se e con i ma”, resta però il dubbio legittimo se in mancanza della crisi mondiale sarebbero mai saliti al potere i nazionalsocialisti: non possiamo escluderlo, ma nemmeno dare per scontato l’opposto.
Limitandoci ai semplici fatti, un’occhiata ai dati elettorali ci spiega molto di quanto la crisi del ’29 riuscì a segnare l’opinione pubblica. Nelle consultazioni del 1928 il partito nazista aveva racimolato solo una percentuale insignificante di voti, tenuto conto che si trattava di una forza politica il cui ambito di azione era limitato praticamente alla sola Baviera. Già due anni dopo, nelle elezioni del 1930, l’NSDAP faceva un autentico exploit, conquistando circa il 18 per cento dei voti e divenendo il terzo partito del paese.
Hitler aveva appreso bene la lezione del fallito putsch di Monaco e ora proclamava di aver messo la testa a posto e di voler arrivare al potere legalmente. Il sistema di Weimar era ormai allo sbando, non sapendo reagire alla nuova crisi, e l’instabilità politica caratterizzò questa nuova fase: in quegli anni, oltre ai problemi economici, si alternarono una serie infinita di governi, guidati da esponenti minori (Stresemann era morto nel 1929) e in pratica si passò da un’elezione all’altra. Caos totale.
Gli esecutivi erano molto deboli e senza una maggioranza di riferimento si tenevano in piedi solo in virtù dei poteri straordinari che la costituzione riconosceva al presidente del Reich, il maresciallo Paul Von Hindenburg. Quest’uomo incarnava in sé tutte le contraddizioni del sistema Weimar. Anziano aristocratico e già comandante militare durante la Grande Guerra, probabilmente fu tra i responsabili della sconfitta.
Come ulteriore paradosso lui, che era il capo di uno stato repubblicano, non celava le proprie simpatie filomonarchiche. Sì esatto: farraginoso. Le continue elezioni politiche videro la crescita inarrestabile del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, che nel 1932 divenne addirittura il primo partito.
Il movimento di Hitler, dichiaratamente nazionalista e antisemita, prometteva la rinascita nazionale, la cancellazione degli odiati trattati di pace e il ritorno della giustizia: molto semplicemente al paese la grandezza perduta! Esattamente come al termine della Grande Guerra, lo sbandierato antisemitismo individuava nel complotto della finanza ebraica un utile capro espiatorio per il malessere generale. Per quanto Hitler potesse apparire convincente agli occhi di un popolo al collasso, anche considerando che le alternative tra comunisti e i partiti di Weimar non sembravano poter offrire maggiori garanzie, risulta difficile ricondurre il suo successo unicamente a quello che oggi chiameremmo populismo.
La sapiente azione di propaganda intercettò indubbiamente il voto di protesta delle masse, ma spiegare solo con questo una crescita tanto repentina non sarebbe corretto. Se andassimo a leggere il programma del partito nel 1920 troveremmo scritti tutti i punti presentati agli elettori negli anni Trenta, eppure prima di questo momento – nonostante la crisi vissuta nel decennio precedente – il Partito Nazionalsocialista aveva registrato un consenso pari a quello di un ubriaco sul palco del Festivalbar… Non mi venivano altri termini di paragone. Per questa ragione, senza negare che ci furono coloro che per disperazione si gettarono tra le braccia dei nazionalsocialisti (e dei comunisti, i cui voti crescevano ugualmente, qualcuno si ricordi dei comunisti, questo elemento da solo non basterebbe a spiegare il successo repentino del movimento di Hitler.
Nazionalsocialisti e comunisti insieme, nelle elezioni federali del 30, si sarebbero assicurati il 31% dei seggi al parlamento. Come sottolineato dallo storico Alan Bullock, i Comunisti dichiararono a chiare lettere di preferir vedere i nazisti al potere piuttosto che muovere un dito per salvare la repubblica di Weimar. Ma a voler male alla Repubblica di Weimar non erano solo i comunisti: tra gli altri c’erano gli importanti centri di potere tradizionali: gli industriali (quali Krupp, Bosch, Vogler, e tanti altri), i finanzieri, i grandi proprietari e gli circoli militari a cui apparteneva lo stesso Hindenburg).
Tutti questi signori non aspettavano altro che sbarazzarsi del goffo (scusate: farraginoso) sistema repubblicano di Weimar, togliendo di mezzo allo stesso tempo tutte le organizzazioni dei lavoratori, avvertite come un ostacolo o un fastidio per le proprie posizioni di potere. L’anti bolscevismo del movimento nazionalsocialista era un’importante garanzia in questo senso, soprattutto nel timore che la crisi potesse scatenare nuove rivolte sul modello spartachista (non a caso, la crescita dei comunisti allertò ulteriormente chi nutriva questi timori. Altra dinamica da favorire l’ascesa di Hitler fu il fatto che non esistesse un partito liberale sostenuto dalla classe media, né tantomeno un interesse comune che spingesse in un fronte unico i socialdemocratici e i centristi.
Divide et impera, anche qui, applicato alla perfezione. Alla luce di ciò, molti tra i personaggi importanti che sostennero Hitler non lo fecero tanto per convinzione, quanto con l’idea di poter strumentalizzare il movimento per i propri scopi, salvo poi toglierlo di mezzo una volta data la spallata finale al regime di Weimar. Come mamma storia ci insegna, si sarebbe rivelato un clamoroso errore di valutazione, ma resta il fatto che nell’immediato questo orientamento regalò ad Hitler appoggi fondamentali, senza i quali difficilmente sarebbe stato nominato cancelliere.
Nonostante il Fuhrer fosse il leader del maggior partito, Hindenburg (al quale spettava la scelta del capo del governo) disprezzava il “piccolo caporale boemo” e furono solo le pressioni di quei circoli a indurlo a nominarlo cancelliere il 30 gennaio 1933. Tra gli uomini che appoggiarono la nomina di Hitler troviamo Franz Von Papen, esponente della classe conservatrice e molto vicino ad Hindenburg: uno dei tanti, lui che fu vice di Hitler nel primo governo guidato dai nazisti, a illudersi di usare il movimento per i suoi fini di potere. Il primo governo Hitler era un gabinetto di coalizione: a parte il Fuhrer, ne facevano parte solo altri due nazionalsocialisti, Herman Goering come ministro della Prussia (il più grande dei lender tedeschi) e Wilhelm Frick in veste di ministro dell’Interno.
Ma Hitler non voleva certo limitarsi a essere il capo di un esecutivo di coalizione. Non era ancora trascorso un mese dalla sua nomina, che il 28 febbraio fu dato alle fiamme l’edificio del Reichstag, il parlamento federale. Ancora oggi si discute se l’incendio sia stato appiccato dagli stessi nazionalsocialisti: quel che è certo è che Hitler ne approfittò subito.
E presentò prontamente al capo dello stato uno schema di decreto, che – paventando un tentativo insurrezionale dei comunisti - in pratica conferiva al governo (di fatto allo stesso Hitler) i pieni poteri. Il ricorso al decreto sull’incendio del Reichstag e alla successiva alla legge sui pieni poteri rappresentò lo strumento giuridico per l’instaurazione della dittatura. Le misure varate (arresti senza mandato, sospensione dei diritti e libertà fondamentali) scatenarono la caccia al nemico politico, a cominciare dagli esponenti della sinistra marxista.
Il 5 marzo si tennero dunque nuove elezioni generali, le ultime formalmente libere, in realtà caratterizzate da violenze ed arresti arbitrari allo scopo di intimorire chi volesse votare un partito che non fosse l’NSDAP. Tutto questo fu la ciliegina avvelenata sulla torta ormai marcia, che diede ai nazisti e ai loro alleati nazionalisti la maggioranza dei seggi. Il primo atto del nuovo parlamento fu l’approvazione della cosiddetta legge delega, che in sostanza assegnava all’esecutivo il potere legislativo, compreso quello di emendare la costituzione.
Scacco matto: esautorato così il parlamento, diventato un guscio vuoto, nello spazio di pochi mesi si succedettero una serie di misure straordinarie che cancellarono ogni residua libertà politica e personale. Si misero progressivamente fuori legge partiti e associazioni che non fossero nazionalsocialiste, mentre radio e giornali vennero chiusi o sottoposti ad una rigida censura governativa (controllata dal ministro Goebbels). A questo si aggiunsero sindacati ed organizzazioni soppresse o inglobate nelle organizzazioni di partito (nacque il fronte tedesco del lavoro come sindacato unico di stato), frattanto che le formazioni paramilitari e la polizia politica si occupavano degli oppositori e si dava avvio alla costruzione i primi campi di concentramento, il primo in assoluto fu Dachau nel 33, all’inizio adibito proprio agli oppositori politici.
Il 14 luglio di quell’anno l’NSDAP fu dichiarato partito unico. Come conseguenza di ciò, aprire un proprio partito diventava reato […] : No Fassino, è reato, non si può. Sempre nel 33 si avviò la trasformazione del settore giudiziario: venne ripristinata la pena di morte per una serie di reati, dall’alto tradimento, al sabotaggio; gli organi di giustizia dei lender furono soppressi e create a livello statale apposite corti (poi chiamate tribunali del popolo) per giudicare i reati politici.
Nell’amministrazione pubblica ci fu l’epurazione di tutti coloro che non fossero politicamente allineati, e si cominciò ad allontanare magistrati ed avvocati di origine ebraica. Nei rapporti con le due maggiori confessioni religiose del paese, la luterana e la cattolica, fu adottata una doppia strategia: collaborazione e ricerca dell’intesa con la corrente maggioritaria delle chiese (a luglio 1933 il Vaticano sottoscrisse con Hitler un concordato, a firmarlo il futuro Pio XII Eugenio Pacelli), mentre per le componenti più restie si fece ricorso alle maniere forti (come avvenne con la Chiesa confessante tedesca). A livello economico furono create una camera nazionale e territoriale, una sorta di luogo di incontro, alle quali presero parte i rappresentanti e gli imprenditori di quei grandi gruppi economici che avevano sostenuto l’ascesa dei nazisti, che come promesso li avevano liberati dalla scomoda presenza dei sindacati e dalla preoccupazione dei diritti dei lavoratori.
Certo come abbiamo detto, avrebbero voluto che anche Hitler, una volta fatto il lavoro sporco, sparisse, ma a questo punto meglio collaborare. L’unica carica importante che restava appannaggio di un non nazista era quella di capo dello stato, il buon vecchio Hindenburg, ma Hitler aveva un piano anche per lui. La questione era particolarmente importante, visto che il presidente del Reich era di diritto il supremo comandante delle forze armate.
Hindenburg era molto anziano (84 anni suonati) e Hitler mirava chiaramente a prenderne il posto. Prima, però, doveva ottenere l’appoggio decisivo delle forze armate, che subordinavano il loro consenso all’ascesa di Hitler alla presidenza all’eliminazione delle SA, formazioni paramilitari rivoluzionare del partito, guidate da Ernest Rohm, vecchio compagno di Hitler. Il progetto di Rohm era di sostituire l’esercito con le sue SA, con lui stesso quale comandante supremo: evidentemente si trattava di un’idea che non piaceva affatto ai capi delle forze armate.
Hitler accettò di toglierlo di mezzo (lo farà in occasione della notte dei lunghi coltelli, il 30 giugno 1934) ed in cambio, quando il 2 agosto 1934 Hindenbug morì, ottenne di riunire nella sua persona la carica di capo dello stato e cancelliere, col titolo ufficiale di Fuhrer e cancelliere del Reich. Di fatto il nazismo era così divenuto l’incarnazione dello stato e la bandiera con la croce uncinata, simbolo del partito, divenne emblema della Germania. Le misure antisemite aspetteranno.
Le leggi di Norimberga saranno approvate solo nel 1935: i nazionalsocialisti erano consapevoli che i tedeschi non fossero per la maggioranza antisemiti, per cui era meglio procedere con gradualità. Nel frattempo, il governo avviò colossali programmi di opere pubbliche e per la riconversione di molte attività industriali verso la produzione siderurgica e bellica (regalando enormi profitti ai generosi finanziatori del nazismo), che consentirono il riassorbimento di molti disoccupati e diedero una grande credito (e consenso) al nuovo regime. Ma questa è un’altra storia.
È la storia di un incubo che aveva ormai preso forma. Un grazie enorme a tutti voi per l’ascolto, e un caloroso ringraziamento anche a tutti i mecenati che supportano questo progetto di divulgazione. Vi suggerisco di dare un’occhiata al video di Starting Finance dedicato all’iperinflazione di Weimar.
Tra l’altro ci sono anch’io a un certo punto, un bel cameo dove approfondisco brevemente le debolezze del sistema politico che purtroppo, per questione di tempistiche, non ho potuto menzionare nel mio video. A presto. Per aspera ad astra.
Related Videos

28:08
Chi ha finanziato davvero i Nazisti?
Nova Lectio
730,755 views

56:36
Come gli Stati Uniti hanno perso la Guerra...
Nova Lectio
1,097,272 views

1:31:09
L’origine della malavita in Italia e nel m...
Geopop
403,893 views

19:57
Come la GERMANIA sta per diventare una SUP...
Starting Finance
175,457 views

38:00
in Corea del Nord non sei mai da solo... 🇰🇵
Nicolò Balini
1,386,339 views

21:57
La droga che rendeva "invincibili" i nazisti?
Nova Lectio
2,337,551 views

20:52
La dottrina del caos di Donald Trump: cosa...
Nova Lectio
193,999 views

34:03
Holpriger Start für Schwarz-Rot: Merz ist ...
ZDF heute-show
1,200,713 views

56:54
L'ASCESA del NAZISMO in Germania
La Storia sul Tubo
398,728 views

32:01
Perché l'Unione Sovietica è crollata?
Nova Lectio
2,535,925 views

1:37:44
La caduta - Cronache della fine del fascis...
La7 Attualità
1,001,581 views
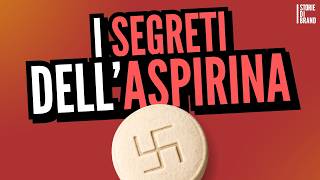
23:30
L'oscura storia dell'ASPIRINA: la pillola ...
Storie di Brand 🚀
185,028 views

25:39
Da Prussia a Grande Germania: l'Impero Ted...
Nova Lectio
773,473 views

29:28
Chi ha rovinato Cuba?
Nova Lectio
1,180,172 views
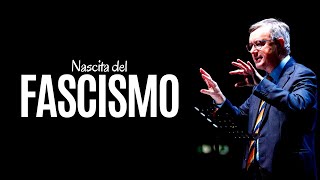
1:12:58
Come l'ITALIA è diventata FASCISTA - Aless...
Alessandro Barbero - La Storia siamo Noi
2,335,633 views

1:03:25
Come le Guerre Jugoslave hanno distrutto i...
Nova Lectio
1,053,969 views

21:43
5 Things to Know About the Jewish People
Fiore
149,993 views

16:38
Hitler non voleva la Guerra? - Alessandro ...
Alessandro Barbero - La Storia siamo Noi
2,197,218 views
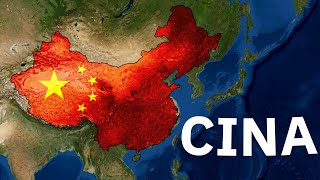
24:02
The Man who Made China a World Power
Nova Lectio
1,152,210 views
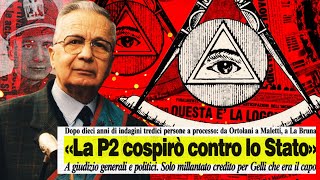
24:45
La P2 di Licio Gelli: la Loggia Massonica ...
Nova Lectio
2,516,345 views