Lezione 1 - Organizzazione dello Stato nella Costituzione italiana
9.12k views10434 WordsCopy TextShare

Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
Video Transcript:
sono alfonso celotto insegno diritto costituzionale a roma tre e sono qui per avviare questo corso sulle autonomie nel sistema costituzionale italiano è un corso pensato per anci quello è un corso pensato per i comuni italiani ed è un corso quindi sulle autonomie però non sappiamo bene che per parlare di autonomie bisogno inquadrarle nel modello costituzionale altrimenti restano solo un pezzo un pezzo autonomo e non si riesce a dare un inquadramento generale del problema quindi partiamo con una prima lezione la costituzione dobbiamo capire che cos'è la costituzione italiana come ci siamo arrivati e il valore che
ha per il modello delle autonomie queste elezioni saranno strutturata in due parti ci sarà una mia introduzione generale poi ci sarà una parte di approfondimento curata da una mia collaboratrice giovanna pistorio che insegna anch'essa diritto costituzionale a roma tre e poi ci saranno delle domande di autovalutazione un percorso con delle domande a risposta multipla affinché lo studente quello che ci sta seguendo possa rivedere i punti essenziali andando a rileggersi queste domande e a risponderle allora come nasce il modello dello stato italiano sappiamo che lo stato italiano nasce formalmente nel 1861 prima prima cosa c'era italia
c'erano gli stati preunitari molti di questi stati erano a dominazione straniera finché poi ma son fatti di storia non di diritto il regno di savoia quindi il regno di sardegna con casa savoia unifica l'italia la unifica giuridicamente con una parte anche di guerra l'operazione dei mille ma la unifica poi giuridicamente con i plebisciti di annessione che cosa accadde il 17 marzo 1861 viene sancita l'unica dita sappiamo che questa ricorrenza 17 marzo ancora si festeggia e in quel momento lo statuto albertino diventa la costituzione del regno d'italia lo statuto albertino era la costituzione del regno di
sardegna e anche gli altri stati italiani gli altri stati preunitari avevano delle costituzioni che erano quella del granducato di toscana o quella del regno delle due sicilie se siete curiosi andate a cercare andate a leggere così capite un po anche quale erano i problemi e gli spiriti che si animavano in quei mesi e in italia comunque il regno di sardegna prende la sua costituzione e la trasferisce al re d'italia sappiamo che la costituzione del regno di sardegna era una costituzione o creata cioè una costituzione concessa quindi una costituzione che il re aveva emanato lui stesso
senza un'assemblea costituente ma proprio per auto limitare il suo potere la parola o creata viene dal francese octroyée e significa concessa gran parte delle costituzioni di quell'epoca in europa sono costituzioni concesse lo statuto albertino era quindi concesso da carlo alberto una costituzione breve un'ottantina di articoli pochissimi principi gran parte dei quali riguardava il renzi le autonomie erano relegate in fondo e avevano soltanto province e comuni perché la base dello stato italiano era organizzata soltanto su province e comuni non c'erano ancora le regioni questo è importante dobbiamo anche ricordare che la struttura aveva il real centro
il re era il capo dello stato il re era non elettivo ma ovviamente ereditario secondo la legge salica quindi secondo la legge della famiglia del sangue il re aveva il potere legislativo perché una legge per essere approvata dovrà essere approvata dalle due camere ma anche dal rap che quindi se non la provava non facevamo entrare in vigore era veramente il centro del sistema il renon presideva il consiglio dei ministi perché c'era un il consiglio dei ministri indicato dal re tutti ricordiamo cavour il primo presidente del consiglio dei ministri però il re era il centro del
sistema ricordiamo infatti storici ricordiamo anche che lo statuto albertino era una costituzione che non prevedeva autore di modifica cioè nulla se diceva sul fatto che potesse essere modificata perché perché in fondo era concessa dal re e quindi era un potere unilaterale era strano difficile prevedere uno strumento di modifiche che cosa accadrà accadrà che per quasi 100 anni resterà in vigore lo statuto albertino e sarà travolto dai fatti storici per questo diciamo che lo statuto albertino era una costituzione flessibile flessibile cioè che poter essere derogata dalle leggi ordinarie infatti pensiamoci bene l'ossatura bertino resta indifferentemente costituzione
del regno di sardegna del regno d'italia e anche del regime fascista cioè fino al 1946 quegli 80 articoli restano lì di fatto sempre meno applicati il regime fascista soprattutto insedierà la dittatura con una serie di leggi intera o dallo statuto questo è un punto importante perché perché quando i costituenti arriveranno a dover scrivere la costituzione dovranno creare dei meccanismi per proteggere la costituzione quindi creeranno delle garanzie costituzionali che sono alla corte costituzionale ma anche il procedimento di revisione costituzionale che poi vedremo meglio in questa lezione cioè la legge ordinaria non può modificare la costituzione la
costruzione diventa rigida rigida significa superiore superiore rispetto alla legge ordinaria tutte le leggi ordinarie devono essere conformi alla costituzione se così non è la corte costituzionale le può annullare anche perché per modificare la costituzione serve quello specifico procedimento l'articolo 138 che poi vedremo nel dettaglio anche con dei limiti l'articolo 139 perché alcune cose non si possono modificare per questa ragione storica la costituzione nasce superiora rileggi proprio perché bisognava proteggerla rispetto ai fatti sport rispetto ai fatti storici cosa che invece non era il tocco lo statuto albertino questo è un punto molto importante ed è un
punto di partenza per inquadrare la costituzione sempre nell'inquadramento della costituzione e quindi della sua primarietà dobbiamo ricordare che la costituzione nasce dalla seconda guerra mondiale nasce dalla resistenza alla fine della seconda guerra mondiale dopo la caduta del fascismo 25 luglio 43 dopo l'armistizio con gli alleati e quindi l'italia che passa come col belligerante con gli alleati l'italia era ancora divisa e due perché amo il regno del sud corretta era prima brindisi e poi a salerno come capitale d'italia al nord c'era la repubblica sociale nel giugno del 44 si stabilisce quella che viene chiamata la costituzione
provvisoria cioè cosa viene detto viene detto che quando si libererà il territorio nazionale si eleggerà un'assemblea costituente e assieme ad essa si deciderà se la forma di stato sarà monarchia con repubblica poi sappiamo che questa idea sarà attuata il 2 giugno 46 e soprattutto il popolo sarà chiamato a votare per due cose perché il voto popolare sarà uno sul referendum istituzionale monarchia repubblica e l'altro invece sarà per l'elezione dell'assemblea costituente l'assemblea costituente e il primo parlamento italiano il primo parlamento della repubblica viene eletto a suffragio universale anche femminile sappiamo che nel 1946 clevo le donne
votano per la prima volta suffragio universale perché le donne non hanno votato nel 1945 per qualche elezione amministrativa quindi per i sindaci ma mai avevano votato per il parlamento anche questa una posizione molto importante quindi 2 giugno 1946 si eleggono due cose l'assemblea costituente e monarchia repubblica sappiamo che il voto monarchia repubblica prese la scelta istituzionale fondamentale ricordiamo che le elezioni furono molto contestate anche perché i due contendenti arrivarono abbastanza vicino la monarchia arriverà a 10 milioni e 800mila voti e la repubblica 12.800.000 ci vuole una ventina di giorni per proclamare risultati anche perché un
ricorso dei professori dell'università di padova contro il risultato del referendum dicendo una cosa molto semplice che la repubblica si aveva vinto ma non aveva raggiunto il 50.1 per cento dei voti cioè non aveva superato la maggioranza assoluta perché perché i voti erano stati più di 25 milioni essendoci state molte schede bianche schede nulle questo ricorso blocco tutto per una decina di giorni si dovrà aspettare il 18 giugno del 46 per la proclamazione ufficiale dei voti dopo che la corte di cassazione aveva rigettato questo ricorso furono settimane molto difficili per l'italia anche perché l'italia era spaccata
in due era spaccata in due perché in tutto il nord fino a roma vince la repubblica in tutto il sud vinse la monarchia questo è un dato importante questa spaccatura garanca dovuta a ragioni storiche perché al nord c'era stata veramente la guerra civile la guerra per la liberazione dei tedeschi quindi la resistenza la sala più forte c'era questo momento del nord il vento repubblicano al sud invece la guerra si era sentita meno e era rimasta più vedere al re all'idea della monarchia per questa ragione quando si eleggerà il capo provvisorio dello stato si sceglierà un
meridionale peraltro di origine monastica infatti i nomi in gioco erano benedetto croce e vittorio emanuele orlando e enrico de nicola cioè che un personaggio della politica meridionale comunque legato alla monarchia proprio per ribilanciare il nord e il sud anche questo è importante per ricordare poi sempre le grandi differenze territoriali che portiamo nel nostro stato l'assemblea costituente quindi si insedia a giugno 1946 e akon compito importante scrivere completamente la nuova architettura dello stato deve scrivere per la prima volta una costituzione repubblicana a cosa si ispira l'assemblea costituente si ispira ancora alle idee di fine settecento di
inizio ottocento quindi alle grandi rivoluzioni liberali alla rivoluzione francese in particolare perché nella rivoluzione francese del 1789 viene sancita l'idea di costituzione modello che cosa deve contenere una costruzione moderna ci dice la carta la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 una carta importante perché proprio la carta dei principi della rivoluzione quindi questa dichiarazione del 1789 all'articolo 16 chiarisce che un paese uno stato per avere costituzione deve garantire diritti e doveri dei cittadini e divisione dei poteri se guardate bene se ci pensate la struttura della nostra costituzione è proprio questo a due parti
dove principi fondamentali abbiamo la parte prima diritti e doveri dei cittadini e la parte seconda invece ordinamento della repubblica a pensarci bene sono proprio le due parti che avevano indicato nella rivoluzione francese cioè il riconoscimento di diritti e doveri e la divisione dei poteri in che senso divisione dei poteri perché prima nelle monarchie assolute il re aveva tutti i poteri legislativi esecutivi e giudiziari invece dividendo il potere secondo le teorie di locke e di montesquieu quindi le grandi teoriche del seicento e del settecento il potere loro più concentrato in una persona ma si bilancia e
si compensa ecco come nascono allora il legislativo l'esecutivo il giudiziario e poi da noi anche i poteri di garanzia corte costituzionale presidente repubblica le autonomie molto articolate proprio per dare un sistema di bilanciamento dei poteri in cui nessuno con centro del potere e poi i diritti e doveri di cittadini perché diritti e doveri perché i cittadini hanno dei doveri di partecipazione militare tributario sanitario articolo 2 della costituzione in generale doveri inderogabili ma anche i ricchi i diritti perché perché prima delle costituzioni degli stati liberali pubblicani moderni i diritti aspettavamo il re cioè è il re
che era al di fuori della legge che riconosceva i suoi cittadini attribuiva attribuiva ai suoi cittadini i diritti invece come recita l'articolo 2 della nostra costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono semplicemente riconosciuti dallo stato non attribuiti perché perché i diritti il sonno della persona e lo stato si limita a riconoscerli ea garantirgli mentre prima è il re arrivo ad attribuirli a darglieli i diritti questo è molto importante perché i diritti più classici le libertà più classiche circolazione e soggiorno libertà personali libertà di riunione e libertà religiosa non erano assolutamente diritti scontati diritti orbi ma fino
alla fine del settecento erano sempre controllati da sovrano e dal potere invece nelle costituzioni moderne e contemporanee si affermano questi diritti se affermano così dirti per fare cosa per ottenere una libertà dallo stato infatti questi diritti delle libertà classiche che noi troviamo degli articoli 13 e seguenti della costituzione sono i diritti di libertà diritti di libertà dallo stato lo stato non può entrare in casa mia libertà di domicilio lo stato non può arrestarmi senza motivo libertà personale lo stato deve lasciarmi libero di esercitare la mia religione articolo 19 della costituzione italiana lo stato deve lasciarmi
libero di riunirmi associarmi articoli 17 e 18 lo stato deve lasciarmi libero di manifestare il pensiero articolo 21 lo stato non deve controllare la mia corrispondenza articolo 15 vedete l'impianto classico delle libertà i diritti fondamentali dei cittadini hanno dei loro diritti non attribuiti dallo stato ma solo riconosce quindi queste due gambe queste due parti diritti e doveri dei cittadini e ordinamento della repubblica sono la base della costituzione solo il meccanismo su cui si impianta il nostro stato che pubblicano ovviamente il nostro stato repubblicano nell'articolazione del potere anche le autonomie poi vedremo meglio le autonomie sono
riconosciute nell'articolo 5 ma ricordiamo sempre la repubblica una e indivisibile riconosce e favorisce le autonomie quindi la repubblica resterà sempre una sola lo stato indivisibile poi in quale articolazione nell'articolazione che si trova nella parte seconda della costituzione ovviamente sulla divisione dei poteri il titolo quinto il famoso titolo quinto dove troviamo regioni province e comuni già anticipiamo che le regioni sono state un'invenzione del costituente perché perché il costituente voleva dare maggiore amalgama dal territorio nazionale e quindi accorpare le province perché lo stato sabaudo uno stato italiano di fondazione sullo statuto albertino aveva soltanto province e comuni
le regioni cui mi sono un'acquisizione nuova ne parleremo ovviamente meglio quando si parla in generale della costituzione di cose bisogna parlare bisogna spiegare bene come adesso vedremo la costituzione come composta la costituzione a un testo materiale dei principi sostanziali e dei principi viventi la costituzione ha una sua primazia ma soprattutto alla costituzionale sulle garanzie le garanzie sono il giudizio di costituzionalità e il procedimento di revisione che adesso vedremo anche in maniera più specifica perché abbiamo detto che per garantire la primarietà della costituzione bisogna necessariamente andare a vedere che esiste un procedimento speciale quello poi sancito
nell'articolo 138 l'articolo 138 serve a modificare la costituzione racconteremo quindi non solo la modifica come funziona il meccanismo ma anche le principali modifiche per capire poi il problema di fondo oggi la nostra costituzione è ancora attuale in italia la costituzione a 75 anni e in assemblea costituente calamandrei uno dei grandissimi padri della costituzione disse una cosa molto chiara noi dobbiamo scrivere una costituzione transit è una costituzione riguarda era il 4 marzo 1947 e calamandrei paese proprio questo impegno scrivere una costituzione che potesse valere negli anni cosa che è riuscita perché dopo 65 anni la nostra
costituzione è ancora viva e vegeta è attenuto alle istituzioni repubblicane addirittura alcuni dicono che sia la costituzione più bella del mondo questo tema più che altro giornalistico di informazione però la nostra costituzione perché è bella la nostra produzione bella anche perché semplice e chiara questa è un'altra cosa importante se noi leggevamo la costituzione sono articoli semplici articoli che tutti possono capire perché perché anche questa fu una scelta del costituente scrivere la costituzione lingua italiana in assemblea costituente sedeva concetto marchesi che era uno dei grandi padri costituenti mar alcun grande letterato chiamò dei suoi colleghi maldini
pancrazi poter redigere un testo su quelle che fossero le regole su come si scrive una costituzione frasi brevi non più di 20 parole mai più di una subordinata per frase uso preferibilmente di parole un uso comune questo perché perché la costituzione della parlare ai cittadini in italia c'erano 40 milioni di abitanti nel 1946 più della metà era analfabeta serviva una cosa chiara è la costituzione rivolta ai cittadini è un dogma centrale lo troviamo poi sancito dell'ultima discussione transitoria finale la diciottesima dove troviamo scritto una cosa semplicissima che la costituzione resterà affissa in tutte le case
comunali per tutto il 1948 perché perché i cittadini devono leggere la devono conoscerla certo non esisteva internet non esisteva twitter non estiva la televisione quindi affiggere la costituzione era un modo per conoscerla noi abbiamo una costituzione quindi presbite che guarda lontano scritta in maniera molto chiara una costituzione che vive a 75 anni con alcuni problemi di riforme sui giornali da fare ma anche un meccanismo molto complesso per riformarla perché perché la costituzione deve essere la base dell'art elemento e quindi riformata non deve essere semplice proprio per garantire la sua centralità buongiorno a tutti mi presento
sono giovanna di storia insegna diritto costituzionale presso il dipartimento di giurisprudenza dell'università degli studi roma tre oggi cominceremo a parlare dell'organizzazione dello stato o meglio dell'organizzazione dello stato nella costituzione italiana quindi più in particolare del modo in cui la costituzione italiana disciplina l'organizzazione dello stato per fare questo dobbiamo fare un passo indietro e cerca anzitutto di capire quali sono le peculiarità le caratteristiche che connotano la costituzione la costituzione da un punto di vista storico politico la nostra costituzione ma a dire il vero anche la costituzione da un punto di vista logico giuridico cioè per comprendere
in che modo la carta fondamentale un testo fondamentale di remo forse il germe dell'ordinamento disciplina l'organizzazione dello stato e il modo in cui essa quindi si è sviluppata nel corso del tempo partirei a questo punto da una dichiarazione anzi dall'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino un testo di fondamentale importanza nel 1789 un testo che come ben sappiamo se è stato proclamato nel corso della rivoluzione francese quindi un momento storico di particolare rilievo da diversi punti di vista soprattutto per quel che riguarda l'affermazione dei diritti e delle libertà fondamentali questo testo diciamo
che si è si è sviluppato nato si è basato anche su quella che erano le dichiarazioni d'indipendenza americana è quindi fondamentale l'esigenza di garantire di affermare e tutelare quelli che amano dire i diversi diritti e le libertà fondamentali la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese a è costituita costituito anche la base di una molteplicità di costituzione cioè la vera e propria fonte di ispirazione compresa la nostra costituzione perché questo testo è stato così importante e soprattutto che cosa per quel che interessa oggi ai fini stesso di costituzione ha affermato ha proclamato l'articolo 16
dicevo è molto importante perché l'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino afferma che ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei poteri determinata non ha costituzione a contrarle decidiamo quindi da questa affermazione importantissima quello che è il concetto fondamentale della costituzione o meglio da questa affermazione possiamo desumere le diverse declinazioni della costituzione le diverse accezioni di cui la costituzione la costituzione come carta fondamentale come testo fondamentale dell'ordinamento si deve comporre anzitutto garanzia dei diritti e separazione dei poteri l'articolo 16 afferma dunque che c'è una costituzione
che un ordinamento giuridico e costituzionale che quindi l'organizzazione dello stato è di natura costituzionale se vi è garanzia di diritti e separazione dei poteri ecco l'importanza da un punto di vista storico della nascita di questo testo nel corso della rivoluzione francese sulla base della dichiarazione di indipendenza americana ovvero l'esigenza fondamentale di garantire di richiedere che la garanzia dei diritti venga assicurata quindi diritti nei confronti del cittadino nei confronti della collettività diritti dell'uomo e accanto alla garanzia dei diritti ci deve essere la separazione dei poteri la separazione dei poteri potremmo dire è strettamente con vista la
garanzia dei diritti perché è è uno strumento di garanzia dei diritti garanzia dei diritti e separazioni dei poteri rappresentano il cuore di ogni costituzione della costituzione di ogni tempo della costituzione di ogni luogo è ancor più importante l'affermazione di questi contenuti anche rispetto all'esigenza di un testo scritto l'articolo 16 della dichiarazione diritti dell'uomo ci fa riflettere su un aspetto importante anche di carattere formale non è necessaria la forma scritta per aversi costituzione è necessario che l'ordinamento sia in grado di garantire i diritti di assicurare la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri se esistono
questi due elementi sia costituzione anche a prescindere da una eventuale formalizzazione scritta del testo questa dichiarazione è importante perché da essa dicevo si desumono si ricavano diverse accezioni del testo costituzionale del concetto stesso di costituzione le diverse declinazioni della costituzione d'altra parte la costituzione il termine stesso è potremmo dire puri senza cioè assume più accezioni più sfumature più declinazioni anzitutto da un punto di vista storico politico da un punto di vista al solito politico la costituzione altro non è che uno strumento di affrancazione dall'assolutismo nasce intorno al xviii secolo nei diversi stati e garantisce quello
che potremmo dire il capovolgimento dei vecchi criteri di legittimazione del potere per assicurare in maniera effettiva e sostanziale proprio la separazione dei poteri non vi può essere più la concentrazione del potere legislativo esecutivo giurisdizionale in un unico soggetto senza che vi sia un punto ma garanzia e quindi una garanzia fondamentale di limitazione dei poteri come strumento anche di garanzia dei diritti quindi potremo sicuramente riconoscere un accezione storico politico del concetto stesso di costituzione appunto in quello che è uno strumento di affrancazione dal potere politico al fine di incrementare la tutela dei diritti e la tutela
del diritto poi da un punto di vista potremmo dire formale il testo costituzionale si caratterizza per la scrittura la certezza del diritto derivante da un testo scritto è indubbia l'uomo di ogni tempo a nera quella della certezza del diritto e la certezza del diritto molto spesso si ricava anche davvero conta su scritto da un pezzo formale garantisce in maniera effettiva maniera certa che quei diritti sono garantiti che quelle limitazioni dei poteri sono assicurati quindi indubbiamente la forma scritta un'accezione di ulteriore garanzia ad un contenuto che è già costituzionale se nella misura in cui come già
detto afferma i diritti garantisce i diritti e assicura la separazione dei poteri quindi da un punto di vista storico da un punto di vista politico rappresenta questa garanzia indubbia di separazione dei poteri e tutela di diritti da un punto di vista formale può esservi la forma scritta che incrementa l'esigenza di garanzia del diritto e dei diritti derivanti appunto dal testo dal testo scritto e poi potremmo dire che diciamo da un punto di vista sostanziale rappresenta il terzo fondamentale è il terzo che ha un valore primario è il germe dell'ordinamento e diciamo la condizione di validità
di unità la struttura essenziale dell'ordinamento il nucleo fondamentale anzi se l'ordinamento e non è l'albero diciamo la costituzione potrebbe essere anzi indubbiamente rappresenta il tronco da cui diciamo dipartono e diversi rami questo è il concetto di costituzione in senso sostanziale che ci fa comprendere il modo in cui da essa parte l'organizzazione dello stato l'organizzazione dello stato è intesa come affermazione dei diritti o meglio garanzia dei diritti separazione dei poteri e quindi disciplina per il potere legislativo del potere esecutivo del potere giurisdizionale deriva dal testo della costituzione non necessariamente un testo lungo non necessariamente molte norme
ma è indispensabile che vi siano quelle norme fondamentali a garanzia dei diritti e a garanzia della separazione dei poteri poi più specificamente è ovvio che la costituzione da un punto di vista diciamo normati visti con un'accezione più normatica contiene un insieme di norme norme che rappresentano il nucleo fondante e che includono anche quei principi fondamentali quello che è potremmo dire il nucleo duro il nocciolo della costituzione immodificabile che non può essere revisionato perché rappresenta l'essenza stessa dell'ordinamento giuridico dell'ordinamento giuridico così come sviluppatesi in quel determinato momento storico e che garantisce dunque l'organizzazione dello stato in
quel determinato ordinamento giuridico se poi ci soffermiamo più da un punto di vista diciamo istituzionali stico allora la costruzione può assumere un ulteriore accezione andando a rappresentare diremo la la forma di stato la forma di governo o più specificamente la decisione fondamentale sulla forma di stato sulla forma di governo che è assunta che sono assunto e determinate in un determinato in un dato ordinamento giuridico quindi le declinazioni del concetto stesso di costituzione sono tante da un punto di vista storico da un punto di vista politico istituzionale e il germe dell'ordinamento nasce come strumento di affrancazione
dal dall'assolutismo capovolge quelli che hanno i precedenti criteri di legittima cede il potere e assicura la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri se queste sono le diverse accezioni le diverse declinazioni del significato stesso di costituzione vediamo se e in che modo vengono riproposte per sussistono nel nostro testo costituzionale la costituzione italiana come sappiamo entra in vigore il primo gennaio del 1948 e si compone di due parti preceduta da dodici principi fondamentali le due parti sono rubricata esattamente sulla base di quanto afferma la dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle libertà e dei diritti dell'uomo
e dei cittadini 1789 perché la prima parte garantisce diritti e doveri dei cittadini e la seconda parte l'ordinamento della repubblica quindi dal punto di vista sostanziale contenutistico indubbiamente la costituzione italiana garantisce quanto indicato dall'articolo 16 della dichiarazione ovvero diritti e separazione dei poteri l'organizzazione l'ordinamento della repubblica l'organizzazione dello stato prevista dalla parte seconda e indice proprio di questa necessaria limitazione dei poteri separazione di potere è un testo scritto a strumento diciamo a garanzia della certezza del diritto dei diritti per tutelare in maniera effettiva è sostanziale e forse maggiore la stabilità del diritto e la nostra
è una costituzione scritta è una costituzione e stabile è una costituzione rigida ovvero è una costituzione che non può essere modificata da una legge ordinaria ma necessita di una procedura aggravata che essere revisionata per essere modificata parliamo di revisione costituzionale la costituzione italiana è una costituzione rigida ovvero a differenza dello statuto albertino che poteva essere modificato con legge ordinaria la costituzione italiana può essere modificata solo seguendo il procedimento aggravato prescritto dall'articolo 138 della costituzione ovviamente si tratta di uno strumento di garanzia a tutela del testo costituzionale gemme dell'ordinamento condizioni di validità di stabilità dell'ordinamento giuridico
per la modifica del quale dunque è necessario attenersi a quelle al procedimento prescritto dall'articolo 138 i sistemi di revisione costituzionale di solito vengono classificati sulla base di diversi elementi in primis sulla base di quello che è l'organo cui attribuito il potere di modificare il testo costituzionale e poi in relazione a quello che è l'apporto garantito dal corpo elettorale al procedimento di modifica sulla base di questi due elementi quindi individuazione del soggetto titolare del potere di modificare della costituzione e con riguardo alla partecipazione del corpo elettorale potremmo dire che il nostro è un sistema misto un
sistema misto perché riconosce anzitutto alla titolarità in capo al potere e la titolarità del potere televisione in capo all'organo legislativo quindi allo stesso organo che è titolare della produzione legislativa quindi legge ordinaria ma allo stesso tempo anche la modifica della legge costituzionale e per quel che riguarda invece il diciamo la partecipazione l'apporto garantito dal corpo elettorale potremmo dire che l'intervento del corpo elettorale eventuale anzi è doppiamente eventuale legato quindi al verificarsi di due condizioni ma procediamo con ordine e vediamo o quanto prescritto dall'articolo 138 in relazione dunque alla revisione del testo costituzionale l'articolo 138 già
o diciamo nell'indicazione di carattere generale con riguardo al tipo di leggi per le quali è indispensabile seguire questo inter suscita qualche qualche dubbio qualche perplessità l'articolo 138 prescrive infatti che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con ciascuna camera con due successive deliberazioni e segue l'iter individuato è già due differenti categorie di di leggi leggi di revisione della costituzione e altre leggi costituzionali si è molto discusso su questa indicazione contenuta all'articolo 138 per capire se e in che modo si possa trattare di due differenti categorie di leggi o quali
siano le caratteristiche che connotano le une e le altre indubbiamente anche da un'interpretazione veramente lettera le leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali induce a ritenere che le leggi di revisione costituzionale siano leggi costituzionali ma se le leggi di revisione costituzionale come emerge anche dalla denominazione sono leggi che vanno a modificare della costituzione a revisionare il testo della costituzione residuo poi un dubbio sul contenuto delle altre leggi costituzionali ovvero da un'interpretazione della mette veramente letterale emerge che esistono leggi costituzionali che non siano leggi di revisione e allora che cosa contengono queste leggi costituzionali queste
altre leggi costituzionali qual è lo scopo il motivo per il quale vengono adottate ora indubbiamente e quindi se le leggi di revisione costituzionale sono quelli che fanno modificare il testo della costituzione le altre leggi costituzionali sono con ogni probabilità quelle leggi che vanno ad integrare il testo della costituzione emblematico in tal senso alcune alcuni casi di riserva di legge costituzionale per esempio l'articolo 116 l'articolo 116 della costituzione come ben sappiamo prevede che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale esempio chiaro che riserva di legge costituzionale ovvero lo statuto delle cinque
regioni autonomia speciale ha la forma di una legge costituzionale è chiaro per questa legge costituzionale non modifica il testo della costituzione ma probabilmente appunto lo integra questo è un chiaro esempio di un'altra legge costituzionale quindi di una legge che modifica il testo della costituzione anche l'articolo 137 ad esempio contiene una riserva di legge costituzionale una legge costituzionale stabilisce le condizioni le forme i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e sarà poi la legge costituzionale 1 del 48 a contenere questa disciplina allora anche questa non è una legge che va a modificare il testo
della costituzione ma appunto si aggiunge a quella materia costituzionale e dunque non modifica il testo della costituzione altri casi di riserva di legge costituzionale sono presenti nel testo costituzionale hanno suscitato qualche ulteriore perplessità per esempio l'articolo 71 l'articolo 71 della costituzione come ben sappiamo elenca contiene quelli che sono i diversi soggetti titolari dell'iniziativa legislativa l'iniziativa delle leggi appartiene al governo a ciascun membro delle camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ora è dubbio che attiene si è fatta a disposizione riguarda l'eventuale modifica del testo costituzionale che potrebbe scaturire comunque dall'introduzione
di un ulteriore soggetto titolare dell'iniziativa legislativa ecco perché l'eventuale legge costituzionale che aggiunge e quindi che va indubbiamente a integrare il testo costituzionale rispetto ai soggetti titolari di iniziativa legislativa ha suscitato qualche perplessità sulla natura stessa della legge solo legge costituzionale o anche di revisione in di inevitabilmente andando a modificare quello che è il numero e il tipo di soggetti titolari di iniziativa legislativa lo stesso potrebbe dirsi con riguarda l'articolo 132 della costituzione che un procedimento ad hoc prevede che con legge costituzionale si possa addivenire alla fusione di regione già esistenti o alla creazione di
nuove regioni anche questa legge costituzionale suscita diciamo qualche perplessità sulla natura cioè sull'essere una legge che integra il terzo costituzionale o che in fondo va a modificare perché indubbiamente andrebbe a modificare il precedente articolo che contiene l'elenco delle regioni italiane quindi in alcuni dubbi e perplessità su alcuni casi di riserva di legge costituzionale ma indubbia la certezza che emergente da una interpretazione letterale le leggi di revisione sono legge costituzionale esistono leggi costituzionali che non vanno a modificare il testo costituzionale ma che vanno ad integrare il testo della costituzione in ogni caso entrambi i tipi di
di leggi televisione o altre leggi costituzionali vengono adottate con un procedimento aggravato il procedimento prescritto dall'articolo 138 l'articolo 138 contiene delle disposizioni importanti e significative e laddove non precisa specificamente alcuni aspetti si applica il procedimento meglio le norme prescritte per il procedimento legislativo ordinario per esempio questo è quanto accade rispetto all'iniziativa legislativa nulla contiene l'articolo 138 rispetto all'iniziativa legislativa e quindi non v'è dubbio che si applicano le stesse norme prescritte dall'articolo 71 della costituzione e quindi indubbiamente l'iniziativa rispetto ai procedimenti di revisione costituzionale spetta al governo a ciascun componente delle telecamere al corpo elettorale nonché
agli altri organi nenti cui 7 inquinata legge costituzionale quindi sappiamo il credere e consigli regionali quindi nessuna variazione per quel che riguarda la l'iniziativa legislativa e il procedimento invece è piuttosto complesso articolo 138 al primo comma prevede anzitutto che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione quindi già rispetto al procedimento legislativo ordinario abbiamo una prima variante molto che importante e significativa che è
caratterizzata dalla doppia deliberazione due deliberazioni di camera e senato caratterizzate da un rapporto di alternatività e non di consecutività sera molto di come invece inizialmente si pensava si è molto discusso su questo rapporto di alternatività piuttosto che quello di consecutività e la ratio diciamo che protende per questa per questa scelta va ravvisata anzitutto nel principio di parità formale tra le due camere e nella esigenza di evitare come dire inutili sprechi di tempo dal momento che il rapporto di alternatività induce a ritenere che il progetto di legge vada presentato prima ad una camera indistintamente altra e
successivamente la prima deliberazione della camera alla quale è stato presentato l'iniziativa legislativa di legge costituzionale va da discusso in prima deliberazione dalla camera che interviene per seconda poniamo il caso viene presentato alla camera prima deliberazione si esprime in prima deliberazione poi ci sarà la prima deliberazione del senato decorreranno decorrerà il termine l'intervallo non inferiore a tre mesi quindi vi sarà la seconda deliberazione della camera intervenuta per prima nel nostro esempio la fabbrica quotati e successivamente la seconda deliberazione del senato in questo modo non soltanto ragioni di tempo migliorano l'efficacia del procedimento legislativo ma chiaramente si
risponde come dicevo a quell'esigenza di parità formale tra i due rami del parlamento per evitare ad esempio che l'intero lavoro effettuato dalla camera che interviene per prima venga venga vanificato dalla camera che interviene per secondo quindi indubbiamente è il rapporto di alternatività alla base del che che disciplina le due deliberazioni tra camera e senato nel corso della del procedimento legislativo l'articolo 138 della costituzione prevede che il procedimento di revisione costituzionale avvenga con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e abbiamo visto con diciamo un rapporto di alternatività tra le due deliberazioni posto
che laddove la costituzione in un prescriva delle indicazioni diverse si applica quanto disposto per il procedimento ordinario e posso che nulla si dice in merito alla prima deliberazione possiamo indubbiamente ritenere che rispetto alla prima deliberazione si applicano le regole le norme di carattere generale già previste per il procedimento legislativo rispetto invece alla seconda deliberazione l'articolo 138 prevede nelle maggioranze specifiche anzitutto richiede almeno il raggiungimento della maggioranza assoluta devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione a questo punto diciamo che si può aprire una una doppia possibilità poniamo il caso
in cui effettivamente in seconda di liberazione si raggiunga la maggioranza assoluta dicevo almeno la maggioranza assoluta perché qualora non si dovesse raggiungere si è fatta maggioranza il procedimento si appresta quindi almeno la maggioranza assoluta ovvero metà più uno dei componenti raggiunta siffatta maggioranza l'articolo 138 prevede che la legge venga pubblicata ma si tratta di una pubblicazione anomala ora una pubblicazione necessaria ai fini dell'eventuale partecipazione del corpo elettorale secondo comma dell'articolo 138 le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione questa pubblicazione anomala ne facciano domanda un quinto dei membri
di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi dunque in seconda deliberazione viene raggiunta la maggioranza assoluta la legge viene proprio per la legge viene pubblicata con questa pubblicazione anomala in gazzetta ufficiale cominciano a decorrere i tre mesi durante i quali i soggetti all'uomo abilitati dal testo costituzionale possono eventualmente richiedere il referendum costituzionale o allora si è fatta eventualità venga percorso da uno di questi soggetti allora si potrà svolgere il referendum e quindi viene chiamato nel procedimento legislativo
viene richiesta la partecipazione procedimento di revisione costituzionale il corpo elettorale rispetto a questo referendum a differenza di quanto prescritto dall'articolo 75 per il referendum abrogativo non è richiesto alcun i quorum di partecipazione ma solo come emerge dall'articolo 138 un quorum di validità quindi a prescindere dal numero dei soggetti che si recano alle urne il il referendum meglio il destino della legge della legge di revisione costituzionale un'altra legge costituzionale dipenderà dall'esito del referendum è importante quindi l'assenza di qualsivoglia quorum di partecipazione non è importante quindi il numero dei soggetti che si recano alle urne a fini
della determinazione dell'esito del referendum di solito il quesito referendario è posto nei seguenti termini approvate la legge di modifica della costituzione nella parte in cui prevede xy z qualora l'esito del referendum sia positivo e quindi qualora il corpo elettorale si esprima a favore della modifica la legge verrà di revisione costituzionale altre legge costituzionale verrà promulgata pubblicata questa volta la pubblicazione come fase integrativa dell'efficacia e quindi entrerà in vigore prima possibilità quindi una prima eventualità che caratterizza l'iter di una legge di revisione costituzionale che venga raggiunta in seconda deliberazione una maggioranza assoluta quindi la metà più
uno dei componenti venga richiesto il referendum il referendum abbia esito positivo la legge entra in vigore è altresì possibile che il referendum abbia invece esito negativo in quel caso chiaramente il procedimento di revisione si arresta altra eventualità è possibile che venga raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti in seconda deliberazione quindi viene pubblicata con una complicazione un uomo la la la legge di revisione costituzionale altre legge costituzionale ma è possibile che decorrano infruttuosamente i tre mesi durante i quali i soggetti abilitati il referendum non richiedano non lo richieda non ritengano utile procedere alla richiesta del referendum
e quindi decorso infruttuosamente i tre mesi la legge verrà promulgata pubblicata entrerà in vigore quindi si tratta di una ipotesi in cui il referendum non può aver luogo a fronte del fatto che appunto non viene richiesto da quelli che sono i soggetti a tal fine abilitati dall'articolo 138 della costituzione altra ipotesi altra possibilità più che può caratterizzare l'iter di una legge di revisione costituzionale ovvero che venga raggiunta la maggioranza addirittura più significativa della maggioranza assoluta cioè la maggioranza dei due terzi a questo punto l'ultimo corpo dell'articolo 138 precisa che non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti una maggior una maggioranza talmente importante significativa espressa dal parlamento rappresentativo del corpo elettorale che si ritiene non necessario procedere all'eventuale coinvolgimento del corpo elettorale ecco perché all'inizio dicevo che la partecipazione del corpo elettorale del procedimento di revisione costituzionale è doppiamente eventuale è legato cioè al raggiungimento della maggioranza assoluta perché qualora invece l'hanno raggiunto la maggioranza i due terzi non si può farlo dal referendum ed è poi legata all'eventuale richiesta del referendum durante quei tre mesi
di pubblicazione all'anomala e solo nel caso in cui appunto si realizzi a questa condizione che può essere coinvolto che il corpo elettorale può essere richiesta la partecipazione del corpo elettorale nel procedimento di revisione costituzionale quindi un iter abbastanza complesso caratterizzato da una doppia deliberazione e delle precise maggioranze richieste in seconda deliberazione una maggioranza almeno assoluta se viene raggiunta la maggioranza dei due terzi non si fa luogo a referendum e quindi la legge viene comunicata complicata entra in vigore seguendo quelle che sono le fasi che consuete farsi integrative dell'efficacia qualora invece venga raggiunta la maggioranza assoluta
allora decorrono tre mesi durante i quali è possibile la richiesta del referendum qualora questa strada dovesse essere percorsa sarà dall'esito del referendum che dipenderà il destino della legge di revisione costituzionale o di altra legge costituzionale un procedimento complesso rispetto al quale ci si è poi domandati se ad esempio a fronte appunto delle peculiarità prescritte all'articolo 138 una legge di revisione costituzionale una legge costituzionale sia applicabile l'articolo 74 cioè sia consentito comunque al presidente della repubblica il cosiddetto potere di rinvio presidenziale e quindi se perplessità possano essere avanzate dal presidente della repubblica prima della promulgazione al
fine di richiedere dunque alle camere una nuova deliberazione diciamo che gli ostacoli dal punto di vista formale e sostanziale sono stati più d'uno da un punto di vista formale anche il fatto che ad esempio l'articolo 74 richiede o meglio prescrive che il presidente della repubblica possa chiedere una nuova deliberazione rispetto al procedimento di revisione costituzionale sappiamo che già si sono verificati già si sono svolte due deliberazioni e oltre si richiederebbe rispetto al procedimento di revisione costituzionale non una nuova deliberazione ma forse un rinnovo delle doppie deliberazioni quindi ostacoli di natura formale ma anche sostanziale legata
dell'importanza di una legge di revisione costituzionale inducono a riflettere che forse il rinvio presidenziale non è applicabile rispetto ad una legge di revisione costituzionale o un'altra lynch costituzionale l'articolo 138 della costituzione prevede il procedimento aggravato per la modifica del testo costituzionale ulteriore problematica che scaturisce dalla dall'esame del procedimento di revisione costituzionale attiene ai limiti alla revisione costituzionale ovvero tutto il testo costituzionale può essere modificato con la procedura ex articolo 138 della costituzione oppure esiste diciamo un limite un limite logico un limite a connaturato al all'idea stessa del testo costituzionale e al rapporto che intercorre tra
potere di revisione e quello che invece il potere costituente ovvero col potere che ha dato vita al testo della costituzione e allora ci si domanda effettivamente l'intero testo della costituzione può essere modificato o è necessario comunque che un quid debba persistere anche successivamente alla revisione perché in fondo si tratterebbe altrimenti di stravolgere quello che è il prodotto del potere costituente posto che potere costituente il potere costituito sono e restano comunque diversi allora rispetto a queste diciamo le problematiche sono sorte diverse riflessioni su quelli che sono appunto i limiti alla revisione costituzionale ovvero per comprendere se
e fino a che punto il procedimento di revisione costituzionale può deve arrestarsi di fronte ad alcuni contenuti nella costituzione di fronte ad alcune disposizioni che non possono essere modificate senza stravolgere quello che è il potere costituente ora lui limiti alla revisione costituzionale possono essere quindi di due tipi anzitutto abbiamo dei limiti testuali e poi c'è una categoria più problematica di quelli che sono i limiti taciti cosa sono i limiti testuali limiti alla revisione costituzionale testuali sono quelli prescritti nel testo della costituzione non necessariamente in modo espresso ma anche in modo implicito ovvero limiti testuale alla
revisione costituzionale sono quelli che si ricavano dal testo della costituzione o in maniera esplicita perché la costituzione prevede che alcune parti della la costituzione non possono essere modificate o lo prevede in maniera implicita ma sono comunque testuali perché si ricavano appunto dal testo della costituzione quali sono questi limiti limiti testuali espressi individuali e inevitabilmente sono quelli prescritti all'articolo 139 la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale unico limite testuale espresso prescritto in costituzione non si può modificare la forma repubblicana e sappiamo bene anche la ratio sottesa questo limite alla revisione costituzionale i due
giorni 46 si svolse il referendum istituzionale sulla forma di governo e il corpo elettorale scienze la forma repubblicana fu questo l'unico limite condizionante il potere di revisioni il potere costituente nella stesura del testo costituzionale solo la forma repubblicana tutto il resto poteva essere liberamente individuato dalla dal potere costituente e questo limite e fu di grande importanza appunto nel condizionare la l'assemblea costituente nella stesura della co del testo costituzionale quindi la forma repubblicana non può essere modificata unico limite testuale espresso indicato cioè espressamente nel terzo della costituzione attento a questa categoria di limiti video vi possono
essere di limiti testuali che sono però impliciti ovvero che si ricavano dal testo della costituzione ma in maniera appunto implicita non testuale non espressamente quindi sempre nel testo ma in maniera implicita un esempio molti ritengono che siano dei limiti testuali impliciti quelli ricavabili dall'articolo 2 della costituzione l'articolo 2 della costituzione fondamentale nell'affermazione di principi e dei diritti delle libertà fondamentali sanciti perché la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ora molti ritengono che i diritti in quanto inviolabili cioè che non possono essere violati non possono essere neanche revisionati partendo dall'assunto che inviolabilità significhi anche l'irripetibilità quindi quelli inviolabilità attiene anche all'impossibilità di modificare quei diritti proprio perché sono inviolabili sono intoccabili non possono essere modificati proprio perché sono inviolabili non possono essere lesi non possono essere quindi a fronte della loro inviolabilità neppure modificati quindi una categoria di limiti che e testuale perché si ricava da un cesso della costituzione ma non in maniera espressa come fa l'articolo 139 bensì implicitamente quindi
si ricava da un'interpretazione dell'artigiano e nume della costituzione ora rispetto a questa categoria di amy che vi dicevo le sponde ne sono altri ovvero i cosiddetti limiti taciti quindi limiti testuali in espressi o impliciti si ricavano dal testo della costituzione limiti taci che sono invece quei limiti che sono connaturati all'ordinamento giuridico a quello ordinamento giuridico sancito da quel testo costituzionale quindi sono quei limiti potremmo dire logico logico giuridiche che attengono logico giudici che attengono proprio all'istanza dell'ordinamento stesso si è molto discusso su se effettivamente esistono nel nostro ordinamento siffatti limiti e se in che modo
possono essere superati ora un aspetto fondamentale o meglio o un momento significativo di svolta nella in questa riflessione sia con la sentenza a 1.146 del 1988 della corte costituzionale perché è una sentenza con cui la corte effettivamente prende posizione sull'esistenza di limiti alla revisione costituzionale sentenza di cui voglio leggere un estratto molto importante per capire il modo in cui tali limiti sono connaturati alla all'essenza dei valori sui quali si basa la costituzione e operano nell'ordinamento giuridico la costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da
leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali quali sono tanto i principi che la costituzione stessa esplicitamente prevede come un limiti assoluti al potere di revisione costituzionale qual è la forma repubblicana articolo 139 quanto i principi che pur non essendo espressamente menzionati tra quindi non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale appartengono all'essenza dei valori supremi su quali si fonda la costituzione italiana allora la corte costituzionale afferma che esistono dei limiti alla revisione costituzionale oltre a quelli testuale oltre all'articolo 139 esistono dei limiti che sono connaturati all'essenza dei valori ci quale si basa la costituzione
e quindi non possono essere modificati perché la modifica degli stessi implicherebbe una modifica dell'assetto costituzionale così come indicato nel testo costituzionale di quella che rappresenta appunto abbiamo detto la condizioni di validità distro la struttura il l'asse portante dell'ordinamento giuridico e fini si infatti principi supremi fondamentali inviolabili non possono essere modificati attenzione la questione della corte costituzionale fonda precisazione di un poco momento non possono essere modificati nel loro contenuto essenziale questo significa che esempio una modifica testuale all'articolo 3 della costituzione può essere apportata quel che non va modificato è il principio di uguaglianza apple eguaglianza sostanziale
prescritta dall'articolo 3 comma 2 ovvero l'essenza la ratio sottesa a quella disposizione costituzionale non sono modifiche formali che sono vietate sono vietate quelle modifiche che andrebbero a stravolgere il contenuto essenziale di quell'articolo che reca un principio fondamentale che contiene un essenza fondamentale dell'ordinamento giuridico non necessariamente i principi fondamentali quindi immodificabili sono contenuti nei primi 12 articoli come spesso si potrebbe essere indotti a pensare perché ad esempio l'articolo 24 della costituzione garantisce il diritto di difesa che indubbiamente è un principio immodificabile è una garanzia che va assicurata a tutti i cittadini e non solo a loano
solo all'uomo in quanto tale quindi inevitabilmente è un principio fondamentale è un diritto che non può essere in alcun modo ho modificato nel suo contenuto essenziale quindi la classificazione anche la individuazione del terzo della costituzione non va vincolato è solo i principi contenuti nei primi 12 articoli ma è proprio un interpretazione testuali sistematica del testo costituzionale che può indurre anzi che deve indurre ad enucleare quei principi supremi quei diritti inviolabili che non possono essere modificati nel loro contenuto essenziale senza sovvertire le senza dell'ordinamento giuridico fondato sulla prostituzione la corte nella centrale della 1.146 dell 88
continua affermando che questa corte del resto ha già riconosciuto e numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme e leggi di rango costituzionale sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del concordato le quali godono in particolare coperte costituzionale fornite all'articolo 7 comma 2 non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale sia quando affermato che la legge di esecuzione del trattato della cee può essere assoggettata al sindacato di questa corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della
persona umana cioè come se la corte costituzionale introducesse in questo modo una sorta di tripartizione nel james delle norme costituzionali esistono i principi sopra vi diritti inviolabili che rappresentano il nucleo duro intoccabile immodificabile né dal legislatore costituzionale italiano né tantomeno da fonti sovranazionali sappiamo bene come le fonti dell'ordinamento europeo sento pato di efficacia diretta sono in grado di determinare la disapplicazione di norme nazionali commesse antinomiche fina anche di grado costituzionale ad eccezione dei soli principi supremi ad eccezione dei diritti inviolabili cioè questo nucleo duro che possiamo collocare al vertice di questa appunto ipotetica tripartizione nella
genesi delle fonti costituzionali poi abbiamo appunto le fonti dell'unione europea dotate di efficacia diretta che possono quindi incidere sulle norme costituzionali stravolgerle determinandone addirittura la disapplicazione e poi abbiamo le altre norme costituzionali ovvero quelle che possono essere modificate sia pur nel rispetto del principio dell'iter prescritto dall'articolo 138 della costituzione quindi è importante che il procedimento di revisione costituzionale vada rispettato da un punto di vista di quello che l'iter prescritto all'articolo 138 ma è lo stesso incontra dei limiti non tutto il terzo della costituzione è modificabile esistono dei limiti che sono testuali ovvero ricavati dal terzo
della costituzione esistono dei limiti implicita ct cioè connaturati all'essenza stessa dell'ordinamento giuridico e anche questi principi supremi diritti inviolabili non possono essere modificati senza stravolgere l'essenza dell'ordinamento giuridico sul quale si basa la sui quali si basa la costituzione italiana non tutta la costituzione è revisionabile la corte costituzionale a partire dalla sentenza 1.146 dell 88 ha riconosciuto ha affermato che esistono principi supremi e diritti inviolabili che non possono essere modificati non sono quindi oggetto di revisione oltre a quelli personali miti testuali espressi e quindi la forma repubblicana abbiamo dei principi che non possono essere sovvertiti modificati
nel loro contenuto essenziale proprio perché rappresentano l'essenza sulla quale si basa la l'ordinamento giuridico ma vediamo concretamente quali sono questi diritti inviolabili e soprattutto come la costituzione garantisce la tutela di tali diritti anche sulla base di quella fonte di ispirazione ovvero della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino il 1789 di cui abbiamo ricordato l'articolo 16 laddove prescrive che appunto una costituzione debba garantire debba assicurare la tutela dei diritti e la separazione dei poteri diversi gli strumenti attraverso i quali la nostra costituzione garantisce la tutela dei diritti in particolare lui possiamo analizzare e classificare gli
strumenti di garanzia dei diritti in quattro tipi abbiamo indubbiamente la riserva di legge la riserva di giurisdizione la tutela giurisdizionale dei diritti e il sindacato di costituzionalità questi sono quattro fondamentali strumenti che la costituzione prevede e disciplina introduce per garantire i diritti cioè che rassicurare quella tutela dei diritti vediamo in che modo in che termini anzitutto la la riserva di legge la riserva di legge un istituto previsto in costituzione in base al quale la disciplina di una tapa materia deve essere regolamentata dalla legge ed infatti ea garanzia uno strumento a garanzia dei diritti perché tutte
le limitazioni ai diritti possono avvenire solo nei casi modi previsti dalla legge cioè unico un diritto deve essere limitato è indispensabile una legge è indispensabile cioè che il titolare della funzione legislativa che il parlamento rappresentativo del corpo elettorale adotti un atto sulla base di quello che è un iter ha luogo previsto con delle garanzie specificamente previsto in costituzione dei regolamenti parlamentari per eventualmente limitare quei diritti quelle libertà fondamentali e lo abbiamo visto bene questo periodo di di pandemia in questo periodo di emergenza quanto sia importante il bilanciamento nella tutela nella garanzia dei diritti e quanto
sia importante il ricorso a strumenti di garanzia per limitare i diritti quindi la riserva di legge un primo strumento di fondamentale rilievo a tutela dei diritti la riserva di giurisdizione risponde alla stessa razzo ma chiama in gioco il ruolo del giudice perché per limitare i ricchi non è solo necessarie che case i modi di limitazioni dei diritti sono stabiliti dalla legge ma indispensabile un atto motivato dell'autorità giudiziaria solo in tal modo è possibile procedere alla limitazione ad esempio nella libertà personale di domicilio ovvero a limitazioni ai diritti fondamentali quindi riserva di legge riserva di giurisdizione
e tutela giurisdizionale dei diritti altro strumento fondamentale che la costituzione prescrive all'articolo 24 e riconosce come diritto fondamentale il diritto proprio alla tutela giurisdizionale ovvero in presenza di una lesione di un diritto il soggetto ha la possibilità di rivolgersi dinanzi ad un giudice per ottenere le il ripristino della situazione violata il risarcimento ovvero alla possibilità di rivolgersi dinanzi al giudice territorialmente competente competente per materia a fronte di quella lesione del diritto una lesione che quindi consente una tutela giurisdizionale quindi il riserva di legge riserva di giurisdizione tutela giurisdizionale dei diritti però la possibilità di rivolgersi
ad un giudice di fronte ad una lesione a una relazione e infine il sindacato costituzionalità anche questo uno strumento fondamentale nella garanzia nell'assicurare la tutela dei diritti perché attiene al ruolo della corte costituzionale a fronte di un'eventuale violazione della carta costituzionale da parte di una legge se una legge è un atto con forza di legge viola fu una norma costituzionale è compito della porta intervenire intervenire per dichiararne l'illegittimità costituzionale cioè di fatto e spingerla dall'ordinamento e quindi se una legge ad esempio viola il principio di uguaglianza perché introduce un trattamento irragionevolmente discriminatorio beh quella legge
in quanto lesiva di un principio fondamentale vice punta dall'ordinamento va rimossa con efficacia retroattiva nei confronti di tutti i consociati proprio perché quella legge è viziata e invalida e questo intervento della corte costituzionale a garanzia del ripristino della costituzionalità è un importantissimo strumento di chiusura 1 studi del sistema di garanzia del testo costituzionale e soprattutto di garanzia dei diritti è quando avrà come la costituzione sulla base di dicevo della come dire fonte di ispirazione contenuta all'articolo 16 della dichiarazione diritti dell'uomo e del cittadino garantisce in maniera effettiva la tutela dei diritti almeno attraverso questi quattro
strumenti riserva di legge di giurisdizione sindacato di costituzionalità e tutela giurisdizionale dei diritti quali sono questi diritti inviolabili che la costituzione garantisce tutela assicura indubbiamente l'articolo 2 della costituzione è una disposizione fondamentale perché è la disposizione che consente anche l'ingresso di nuovi diritti in un articolo 2 della costituzione prevede la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili che solidarietà politica economica e sociale principio fondamentale il contenuto nell'articolo 2 è anzitutto il principio personalistico ovvero la repubblica
garantisce conosce quelli che sono i diritti dell'uomo in quanto tale diritti inviolabili diritti che non possono essere lesi e forse diritti che non possono essere modificati che sono irripetibili che sono inviolabili e che appartengono all'individuo in quanto tale ecco il principio personalistico ovvero l'esigenza di apprezzare tutela all'individuo nella sua specificità nella sua individualità ma allo stesso tempo anche all'inter il tuo delle formazioni sociali e quindi la possibilità anzi la necessità di apprestare una garanzia sulla base di questo principio pluralistico anche al singolo nelle formazioni sociali e ovvero in quelle organizzazioni in quella formazione come si
svolge la sua personalità fondamentale quindi accanto al principio impersonali sco il principio pluralistico e l'articolo 2 da ultimo prescrive ovviamente l'osservanza anche dei doveri ecco il principio solidaristico accanto alla tutela dei diritti è indispensabile la l'adempimento dei doveri di solidarietà politi politici economici e sociali di essi al all'individuo l'articolo 2 della costituzione è stato oggetto di numerose riflessioni a fronte del fatto che non contiene un elenco esaustivo dei diritti me evidentemente è idoneo a consentire sul versante diametralmente opposto l'ingresso di qualsivoglia diritto nell'ordinamento giuridico costituzionale perché questa precisazione perchè sia molto discusso sul ruolo giocato
da questa disposizione rispetto all'eventuale evoluzione della società e quindi l'affermazione di nuovi diritti indubbiamente si è quindi discusso sul se l'articolo 2 posto essere intesa come una norma fattispecie chiusa e quindi garantire soltanto i diritti successivamente recuperate nel testo della costituzione o se possa invece definirsi una norma fattispecie aperta e quindi consentire l'ingresso di qualsivoglia ulteriore diritto è prevalso indubbiamente con la tesi mediana tra l'una e l'altra ovvero sicuramente per effetto dell'apertura individuata all'articolo 2 è possibile l'introduzione nel nostro ordinamento di nuovi diritti ovvero diritti che non trovano un'espressa tutela nel testo costituzionale a fronte
di naturali evoluzioni della società che spingono e che determina l'introduzione di nuovi diritti la nascita lo sviluppo di nuovi diritti tuttavia questi nuovi diritti devono avere comunque un appiglio in costituzione cioè la propria ratio la propria matrice deve essere contenuta in una disposizione costituzionale esempio tipico è quello della privacy oggi non v'è dubbio alcuno nel riconoscere che la privacy abbia una tutela costituzionale ma parimenti indubbio che non c'è nel testo costituzionale una norma specifica a tutela della privacy la privacy trova il suo ingresso nel nostro ordinamento indubbiamente con una tutela costituzionale in virtù dell'articolo 2
della costituzione dell'articolo 15 della costituzione sulla segretezza della corrispondenza e forse anche sulla base dell'articolo 13 della costituzione ovvero di cura che la libertà personale perché oggi d'altra parte dell'inter sta personale non è solo una libertà fisica ovvero la tutela fronte di eventuali aggressioni a fronte di perquisizioni personali e domiciliari ma anche la tutela di una identità psico fisica e quindi il diritto al nome diritto all'immagine il diritto alla all'identità sessuale sono tutti aspetti che contribuiscono a definire la libertà o meglio l'identità personale di ciascun individuo e che di recente forse il contenuto della libertà
personale si arricchisce ulteriormente a fronte dello sviluppo dei diritti nell'era digitale e quindi non abbiamo dubbi o le riconoscere che la tutela della libertà personale si estende anche a quello che egli all'identità digitale ovvero tutte quelle specificità che caratterizzano l'individuo nel mondo virtuale in questo mondo senza spazio e senza tempo in cui però il soggetto immette delle informazioni dei dati che lo contraddistinguono e quindi la libertà personale si arricchisce di contenuti nuovi di contenuti sostanzialmente diversi rispetto a quelli originariamente pensati dai padri costituenti ma che senza dubbio possono avere un figlio nel testo costituzionale oltre
alle libertà personale poi la costituzione garantisce altre libertà individuali per esempio la libertà di domicilio la libertà e la segretezza delle comunicazioni la libertà di soggiorno nonché la libertà di manifestazione del proprio pensiero come dire quintessenza dello stato di diritto fondamentale oltre a queste libertà individuali vi è poi la garanzia e la tutela nei confronti e libertà collettive pensiamo ad esempio a quella tutela del singolo nelle formazioni sociali nelle associazioni pensiamo alla tutela e la garanzia del diritto nelle riunioni il diritto di riunirsi ma anche la libertà negativa di non riunirsi qualora si volesse procedere
ad un esercizio di tale evento le garanzie prescritte in costituzione tutela l'individuo abbiamo poi delle libertà economica a partire dall'articolo 41 e seguenti della costituzione dei diritti sociali ovvero il diritto al lavoro il diritto allo studio e diritto all'ambiente di vita l'ambiente salubre molti di questi sono cosiddetti diritti condizionati cioè che presuppongono l'intervento di una organizzazione statale ovvero del dello stato per garantire in maniera effettiva tali diritti il diritto allo studio è privo di qualsiasi ragion d'essere se non ci sono le scuole più diretta la salute si svuotano il suo contenuto essenziale se non ci
sono strutture ospedaliere pubbliche che garantiscono l'attuazione di tali diritto e l'affermazione diciamo della tutela effettiva e sostanziale di questi delitti di fatto trova la propria radice la propria esistenza dell'articolo 3 della costituzione ovvero il principio di uguaglianza il principio di uguaglianza un valore etico è un valore sociale religioso è un principio giuridico essenziale direi della democrazia sin dai tempi dell'antica grecia e è un principio o sconsacrato nell'articolo 3 della costituzione e che costa d comi come ben sappiamo il primo comma racchiude tutela quel principio di uguaglianza formale numerica panificatrice siamo tutti uguali non ci sono
distinzioni di sesso razza lingua opinioni politiche condizioni economiche e sociali quindi direi l'affermazione il portato il frutto di quel di quello stato liberale quindi il frutto delle rivoluzioni della rivoluzione francese la abolizione delle differenze per ceti per classi sociali finalmente una parificazione ma questa parificazione numerica non è satisfattiva in maniera davvero completa perché perché in realtà le differenze ci sono ci sono differenze fisiologiche tra l'uomo e la donna ci sono differenze economiche tra soggetti abbienti e soggetti meno abbienti ci sono differenze tra soggetti apt e soggetti diversamente abili ecco allora l'importanza del secondo comma che
introduce quello che è il concetto di eguaglianza sostanziale ovvero partendo dal presupposto che non tutte le situazioni giuridiche sono i quali non tutte le condizioni e si trovano sullo stesso piano è compito della repubblica ecco l'inter il ruolo interventista dello stato è compito della repubblica quello di intervenire per rimuovere quelle diseguaglianze che precludono un'eguaglianza mera effettiva sostanziale e quindi è indispensabile un trattamento uguale a fronte di situazioni uguali diversificato a fronte di situazioni diverse per non incorrere in quelle che sono discriminazioni palesemente irragionevoli ecco che allora non solo le differenziazioni esistono ma vanno tutelate vanno
salvaguardate vanno trattate in modo diverso questa e l'eguaglianza vere effettiva sostanziale che rappresenta l'essenza della democraticità di uno stato e che garantisce assicura in maniera effettiva totale statis fattiva la tutela dei diritti
Related Videos

1:30:47
Lezione 2 - I tre poteri classici: A) Parl...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
5,290 views

11:31
Quanto dipende il nord dal sud - Presadire...
Rai
100,514 views
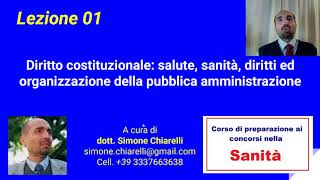
2:08:24
Sanità: diritto costituzionale e organizza...
Simone Chiarelli
7,436 views

52:07
Corso breve di Diritto costituzionale. Pri...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
57,865 views

47:09
La spiegazione di come funziona il Governo...
scrip
22,916 views

28:53
La Costituzione - Lezione n.11 - La formaz...
Keyeditore Tv
8,336 views

1:26:16
Lezione 5 - Le autonomie: b) Comuni
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
2,680 views

21:05
Istituzioni di Diritto privato (prof. Giov...
Università di Catania - webtv
38,351 views

1:57:03
La Costituzione Italiana. Commento articol...
TreccaniChannel
21,118 views

1:00:38
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - GUIDA COMPLE...
Formazione Diritto
194,051 views

45:38
Corso breve di diritto costituzionale. Non...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
9,874 views

1:31:12
Lezione 3 - Gli organi di Garanzia: Presid...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
3,411 views

23:08
La Costituzione - Lezione n.14 - La Magist...
Keyeditore Tv
12,620 views

16:11
Trasparenza e diritto di accesso atti : ...
Formazione Diritto
77,195 views
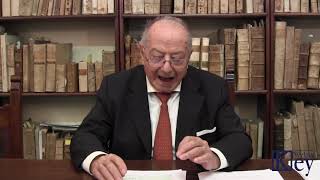
24:44
La Costituzione - Lezione n.5 - I Diritti ...
Keyeditore Tv
16,278 views

1:30:55
Lezione 4 - Le autonomie: a) Regioni e Pro...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
5,727 views

49:13
Corso breve di Diritto costituzionale. Ter...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
16,627 views

1:01:18
Greatest Italian Songs - Bella Vita Italia...
ARBI NORA
9,233,565 views
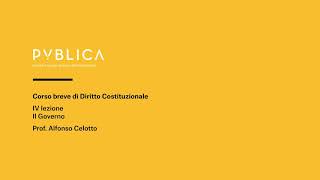
51:46
Corso breve di Diritto costituzionale. Qua...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
18,464 views

16:59
La Costituzione - Lezione n.1
Keyeditore Tv
21,383 views