Platone - Luciano Canfora
21.06k views8690 WordsCopy TextShare

Luciano Canfora Podcast
Canale creato da Luca Baldanza
Video Transcript:
Si è dunque intanto, parliamo di un personaggio di famiglia nobilissima: Platone. Famiglia legata anche agli ambienti molto critici verso la città, il funzionamento della città retta da un’assemblea popolare teoricamente onnipotente. Ma anche qui ci sarebbe da fare qualche distinzione, perché è vero che l’assemblea popolare aveva una forza decisionale indiscutibile, però è altrettanto vero che le grandi famiglie – visto che usiamo questo termine, ed è bene recuperarlo – le grandi famiglie, le grandi stirpi, gli altri "nidi", per esempio, di cui era Pericle un esponente, ma prima di lui Clistene e dopo di lui Alcibiade, contavano
moltissimo, guidavano la democrazia ed erano spesso insofferenti verso il controllo popolare. Quindi c’era questa situazione curiosa di un equilibrio: alcune famiglie, alcuni gruppi si tiravano fuori. No, per esempio, lo zio di Platone, passato alla storia come un personaggio negativo, Crizia si chiamava, era uno scolaro di Socrate anche lui ed è colui che ha guidato l'esperienza di governo dei cosiddetti trenta tiranni, parola abbastanza logora ma che vuol dire, insomma, un governo dispotico, un governo molto oligarchico, restrittivo, che restringe il numero dei cittadini. Platone viene da quel mondo lì ed è al tempo stesso, diciamo, ritenuto, non
a torto, colui che ha lanciato nel pensiero filosofico mondiale la prospettiva comunistica: la comunità, la comunione non soltanto dei beni, ma addirittura dei rapporti affettivi, la dissoluzione dell'istituto familiare e una dominanza sulla società di un’élite reclutata non sulla base del censo o della capacità guerriera, ma del sapere filosofico. Quindi, i filosofi al potere, che non è un'idea sbagliatissima, potrebbe avere anche dei puri esiti; non si sa mai, insomma, andate le tante esperienze che facciamo, anche questa potrebbe essere messa alla prova. E quindi si coniugano in lui una critica radicale del meccanismo cittadino e una prospettiva
molto aristocratica. Come mai queste due cose vanno insieme? Ma credo che sia giusto dire, anche se non è sempre gradita come diagnosi, che la democrazia ateniese è in realtà un regime ristretto: condizione per essere cittadino di pieno diritto significa essere ateniese di padre e di madre non legge; la introdusse proprio Pericle, fra l'altro: maschio, di età adulta e di capacità militari. Quindi c’è questa identificazione cittadino-guerriero. Per giunta, la città vive e può prosperare anche le persone meno abbienti, perché c'è l'impero e quindi gli alleati, che sono di fatto dei sudditi, versano un tributo che consente,
diciamo così, uno stato sociale che funziona. Allora gli oligarchi criticano questa visione restrittiva della società e additano anche alcuni di loro la radicale esclusione da tutto, dalla vita pubblica in ogni sua manifestazione, del gruppo, chiamiamolo sociale, delle donne. Quindi la democrazia ateniese è molto escludente: esclude anche metà, diciamo, del genere umano, cioè l’universo femminile. Curiosa situazione a Sparta, che è l'antagonista tradizionale, che si considera capofila delle oligarchie, a torto o a ragione, ha invece una gestione diversa per il prestigio sociale delle donne. A Sparta è molto elevato: non fanno parte di organismi decisionali, certamente, però
contano molto, e questo è ampiamente documentato nella tradizione letteraria. Nella scuola filosofica di Platone, in particolare, c'è una presenza femminile, cosa paradossale, potremmo dire, rispetto a una consuetudine di esclusione assoluta, tranne che per donne considerate libere di costumi, per lo più non ateniesi di nascita. Paradosso dei paradossi: il grande Pericle, che certamente è stato un politico consumatissimo, bravissimo, abile, capace di dominare l'assemblea popolare di guidarla, abbandona la sua moglie ateniese e si unisce a una donna di Mileto, Aspasia. Ed era quindi costumi completamente liberi rispetto alla castigatezza umbratile della donna ateniese, che è una non
persona. Da questa donna ha un figlio che si chiama, che lui, Pericle, per ottenere che quest'uomo, questo ragazzo, abbia la cittadinanza ateniese, pur non essendo figlio di una donna ateniese, lui implora l’assemblea, implora l’istituzione, in quel caso il tribunale che deve concedere, ed è lui che ha emanato la legge restrittiva della cittadinanza ai puri ateniesi. Insomma, un personaggio contraddittorio, Platone lancia questa idea e ora, noi sappiamo, non voglio farla lunga, ma è bene ricordarlo: che un'idea è stata interpretata anche in modo molto ostile. Il comunismo platonico e Marx, per esempio, in una pagina, in una
nota del "Capitale", del suo grande libro "Das Kapital", per incidere, se ne parla e dice: ma la Repubblica di Platone con quella sua struttura piramidale è il sistema delle caste egiziane trapiantato ad Atene, quindi non ha nulla a che fare col comunismo. Un'altra critica, molto più vicina nel tempo, Platone l'ha subita dal suo più intelligente e più capace allievo, cioè Aristotele. Aristotele non era un ateniese, era un macedone, era figlio del medico personale di Filippo di Macedonia e maestro, per un po' di tempo, di Alessandro Magno. Insomma, era radicato nella grande monarchia macedone, che diventerà
poi, alla fine del IV secolo, egemone su tutta la Grecia. Aristotele è stato vent'anni scolaro di Platone, ha avuto l'amarezza di non succedere a lui a capo della scuola, per cui, per protesta, se ne va e fonda un'altra scuola, il Liceo. Quando gli è consentito di tornare in Atene, dopo varie vicende politiche, in questa sua attività didattica, mi fate i corsi, per esempio, di politica, per esempio, della retorica, di scienze: un uomo poliedrico, leonardesco potremmo dire. In queste lezioni di politica, lui dedica un intero libro e secondo libro ad attaccare Platone su quel punto: sul
comunismo dei beni e delle donne. Qual è l'argomento che lui porta? Aristotele vive alla fine del IV secolo, muore l’anno dopo Alessandro Magno, nel 322. È un argomento, può, modesto tutto sommato, perché lui dice: bene, non ci sarà una famiglia e quindi i giovani fanciulli debbono essere considerati – questo chiede Platone nel, o meglio, Socrate nel quinto libro – Platone dà sempre la parola a Socrate nei dialoghi: figli di tutti gli anziani, cioè riconosceranno come genitori, come padre, come madre, tutti coloro che sono anziani. Benedice Aristotele con un argomento un pochino restrittivo. E allora, il
pericolo di incesto sarebbe a portata di mano perché il genitore vero, diciamo, non è più riconoscibile, in quanto da subito i fanciulli vengono allontanati dalla famiglia ed educati tutti insieme. Potrebbe incorrere in questo incontro l'imbarazzante argomento, così di buon senso, ma che comunque non va alla radice della questione. Molto prima di Aristotele, però, c'è questa trovata platonica che doveva aver fatto chiasso. Altro Aristotele dice: Platone è l'unico che ha pensato a una cosa del genere; l'unico che ha una notizia preziosa e, in un certo senso, perché ci aiuta a capire che, quando un comico, per
così dire, estremamente pungente, Aristofane, sferra una commedia, "Le donne all'assemblea popolare", contro l'utopia della comunione dei beni e per le donne, ce l'ha con Platone. Chiaramente si può dimostrare che è il bersaglio; d'altra parte, questi uomini vivevano dentro una scuola, l'Accademia, facevano lezione, dialogavano, però il loro pensiero circolava, fuoriusciva. Aristotele e Aristofane mettono in scena una commedia, a mio avviso geniale, che si apre con un colpo di stato: colpo di stato delle donne, le quali, come ho detto all'inizio, non sono cittadine pleno iure, sono delle non persone, non vanno all'assemblea, non decidono nulla, escono di
casa solo quando escono delle processioni. In quell'occasione può succedere anche qualcosa. Per la prima orazione di Lisia, che noi abbiamo sulla uccisione di Eratostene, di un tale che si chiama Eratostene, racconta una vicenda privata, cioè un adulterio, diciamo, di una signora ateniese che era incappata, diciamo, in questa passione per un estraneo, in occasione di una processione. Quindi la processione era stato l'unico momento in cui era uscita di casa; aveva visto questo tale, il quale viene ammazzato dal marito cosiddetto legittimo, che sorprende quest'uomo in casa, e si difende dinanzi a un tribunale giustificando con argomenti che
i giudici hanno accettato, senza almeno il dubbio, come buoni per aver fatto questo crimine. Decidono così di uccidere una persona. Nella realtà ateniese, immaginate che le donne prendono il potere, vanno all'alba all'assemblea, quando ancora gli altri buoni ateniesi non si sono recati lì perché si alzano un po' tardi; hanno messo delle barbe finte, quindi si sono camuffati più o meno da uomini. In realtà, sulla scena doveva essere curioso perché non esistevano attrici, erano solo attori, quindi comunque le parti femminili le facevano degli uomini. In questo caso sono uomini che sono donne, ma si travestono da
uomini. Insomma, la finzione scenica aiutava; un po' gli ateniesi si divertivano. E loro sono lì, in maggioranza, perché se l'anti sono tutte presenti ad Atene, c'era un assenteismo sempre a livello popolare fortissimo. E loro, dirigente, leader, che si chiama Prassagora, lancia un programma, lo fa approvare; loro sono maggioranza, quindi lo approvano, e da quel momento in avanti c'è la comunione di tutti i peni e dell'eros. E qui Aristofane colpisce nel punto debole la costituzione platonica che, se ben ci riflettiamo, è maschilistica; cioè comunanza di tutte le donne vuol dire che la satrapia, allora, Aristofane la
capovolge, per cui le donne hanno il diritto di avere eros con qualunque, o anzi, c'è una graduatoria: prima le persone anziane, poi via via le giovani, e questo determina una situazione particolarmente, come dire, curiosa. Al termine della commedia, però, con questo non è soltanto dileggio verso il filosofo, pista che l'ha detta grossa; e quindi, davanti al pubblico, lo mettiamo alla berlina. C'è un elemento, secondo me, notevole: Aristofane ha fatto di Prassagora, che è il leader delle donne che hanno preso il potere, un'eroina, una persona eroica, dalle idee lucide, che tratteggia un programma avveniristico di grande
respiro, poi si scontra con la realtà. Per esempio, una delle scene più note di questa commedia è quando bisogna portare i propri beni all'ammasso, tutti insieme, e qualcuno esita e dice: "Ma va!", il primato, insomma, come dire, lo spirito di civismo collettivistico non nasce tanto. E alla fine, però, c'è il passo comune, nel pasto comune sono tutti presenti e corrono a raggiungere la postazione necessaria. Quindi c'è ironia sul meccanismo, ma apprezzamento per il coraggio di una donna, che è l'unico personaggio positivo in tutta la commedia. Allora, l'esclusione femminile che Platone ha ritenuto di superare in
quel modo, Aristofane la mette a fuoco. Perché? Perché risente molto della critica aristocratica alla grettezza, alla chiusura della democrazia ateniese. Perciò, "Donne all'assemblea popolare", il titolo in greco, vuol dire esattamente questo, ed è già un pugno nello stomaco per l'ateniese medio, perché l'assemblea popolare è il regno degli uomini e basta. Quindi Aristofane supera Platone in questo, anche se poi la sua ironia nei confronti dei corpi femminili vecchi non è lo sguardo proprio femminista, diciamo. Comunque è vero che mette, ma c'è un forse anche l'intento di rifiutare un certo cliché. Quindi, come dire, io ho una
grande simpatia per questo autore comico, che tutti i 39 se fosse soltanto un buffone o poco più. E invece è un politico fine, è un politico che in alcuni casi si è anche compromesso politicamente; per certi anni parrebbe essere uscito di scena. No, questa commedia è una delle ultime sue; no, lui ha cominciato giovanissimo, a 20 anni, un ragazzo come un enfant prodige, e mandava un altro a fare da regista; lui scriveva il testo, poi ha fatto il regista intensamente per vent'anni, dal 426 al 405. Poi, dopo la guerra civile ateniese, c'è un vuoto. Quindi,
cosa ha fatto negli anni, nell'anno della guerra civile? Dove è finito? Riemerge negli anni '90 e lì se la prende con Platone. È anche interessante che questa fu una grande contesa culturale e politica fra Platone e Aristofane riguardi la famiglia in qualche modo. No, che cosa ci dice? Intanto Platone si è divertito a mettere Aristofane in un dialogo, nel Simposio; gli fa dire delle cose un po’ stravaganti. Noi non sappiamo le date dei dialoghi platonici, praticamente non le sappiamo per nessuno; il suo dialogo, ma può essere che Aristofane… Non fosse più in vita quando lui
ha scritto e diffuso il Simposio, però lo fa apparire anche in un'altra occasione, nell'Apologia di Socrate, perché Socrate, uomo complicato di cui Platone si fa portavoce, non ci dimentichiamo che Aristofane ha attaccato Socrate in maniera durissima nel 423 con Le nuvole, in cui lo ha messo alla berlina. E quando Socrate viene messo sotto processo nel 399 con un'accusa assurda di ateismo e di corruzione della gioventù, di fatto perché era amico di Crizia, di questi che avevano preso il potere durante l'oligarchia, Platone fa pronunciare: "Abbiamo questo testo che riflette forse quello che Socrate disse veramente". Una
frase: "Il mio primo accusatore fu Aristofane con la commedia Le nuvole". Per Platone, un problema. C'è una differenza tra i due, singolarissima su tanti piani, uno dei quali è quello familiare, perché, come ho detto prima, a Platone appartiene all'elite più alta, l'aristocrazia più remota dell'Attica. Cristofari, chi era? Probabilmente era figlio di un contadino povero, potremmo dire. Lui ha una grande passione per i contadini, e l'unico centro di cui parla sempre bene nelle sue commedie richiama saggisti, saggissimo contro un debole. Perché dico questo? Perché nella prima commedia sua, che noi abbiamo, gli Acarnesi, lui dice scherzando,
fa dire a un protagonista ateniese: "Non regalate l'isola di Egina di fronte all'Attica, al nemico, agli Spartani, perché così gli Spartani vi rubano il vostro poeta". Allora la domanda è: come mai non è nato ad Atene? È nato a Egina! No, il padre evidentemente aveva avuto un piccolo lotto di terra essendo un ateniese povero. Lo stato sociale ateniese provvedeva a questo nelle località occupate, talvolta alleati, talvolta addirittura occupazione militare, piazzava i cosiddetti "hitler un chi", cioè detentori di un lotto di terra, e quindi lui deve essere stato lì da fanciullo e poi è tornato ad
Atene, è andato a scuola, ha imparato in fretta la musica, la metrica, no, per scrivere quelle commedie. Deve avere una grande competenza musicale, ma il padre era un contadino povero nella scala sociale, potremmo dire, agli antipodi rispetto all'aristocratico Platone. Anche questo funziona nei rapporti tra i due. Professore, posso chiedere perché la parola greca che restituisce il nucleo familiare e poi cos'oil co'? "So" in cosa? "Ho icos" richiama l'idea dell'abitare. "Oi" richiama quello che è, in certo modo, più che il legame di sangue o di parentela. Infatti, nello "icos" erano inclusi anche gli schiavi. Cioè, cosa
ci dice della famiglia nel contesto della società greca? Intanto stiamo parlando di una società povera nel senso anche materiale. Gli edifici? Una cosa curiosa: le carceri, per esempio, perché ad Atene di colui che evade dal carcere si dice che "tolgo rue" fosse quello che fa un buco nel muro, perché era piuttosto facile farlo, talmente l'edificio era inconsistente e arrangiato. Certo, alcune dimore erano un po' più lussuose. L'uomo più ricco di Atene era un tale che è morto in malo modo nella campagna in Sicilia contro Siracusa; si chiamava Nicia, aveva l'appalto delle miniere d'argento. Le Lauree
on e temeva sempre che la gente per la strada gli chiedesse se avesse qualche soldo, quindi andava per vie nascoste all'assemblea. Certo, i monumenti: il Partenone, il Partenone cominciato da Cimone, racconti della proseguito Pericle, l'architetto direttore dei lavori, e Rafidia, grande artista, anche grande profittatore di quattrini, per cui ha avuto un processo. Però è una società povera, si mangia pochissimo la carne; la carne si mangia quando ci sono le feste, si ammazzano gli animali. E quindi anche, diciamo, il povero che non ha uno status sociale particolarmente dovizioso mangia questo cibo non usuale. Di solito, mangiano
un'ottima dieta; per contro, dal tedesco de Rose, peraltro, si difendono da questo malanno tipico delle società opulente, e però anche nella casa di un povero c'è almeno uno schiavo. Questo lo sappiamo sempre da quello oratore lì, si sa che ho nominato poco fa, e lui era un siciliano, quindi non era un ateniese, non poteva fare il cittadino. Suo padre era molto ricco, si chiamava Cefalo, era anche un amico di Socrate, fabbricanti di armi, una grande casa al Pireo. Poi, durante la guerra civile, ha perso tutto, è stato, perché Meteco, i 30 si sono avventati sui
mitici. Allora ha fatto l'avvocato, scriveva cause per altri e abbiamo di lui una trentina di discorsi, molto interessanti, alcuni politici, va bene; ma molto interessanti anche quelli che riguardano la vita comune, la vita normale, cause private, cause di eredità, contestazioni interfamiliari. E a un certo punto, lui fa parlare, o meglio scrive, per cliente che poi avrà recitato su discorso davanti ai giudici, e dice: "Ad Atene non c'è nessuno così povero che non abbia almeno uno schiavo". Nel "Pluto", che è una commedia, l'ultima in ordine di tempo di Aristofane, sappiamo l'anno esatto: il 388, quindi parecchio
avanti nel IV secolo. La commedia si chiama così perché la ricchezza, Atene ha perso l'impero quando ha perso la guerra, e quindi la questione sociale è diventata bruciante. La lotta tra ricchi e poveri diventa quotidiana e Aristofane ha questa idea di mettere in scena l'iniquità di questa divinità, del "no", il Pluto, il dio della ricchezza che è cieco e quindi va nelle tasche di alcuni e non di altri, non vede. Il protagonista cerca, con una serie di episodi più o meno divertenti, di snebbiare, cioè di ottenere giustizia, ed è seguito da uno schiavo. Lui è
l'emblema dell'uomo povero, il protagonista del "Pluto" dice allo schiavo: "Tu sei più fedele tra i miei schiavi, 12, forse più di due". Questo ci aiuta a capire che avere uno schiavo era proprio il minimo dello status symbol della Atene e poi c'erano quelli che ne avevano infinita. Naturalmente questo cosa ci aiuta a capire? Che in una società schiavistica la base sottostante, che non si vede, perché lo schiavo, come la donna, è una non persona, è il vero fondamento della ricchezza. Dei numeri, anche più o meno contestati, delle cifre, l'unico censimento fatto ad Atene, di cui
abbiamo notizia, fu fatto alla fine del IV secolo, nel 316, probabilmente quindi poco dopo la morte di Aristotele. Le cifre che abbiamo sono sconcertanti, ma io ho sempre pensato che siano verifiche; molti studiosi non lo pensano così. Ventimila cittadini di pieno diritto, ventimila però rinviano a un nucleo familiare, quindi c'è una moglie e magari dei figli minori. Il numero ventimila va moltiplicato grossomodo per tre: diecimila stranieri, "meteci", si vuol dire uno che abita in Atene ma non è cittadino, che spesso fanno mestieri importantissimi nei commerci e possono anche diventare molto ricchi, come il padre di
Lisia; e quattrocentomila schiavi, una cifra spaventosa. Alcuni studiosi si è discusso tante volte di questo, mi hanno obiettato: "E chi gli dava da mangiare? Tenere in vita quattrocentomila persone?". Ma la risposta, purtroppo, è dolorosa: cioè non era la priorità. Se muore uno schiavo, ce n'è un altro; fra l'altro, gli schiavi sono di solito prigionieri di guerra oppure comprati al mercato degli schiavi, che è una delle ragioni per cui queste società antiche sono sempre in guerra, perché lo strumento per avere schiavi è la guerra. Tutto sommato, la pace è un concetto a tempo, un concetto intermittente.
No, la parola che in greco significa "pace" significa anche "guerra", "tregua": cioè la pace non dura sine die, si programma che deve durare tot anni e magari ben prima si interrompe, perché la guerra è il veicolo della ricchezza principale. La manodopera sente. A professare, prima di riprendere il discorso assoluto, via che attraversa poi secoli, ci porta avanti. Facciamo una breve parentesi sulla condizione della donna nella società romana; le ha detto, appunto, nella società greca è una non persona. Quindi c'è un in serio lizzano: Grecate riesce perché già si faccia un po' diverso. Certi, società ateniese,
peraltro, lei prima parlava del delitto d'onore. Nome, viene da pensare che ci sono delle cose, sono rimaste: la punibilità dell'adulterio femminile e la liceità dell'adulterio maschile, che naturalmente era riconosciuto, anzi direi accentuato anche dalla presenza della schiavitù, infatti in casa perché era un diritto del padrone. Dove ci siamo liberati di questo, in Italia, nel 1969. Visto in prospettiva è come dire ieri, perché noi fino al '69 abbiamo avuto la punibilità del... tutte le famiglie erano di quello maschile. Poi, grazie a Dio, alla Corte Costituzionale è intervenuta; ma a Roma la situazione della donna un pochino
migliora, un po' premio nel vento; diversa e molto simile è stato detto tante volte alla situazione spartana, nel senso che il prestigio sociale delle matrone, cioè delle donne che appartengono a famiglie che contano, è altissimo. Sono anche lo strumento di alleanze politiche: la figlia di Cesare sposa Pompeo, ma non perché si fosse invaghito di quest'uomo, peraltro sgradevole, ma perché è un'alleanza politica tra i due, di cui lei è il sigillo, in certo senso. Poi ci sono altre donne celebri, la cui presenza politica è visibile e documentata. Nel mondo romano, le matrone hanno una dote importante
e, se in certi momenti, il potere politico vuole metterci su le mani, reagiscono. Episodio famoso: nell'anno 43 a.C., l'anno terribile della repubblica romana, nasce il secondo triumvirato, che comincia a massacrare i nemici politici con le prescrizioni. Si deve preparare alla guerra contro i Cesari, CD, Bruto e Cassio, che se ne sono andati in Oriente e stanno reclutando truppe, legioni. Poi ci sarà la battaglia, anzi, nella guerra di Filippi, in cui vincono i triumviri e perdono i Cesari. Per la guerra hanno bisogno di quattrini; potremmo dire tassano le matrone, le quali scendono in piazza e impediscono
questo. Quindi hanno una forza politica esplicita, che viene anche riconosciuta. Insomma, il mondo romano, che è essenzialmente una repubblica aristocratica, anche se molti studiosi tendono a parlare di democrazia, data a Roma, ma non ha senso, è una repubblica aristocratica in cui c'è un contropotere, quello diciamo dei comizi, i tribuni della plebe, che sono detti magistrati in antitesi ai magistrati regolari, anche se poi le carriere si intrecciano. È però il sistema elettorale tale da consentire comunque la prevalenza dei ceti ricchi: cavalieri, senatori, e soprattutto l'organo più importante è il senato, che è un organo di cooptazione
non attraverso il cursus honorum. Chi ha fatto il questore può entrare in senato. Ecco, in questa repubblica aristocratica, come nel caso spartano, è la forza delle donne all'interno della struttura familiare che è molto rilevante. Forse anche perché, lo possiamo immaginare per quel poco che sappiamo su Roma, ha influito molto il modello, per esempio, di alcune città della Magna Grecia: Taranto era una colonia spartana, quindi aveva portato un pezzo, diciamo, di mentalità spartana nell'Italia meridionale, con cui Roma è entrata in contatto, è anche in guerra. L'Etruria, gli etruschi, di cui abbiamo tantissima documentazione visibile, ma molto
più difficile invece quella scritta, e ben quel che riusciamo a capire è una società non dico matriarcale, ma in cui le donne hanno un peso notevolissimo, una presenza notevolissima. Quindi Roma è un intreccio di questi elementi culturali di varia provenienza, mentre gli ateniesi si vantavano un po' scioccamente, il caso di dire, di essere autoctoni, la purezza della razza, che è uno dei concetti più balordi che si possano concepire. Loro se ne vantavano, però venivano anche presi in giro per questo; Aristofane si diverte molto su questa autoctonia, pseudo-concetto, come fa uno a essere nato per partenogenesi
da solo, evidentemente no. Quindi aveva ragione l'imperatore Claudio, uomo saggio, che quando suggerì in senato di aprire le porte del senato anche ai notabili della Gallia, Pomata, del nord della Gallia, non facciamo l'errore che hanno fatto gli ateniesi, che avevano un'idea così ristretta della cittadinanza, che alla fine decaddero, decaddero anche demograficamente. Noi romani abbiamo cominciato imbarcando tutti. Romolo ha imbarcato delinquenti, profughi da altre città. Quindi una città potente come Roma è una città nata dai profughi. Chiama oro migranti e li chiamavano profughi. Cento simili stavamo parlando dell'utopia; questa utopia del dissolvimento ha vissuto familiare nel
contesto. È un'utopia che ha attraversato i secoli. L'altro giorno ho scritto un intervento su Corriere della Sera e ci ho raccontato dell'utopia del francese Jean Fury, e che avrei preso. Questo è stato ripreso anche dal Manifesto, comprato Tommaso Campanella, ben prima di Campanella, del filosofo che era anche monaco. È quindi più interessante, e poi arrivammo a Marx. Lei ci ha spiegato che c'era anche qualche contraddizione in questa teoria. Poi le voglio fare una domanda sul perché queste utopie sono destinate, per poi, anche nel Novecento, anche nel lusso comunista, c'erano delle idealità sovversive sulla famiglia. Paul
Ginsborg dice due cose: che l'utopia si ferma sempre sulla soglia di casa. Dice sia nel fascismo italiano, sia nella Russia sovietica, sia nella Germania nazista, i totalitarismi trovarono poi una resistenza nelle reti solidali di fraternità e di resistenza che si creano all'interno delle famiglie. Quindi la famiglia è comunque una zona di resistenza rispetto anche a un progetto riformatore radicale. Una seconda questione, invece, di carattere personale: questi poi grandi utopisti, prendiamo Marx, che teorizzava grandi cose, poi nei comportamenti privati cadeva un po' nel bellizzi del peggior borghese, perché è stato un uomo infedele. È stato un
uomo, diciamo, estroverso; non ricevano un aggettivo molto espressivo. Quindi ecco, mi interessa la sua opinione su questo. Dunque, sul primo punto, ammiro molto Ginsborg, uomo fine, profondo conoscitore della nostra storia italiana. Fra l'altro, però, non sono tanto d'accordo su questo, tanto perché non esistono categorie generali, esistono storie dei singoli paesi. Immaginiamo la Russia zarista, che ha un'elite di europei, sì, ma scafata, che va in Germania a fare le terme, che scrive e parla francese, poi inglese. No, basta scorrere Tolstoj in Guerra e Pace, e l'aristocrazia parla francese; in Anna Karenina parla inglese. Quindi proprio apertissima.
E invece poi la base sociale maggioritaria è la profonda Russia della comunità contadina, molto più conservatrice, arcaica, eccetera, eccetera. Quindi già un paese non si può considerarlo nel suo insieme. Il bolscevismo, nel suo affermarsi, fu oltranzista su questo terreno; per esempio, instaurò una pratica della legislazione sul divorzio velocissima, per cui due persone non vanno d'accordo, benissimo, c'è un'entità più o meno giudiziaria che prende atto di questo: il matrimonio è sciolto. Quindi infrange catene ataviche. Al contrario, il fascismo italiano ha puntato molto sul tradizionalismo; Mussolini parlava spesso della ruralità. In rurali d'italiano, la ruralità comportava anche
una visione molto tradizionale della famiglia; incrementare le nascite, come dire, con strumenti incentivanti, anche economici. Al tempo stesso tira fuori, con l'organizzazione di massa, la donna e la porta alle manifestazioni pubbliche, per lo più ginniche. Il nazismo tedesco in questo è anch'esso molto specifico della tradizione tedesca, che non ha a che fare né con quella russa né con quella italiana. Quindi direi: la famiglia come luogo di resistenza non la vedo poi tanto convincente come teoria. Direi piuttosto, venendo ai secoli successivi al vecchio Platone, nel caso di un uomo a suo modo geniale come Tommaso Campanella.
Nella Città del Sole, lui riprende addirittura letteralmente alcune trovate platoniche, in modi anche comici. Per esempio, la sua proposta in questo libro, che è un racconto di viaggio, come sempre nelle utopie rinascimentali. No, anche l'utopia di Tommaso Moro, il racconto di un viaggio, è andato all'isola; l'isola dovrebbe essere Ceylon, quella che viene descritta dalla protagonista. E lì c'è un ordinamento meraviglioso: le donne sono in comune. Però stiamo attenti: per i filosofi ci vogliono delle donne molto gagliarde, perché i filosofi hanno una vita spirituale intensissima, ma fisicamente sono un po' fragili. Allora devono fare buona stirpe.
Invece per gli altri è meno importante. Di un comico assoluto, diciamo, quello che più colpisce è la serietà con cui vengono prospettate queste casistiche. Al nucleo, però, al di là di queste ingenuità, c'è una carica innovativa che ha fatto di lui un eretico. No, è stato ristretto. La Città del Sole l'ha scritta in carcere; il bravo molto vitale monaco calabrese, ma nell'epoca romantica che eredita anche la libertà di costumi del Settecento, XVIII secolo, è un secolo di massima libertà di costumi. Direi a 360 gradi. Il romanticismo supera questa forma, diciamo così, libertina settecentesca e mette
in scena invece una idealità nobilissima di amore libero, di infrangere dei limiti costringenti, le affinità elettive di Crete. E in certo senso tutta questa critica romantica, i giovanotti Marx ed Engels avevano meno di 30 anni quando hanno scritto il famoso manifesto, erano in rete anche di questa cultura. Quindi la critica della famiglia borghese, che si fonda sullo scambio delle mogli all'interno di un ceto che sfrutta poi le donne dei proletari, tutto questo c'è anche un elemento letterario alle spalle. Dopodiché, il compagno Marx ogni tanto ha fatto delle sciocchezze; non è stato salvato al compagno Ammazza,
ma è ricorrente sempre. Small cita alcune figure anche drammatiche. Una figura che è stata protagonista dell'emancipazione femminile durante la rivoluzione russa è stata Aleksandra Kollontai. Con la tesi, anche lei, è stata una figura importante, ma in esterna poi fu costretta, dopo aver teorizzato la parità femminile, i diritti di pari diritti. E cioè, trust ha dato pazientemente al ruolo dell'amante di Lenin, cadendo nel triangolo. La storia è piena di teorie di personaggi che utilizzavano cose giustissime e poi, nella vita privata, cadevano, diciamo, nei vizi peggiori della famiglia. Fortuna. E questo però, forse, si potrebbe... facciamo una
riflessione di carattere ecumenico. [Musica] È evidente che ci sono uno sviluppo della società in tutti i suoi aspetti, dei momenti di forte spinta, diciamo, 50 anni, 51 anni fa, il nostro mondo occidentale è pervaso da una sorta di rivoluzione culturale, chiamiamola così, diversa da paese a paese, con elementi comuni. Il '68 europeo in Germania aveva certe caratteristiche, in Italia altre, in Francia... Ancora, diverse però, il rinnovamento del costume fu allora propugnato con soluzioni estreme; le comuni sessantottesche fallirono nella quotidianità, diciamo, più modesta, ed era anche prevedibile. Ma senza queste grandi spinte, la società non si
muove. Quindi, con un occhio, diciamo, volterriano, mi riferisco a Cannes: dite no, che è sempre serafico, anche se gliele succedono di tutti i colori. Va detto che queste grandi febbri sono indispensabili per infrangere il costume stantio, e il nostro mondo universitario ne sa qualcosa. I vecchi baroni ebbero grande disagio dinanzi alla contestazione, che diceva anche delle cose troppo schematiche, elementari, talvolta assurde; però impararono a ridimensionarsi, e questo fu un grande risultato. Questa è, questa bellissima, e poi in quegli anni comincia anche nel nostro Paese tutta una serie di riforme della famiglia. Va prima; volevo raccontarlo.
È questo: una volta, Ermanno Olmi, che è stato un grandissimo regista di grande sensibilità e che ha saputo raccontare la società italiana, mi raccontò di aver registrato un documentario nel ’68, quando appunto veniva teorizzato il libero amore. Le comuni, per cui il proprio compagno poteva condividere degli amori con quante persone, un documentario, e andò dai leader dei movimenti, da questi ragazzi che avevano anche un aspetto molto, molto sicuro, barricadero; le barbe, lui i capelli lunghi, erano dei guerrieri. Allora sia il giusto che la mia compagna, che Francesca, condivideva con Giacomino, Ermanno Olmi, fatte a questa
cosa. Sia giusto, ma tu non ti dispiacerebbe essi un po’? E qui da questa tesoretto tracotante poi finivano in un pianto disperato. E lui ha registrato, come dire, la disperazione di questi leader che poi teorizzavano il libero amore, però soffrivano intimamente. Noi abbiamo fatto grande fatica per ottenere una parità di diritti dentro il nucleo familiare. Basti pensare che soltanto nel ’75 abbiamo avuto la riforma della famiglia che ha fissato pari diritti. Fino al ’75 esisteva un padrone della famiglia, il capofamiglia, che decideva dove doveva risiedere il nucleo familiare, che educazione dare sin dall’inizio. Ma abbiamo
dei ritardi enormi. Uno studioso che si è occupato di questo è stato Stefano Rodotà, e lui notava questo: che il diritto, pur riconoscendo marito e moglie, ha pari dignità all’interno della famiglia. Il diritto non parla mai di amore; cioè parla di solidarietà, parla di intesa, ma non parla mai di amore. Il diritto esclude l’amore dentro la famiglia, si doleva di questo. Sì, ma io che lui sia un dosi con sé, ma don rilevava come un atto sbagliato che il diritto non accogliesse il sentimento amoroso. Grande simpatia e B per Rodotà, da vivo, e lo considero
un giurista illuminato, ma su questo punto lo seguirei poco perché non è un terreno sul quale si possa legiferare. Legiferare sui sentimenti personali non ha nessun senso; essi si sprigionano se c'è spazio; se non si sprigionano, come si possono disciplinare? Questo è vero, però non citare la parola amore significa non riconoscere il sentimento amoroso dentro il matrimonio, dentro alla famiglia; cioè rimanere soltanto sul piano del contratto e non mancare di rigore. Esso è un contratto, contratto ferito. Per fortuna, il Signore sancisce anche quella parità che, così a lungo, fu calpestata secondo il modello jus vitae
et necis del pater familias romano, che aveva proprio il diritto di mandare a morte un figlio se riteneva che avesse errato. No, quindi un pater familias onnipotente. E di cammino se n’è fatto. Per fortuna, le leggi registrano questi cambiamenti o addirittura li sanciscono. Sempre Rodotà, nel rilevare un certo ritardo italiano nel conquistare alcuni diritti, pensiamo anche al divorzio e alla battaglia sul divorzio, miracolate gli anni ’70, la battaglia per farla porto, differiva questi ritardi a due culture differenti, ma complici una sorta di resistenza morale, mettiamola così: la cultura cattolica ma anche la cultura comunista. Ma
c’è di più. Mi viene in mente una cosa che mi ha sempre fatto un po' ridere, cioè che nella cosiddetta Costituzione americana, che poi non si dovrebbe neanche chiamare così perché è un insieme di… c'è il diritto alla felicità, fa un po’ sorridere perché avrebbe detto Agostino di Ippona che questa felicità vive in interiore homine, non si può decretarla. Va bene, quindi ripeto, sarà una visione della mia meno illuminata di quella di Rodotà, il quale aveva una forte antipatia per i punti in comune tra mondo cattolico e mondo comunista, mentre io penso che quello sia
stato un incontro salutare per la nostra Repubblica. Va bene, quindi il fatto che avessero dei terreni in cui si incontravano nella costituente, si incontrarono e diedero il meglio di sé, lo vedo come una delle tappe positive della nostra storia, questa sicuramente. Però, sul tema, presentano del divorzio, ci furono indubbiamente, direi, cartucce, un’aneddotica interminabile del PCI. Possiamo rievocare, non ne abbiamo parlato, credo, episodio sicuramente storico accaduto che denota che cosa: la difficoltà a sintonizzarsi con una tematica del genere, ancora una volta in una realtà come quella per esempio italiana. Però non è soltanto nostra [Musica], così
diversificata da un capo all'altro della penisola, per cui davvero è un Paese, il nostro, interessante per mille motivi ma poco unitario, perché ha tante storie, tanta storia pregressa, quindi costumi diversi che non si sono amalgamati. Faticosamente lo fanno le generazioni nuove; sono molto più veloci nel socializzare costumi che vengono dalle tradizioni diverse. Ma se ci trapiantiamo nel 1973-74, quando si fece referendum per difendere la legge Fortuna di Loris Fortuna che aveva introdotto il divorzio in Italia, dopo attese interminabili da parte cattolica, parte il referendum abrogativo della legge Fortuna. Stiamo parlando di molti anni addietro, ma
insomma l’impressione di una certa età se lo ricordano. E quindi la battaglia fu di difendere una legge che rischiava di essere travolta in nome di un tradizionalismo cattolico molto oscurantista. Curiosamente, l’alfiere della lotta contro la legge Fortuna fu Amintore Fanfani, che era a suo modo un dirigente democristiano, che voleva far passare per essere moderno, eccetera. Ed era un… quel caso. Vede il peggio di sé. Non voglio neanche rievocare le cose indicibili che le diceva nei suoi comizi; invece, voglio rievocare quello che capitò a Berlinguer. Enrico Berlinguer era un uomo sottile e raffinato, tenace e battaglioso.
Italia, da Bolzano a Caltanissetta, non per fare comizi, spiegare, eccetera. E si narra, e credo che sia una narrazione autentica, che in un comizio in Sicilia, in un paesino, lui si sforza di spiegare l'importanza di questa conquista civile, rievocando elementi storici. Un compagno chiede la parola e dice: "Compagno segretario, se il partito mi ordina di divorziare, obbedisco." Non aveva capito niente. Questo è un po' una fotografia del nostro paese, perché oggi più che mai c'è bisogno di comprendere la storia e, soprattutto, cosa possono insegnare i classici all'uomo di oggi. Domanda cosmica? Va bene, non è
mai legittima, assolutamente legittima. Intanto cerco sempre di dire, anche se può sembrare pedantesco, che io li chiamerei sempre "antichi", perché "classico" è una parola un pochino respingente; non indica qualcosa che resta molto in alto rispetto a tutto il resto. Gli antichi che parlano scrivevano e parlavano le due lingue diffuse nel Mediterraneo per tanti secoli, il greco e il latino, hanno dato avvio di reja a l'insieme delle attività dell'intelletto, per dire, dalla geometria alla ricerca naturale, dalla poesia, alla riflessione filosofica, al racconto dei fatti storici, all'archivistica. Hanno avviato tantissime attività il cui seguito è la storia
successiva. Quindi, il punto d'avvio è quello. Ora, questo non basta a dire che dobbiamo ciclicamente andarli a visitare, perché sennò ci dimentichiamo il nostro punto di partenza. La cosa interessante è che fu ed è la mia risposta, e magari diversa da quella di tantissimi altri bellissimi studiosi, la ragione per la quale è un mondo vivo, vivente, che ci interroga; è la sua profonda conflittualità. Il fatto che in quella realtà i nostri dilemmi, che non riusciamo a risolvere se non provvisoriamente, erano già presenti in forma di dilemmi lancinanti. E allora, l'utilità del dialogare con loro significa
affrontare i nostri stessi problemi, magari con risposte tutt'altro che banali. Esagero, ma insomma, la pagina introduttiva di Einstein al "De Rerum Natura" di Lucrezio. Lucrezio, grande scienziato che ha scritto in esametri un poema scientifico, grosso modo traducendo e mettendo in versi un trattato sulla natura di Epicuro. Una parte di esso, naturalmente, alla base c'è la visione atomistica della realtà: tutta la realtà è fatta di atomi. Anche gli odori sono atomi. Una visione molto lungimirante, ma anche molto grossolana, nel senso che questi atomi sembrano quasi delle pallottole. Noi siamo in un'epoca in cui l'atomo si è
dissolto. Einstein scrive un'introduzione, 1922-23, alla traduzione tedesca fatta da un grande scienziato, German Denis, in cui dice tutta la sua simpatia per un uomo che aveva capito, dice Einstein, che la realtà è tutta spiegabile in termini razionali e scientifici, anche quella parte che non abbiamo ancora capito, ma che ci sforziamo di capire. Al tempo stesso considera arretratissima la visione primitiva dell'atomo che è nel poema di Lucrezio. Ecco, questo è un esempio concreto di dialogo fra un grandissimo pensatore, prima ancora che fisico del ventesimo secolo, con un testo dell'età di Cicerone, perché Lucrezio era un po'
più giovane di Cicerone. Bene, la mia risposta provvisoria è questa: "Professore, lei attinge a serbatoi di sapere dove io non arriverò mai." Quindi faccio una domanda che sicuramente è off topic, se non che così per miracolo qui dentro. Ma è un mio problema: Glossy o da Cuma? Che è stato? Io non so se al pubblico presente interessi, ma io ho bisogno di sapere una cosa: lei sa se si è suicidato o se è stato assassinato dai romani a Bergamo? Intanto i giornali dell'epoca non sono conservati. Però, a parte questo, prima di dare un tentativo di
conato di risposta, bisogna dire una parola e mettere su chi fosse costui. Va bene? Per me è un personaggio straordinario e vero filosofo, filosofo Tommaso, frequentatore del pensiero storico. Dopo Aristotele, ci sono due grandi correnti, fra loro molto lontane: quella che fa capo a Epicuro e quella degli storici, Zenone, Cleante, Crisippo, eccetera. Di solito si considera lo stoicismo la filosofia delle classi dirigenti. No, Catone Uticense era seguace, Bruto il Cesari cita Epicuro. Banalmente, si dice ha predicato il ritirarsi dalla politica nel vivere nascosto. Novate di Osas sono schemi un po’ approssimativi. Molti storici si sono
impegnati, almeno sul piano ideologico, per cause di libertà di tutti, a cominciare, potremmo dire, dalla lettera celebre di Seneca sulla indiscriminazione fra il libero e lo schiavo. Quindi, si mette in discussione il fondamento stesso della società antica. Epicurei che si sono impegnati nella politica lasciandoci la pelle, altrettanto rilevanti quanto gli storici che hanno predicato il cosmopolitismo. Siamo cittadini del mondo. Su questo terreno addirittura si incontrano con gli epicurei in tale che si chiama Diogene di Eno, il quale ha lasciato dei testi in cui si dice: "La terra è divisa in azioni, ma è una finzione,
perché siamo tutti abitanti di un'unica casa." Oi, cos'è questa unica casa? È la terra. L'occhio è amico, strettissimo collaboratore, consigliere di Tiberio Gracco. Siamo nel 133 avanti Cristo. Tiberio Gracco non è un rivoluzionario, è un uomo che si pone un problema: i contadini d'Italia si sono impoveriti, non hanno neanche più una terra, come lui dice, dove dormire, che ci hanno invece gli animali, loro non ce l'hanno più. Allora, il latifondo romano, che ha messo le mani anche su l'ager pubblico, deve essere arginato. E l'ager pubblico deve essere suddiviso tra i contadini che non hanno terra.
È una riforma non eversiva, che però è molto malvista dal ceto senatorio, soprattutto quando Tiberio Gracco cerca di farsi rieleggere e comunque contesta l'azione dei tribuni della plebe venduti al Senato. Viene ammazzato. Scipione Nasica capeggia i senatori, spezzano i sedili del Senato e con questo strumento primitivo massacrano Tiberio Gracco. Dieci. Anni dopo, il fratello riprende la questione del 123, ma nell'attacco fisico contro Tiberio Gracco i suoi ci furono centinaia di morti. Non soltanto Tiberio si salvò; Bossio, che era stato un suo fedelissimo seguace, fu processato e, secondo Plutarco, alla domanda "Perché hai sempre seguito Tiberio?"
rispose: "È perché è un uomo giusto, e se lui avesse ingiunto di incendiare il Campidoglio, l'avrei fatto." Risposta provocatoria, naturalmente; però lui si salva nel senso che non era il cittadino romano, fra l'altro, quindi non era facilissimo processarlo. Doveva, ma agli antipodi del Mediterraneo, in Asia Minore, proprio nel 133, l'ultimo sovrano della dinastia degli Attalidi, Attalo III, aveva regalato alla Repubblica romana, al Senato e al popolo di Roma, il suo regno. Un'iniziativa che a noi pare un po' singolare, ma che si spiega con quel che accade dopo, cioè gli equilibri sociali all'interno di questo piccolo
regno di Pergamo, caratterizzato, peraltro, da una grandissima biblioteca (non la famosa biblioteca di Bergamo) erano tali da allarmare la dinastia regnante, per cui, appena i romani si accingono a prendere possesso di questa terra, scoppia una rivoluzione di schiavi e di cittadini liberi che si affiancano agli schiavi, uniti dal culto del Sole IX-XI. Si consideravano seguaci del culto solare. Bossio di Cuma sta con loro, come dire, le brigate internazionali di Spagna. Insomma, "Valli" perché lì si combatte per una causa giusta. Lei però m'ha chiesto come è morto. Credo che abbia fatto una brutta fine, visto che
i romani hanno fatto, come al solito, tabula rasa, come dice Tacito nell'Agricoltura, "dire a un capo dei Britanni, dove fanno il deserto, la chiamano pace." [Applauso] [Applauso] Mi stavo chiedendo se magari non rischiamo di leggere alcuni fenomeni in chiave borghese, appunto quando parliamo del rapporto, ad esempio, di Lenin con le sue due compagne. Non riesco a immaginarmi la reazione di Lenin se sente dire che il suo era un triangolo amoroso; sembra un po' strano associare triangolo amoroso a Lenin o parlare di diamante. Però lasciatemi, mi si chiarisca questa cosa. Se è presente un certo antisovietismo,
che mi sembra abbastanza diffuso ultimamente, volevo ricordare, anzi chiedere conferma, in questo senso. Cioè, una delle prime menzogne antisovietiche riguarda proprio la comunione dell'eros o delle donne, perché generalmente ci si riferisce alle donne quando si parla di comunione dell'eros, cioè durante (ma chiedo conferma) durante la collettivizzazione, che tanto forzata in realtà non fu, perché basta leggere "Terre vergini" di Shaw e Loco, ad esempio. Ecco, una delle menzogne che si diffondevano era che, se si fosse aderito alle fattorie collettive, alle cooperative, ai kolkhoz, ecco che allora si sarebbero messe in comune anche le donne. Grazie. Secondo
me, lei ha già dato la risposta alla sua domanda, perché la prima parte mi sembra del tutto leggibile. Legittimo dire, usiamo un linguaggio inappropriato, non proprio adatto al soggetto. Magari la si può pensare diversamente, ma nel secondo caso lei ha evocato un tipo di rappresentazione falsa della realtà e ha anche detto che è una rappresentazione falsa. Quindi io non posso che prendere atto del fatto che non so perché ha citato però "I dissodati" di Lino, il romanzo di Shaw e Loco, perché non solo è molto interessante, descrive in maniera realistica, per niente di tiriambica, l'operazione
della socializzazione delle terre, però non credo che abbia molto a che fare con la questione che lei ha posto. Per ogni modo la ringrazio, perché ha dato un contributo. Buonasera, professore. Io mi chiamo Corrado Marrocco, ho avuto il piacere di stringere la mano a pochi attimi fa e le ho detto che esercito come professione di notaio in questa provincia da oltre 40 anni. E ho la presunzione, mi perdoni, più che di fare una domanda, ne volevo fare un'altra, ma non c'è tempo di dare una risposta. Pensi un po' a una risposta alla prima domanda che
è stata fatta e che si richiama poco, il pochissimo, al dialogo che abbiamo fatto. Proprio fa. Qual è l'importanza della storia e dei classici per quanto riguarda la storia? Il discorso sarebbe lungo e mi sembra che si possa concludere. Possiamo stringere in questo: chi non conosce la storia passata, non capisce il presente e non sa organizzare il futuro. Per quanto riguarda i classici, però, un piccolo aneddoto personale che forse qualcuno che conosce, spero che tra tanta gente, qualcuno sia stata anche mia cliente, visto che c'è da 10 anni a Gorizia, ora a Monfalcone. Io sono
stato accusato nel 2007 di truffa aggravata e i giornali (non dico quali) hanno fatto grande sfoggio di articoli e di titoli a caratteri cubitali. Lei capisce: un notaio accusato di truffa aggravata. La storia dura da dieci anni; per andare in primo grado sono stato assolto, ovviamente, perché il fatto non sussiste; cioè, il morto non c'era. Ho rinunciato alla prescrizione, ho fatto tutto il cursus honorum. Rapido lo so, sono stato assolto anche così, con il parere favorevole del pubblico ministero. E le dirò, io che ho la licenza scientifica, purtroppo in una classica mi sento quasi analfabeta.
Con sapienza, le posso dire che mi ha sostenuto in questo periodo rileggere approfonditamente "L'apologia di Socrate" e il "Critone." Quando, sul "Critone," Socrate si massaggia la caviglia perché ha passato la notte in catene, e ha permesso di andare davanti ai giudici con l'orgoglio della persona innocente che mette sotto accusa un sistema. E di questo scriverò quando andrò in pensione, se esisterà ancora la libertà su internet, che si sta mettendo in discussione. Grazie. Grazie al notaio per la sua testimonianza. Vuole dire altro? Sopravvivano. La ringrazio. Mai mi viene in mente, è una cosa che le dico
un po' così scherzosamente: Denis Diderot è colui che ha creato l'Enciclopedia. Non solo si copre di quando pubblica il primo tomo nel 1751, viene arrestato perché la Chiesa ritiene che sia un libro pericolosissimo. E, ciclo di A, viene messo nella Bastiglia. Poi, in realtà... Madame de Pompadour intervenne in suo favore; questo però non subitissimo. Quando era lì dentro, si è dedicato alla polizia di Socrate. Quindi, legherò: inviterò un antenato di un certo peso. Io volevo chiedere: lei, a un certo punto, ha parlato degli scossoni che talvolta sono necessari per rimettere in moto una situazione di
stasio che si è incancrenita e stagnante. Ovviamente, io poi ho pensato all'idea di rivoluzione, anche se il passo è molto ampio tra uno scossone e una rivoluzione. Ma, secondo lei, alla luce delle varie rivoluzioni o momenti rivoluzionari che ci sono stati, qual è il momento in cui una rivoluzione si può dire conclusa? Cioè, i rivoluzionari instaurano una specie di stato d'eccezione in nome di una serie di ideali, di progetti, eccetera. A un certo punto però, il lavoro si dovrebbe dire concluso per installare una specie di nuova ordinarietà, una nuova normalità. Quindi, la domanda è: secondo
lei, o se lei ha trovato delle risposte nei suoi studi, in che momento come si può concludere una rivoluzione? Non è una piccolissima domanda; è, se vuole, la domanda di chiusura. Cercherò un'altra mezz'ora, non scantonare e non deludere questa questione così seria che lei pone. Poi ci porterebbe molto lontano; ci dovremmo raccontare un sacco di cose. Va bene, parto da due o tre esempi. Perché si chiedeva Tocqueville, al 1865 - 60, credo? Lui scrive "L'ansa in regime" e "La rivoluzione" è un'opera che è rimasta incompiuta. Però, è un grande libro. Dice perché la rivoluzione scoppiò
in Francia. Lui era un conservatore, tutt'altro che simpatizzante per la ghigliottina, per il '93, per Robespierre, per nulla. Lui dice una cosa molto acuta, cioè proprio perché il regime, visione di tipo feudale, era entrato in crisi nei rapporti sociali quotidiani, la situazione era matura affinché esplodesse. Ed è scoppiata proprio lì perché era il paese d'Europa dove il vecchio regime era più debole. Non è scoppiata in Prussia, men che meno in Austria; è scoppiata in Francia. E questo cosa spiega? Spiega che le rivoluzioni non si programmano, si producono. Alla Costituente, il nostro insigne Costituente, che si
chiamava Togliatti, provocato un po' nel dibattito, venivano accusati i comunisti di sfruttare la tribuna parlamentare per promuovere una rivoluzione vera e propria. E lui ebbe a dire una frase che mi è rimasta molto impressa studiando un po' queste cose: le rivoluzioni non le fanno i partiti; i partiti al più le dirigono, se ne sono capaci. Va bene, che è una diagnosi molto seria che rinvia allo stesso tipo di considerazioni. Considerato, quindi, che ci sono condizioni esclusive che non possono non produrre quel risultato. È la stessa situazione, potremmo dire, del 1917 a Pietroburgo, nel resto della
Russia, dove aver portato questo paese a una guerra assurda, armando i contadini per le masse militari dello zar, erano contadini col fucile in mano mandati allo sbaraglio in una guerra che a est era perdente. Ha creato le condizioni affinché i fucili venissero rivolti contro gli ufficiali, contro il potere. Ottobre '17 è il punto d'arrivo di un processo. La questione vera però è quella che le imponeva Levi, dice: perché non riusciamo a programmare quando comincia, quando dura e quando finisce? No, è impossibile, perché, diventando potere statuale, la rivoluzione diventa un'altra cosa: diventa costruzione di un ordine,
anche quando parte nella forma più radicalmente eversiva. Ma deve costruire un ordine. Quest'ordine crea conflitto; il conflitto crea un prodotto inedito. Questo prodotto inedito nessuno se l'aspettava e, a sua volta, ha un suo destino. Le grandi rivoluzioni del secolo ventesimo hanno avuto dei risultati sconcertanti, sia quella nell'estremo oriente sia quella nell'Europa orientale, cioè nella Russia. Ma lo storico non si allarma per questo; è abituato a sapere che va a finire così. Lo sa, solo che il conflitto si ripropone, perché la dinamica, in ultima analisi, che è stata, secondo me, alla base di queste crisi irresistibili
è la consapevolezza della necessità di una sempre maggiore uguaglianza e il disappunto, grave, perché essa viene calpestata. Però si ripropone la disuguaglianza anche nella situazione del nuovo potere e di lì la crisi. I filosofi che pensano che la storia finisca ad un certo momento sono fuori strada; la storia non finisce. Il conflitto si ripropone e ha alla base sempre il problema dell'uguaglianza umana. Grazie, professore. Mi sembra che abbiate fatto una bellissima riflessione di chiusura di questo incontro. E grazie. Il grido che ha seguito tutti. [Applauso]
Related Videos
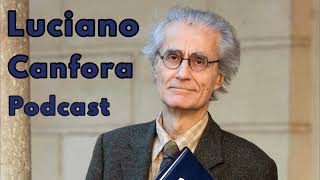
53:37
Ammiratore degli spartani - Luciano Canfora
Luciano Canfora Podcast
11,985 views
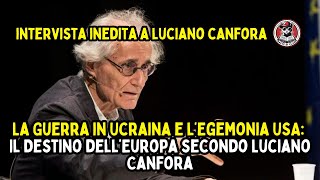
38:40
La Guerra in Ucraina, i BRICS e l’Egemonia...
Tracce Di Classe
39,899 views

4:34
"Revive Your Heart: A Spiritual Guide to S...
The book Capsule
5 views

1:12:16
Umberto Galimberti - In dialogo con Platon...
Filosofi lungo l'Oglio
57,333 views

1:04:49
DIEGO FUSARO: Platone spiegato ai Licei. I...
Diego Fusaro
13,786 views

1:36:09
Il FASCISMO e il COMUNISMO - raccontati da...
Circolo Metafisico
82,405 views

1:15:24
Gli imperatori - Luciano Canfora
Luciano Canfora Podcast
17,324 views

1:28:43
STORIA EUROPEA, di Luciano Canfora e Franc...
ScipioneTV
28,486 views

1:21:10
Gli dei si disinteressano - Luciano Canfora
Luciano Canfora Podcast
11,496 views

1:42:10
Inaugurazione XXXV Anno Accademico - Dizio...
Università dell'Età Libera - Pesaro
12,835 views
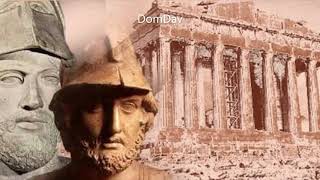
1:11:26
Pericle raccontato da Luciano Canfora
DomDav
66,655 views

1:14:57
Attica - Luciano Canfora
Luciano Canfora Podcast
8,320 views

1:46:03
REFLEX 2023 LUCIANO CANFORA
pubblivideotv
12,700 views

2:53:39
LUCIANO CANFORA - ARISTOFANE CONTRO SOCRATE
Circolo Metafisico
27,802 views

54:49
Guerra e schiavi nell’antichità con Lucian...
PiuLibriPiuLiberi
20,728 views

1:44:25
La presa della bastiglia - Luciano Canfora
Luciano Canfora Podcast
17,875 views
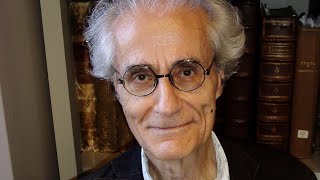
1:13:41
La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cr...
Club di Cultura Classica "Ezio Mancino" APS
32,879 views

1:35:41
Luciano Canfora e la crisi politica ateniese
Università del Piemonte Orientale
103,339 views
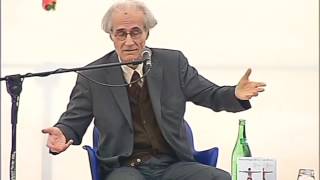
1:14:37
Luciano Canfora: "L' eterna lotta tra vero...
Dialoghi di Pistoia
128,662 views

37:34
MitiCu! - Lectio magistralis di LUCIANO CA...
GAL Terre Locridee WEB TV
5,426 views